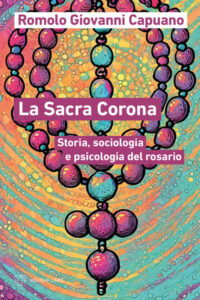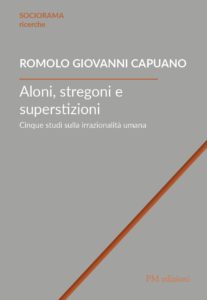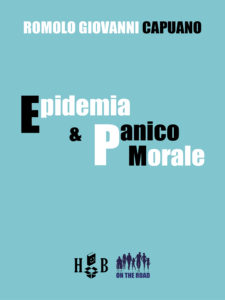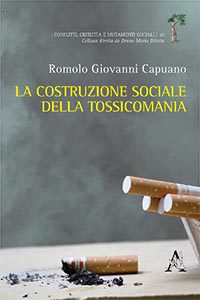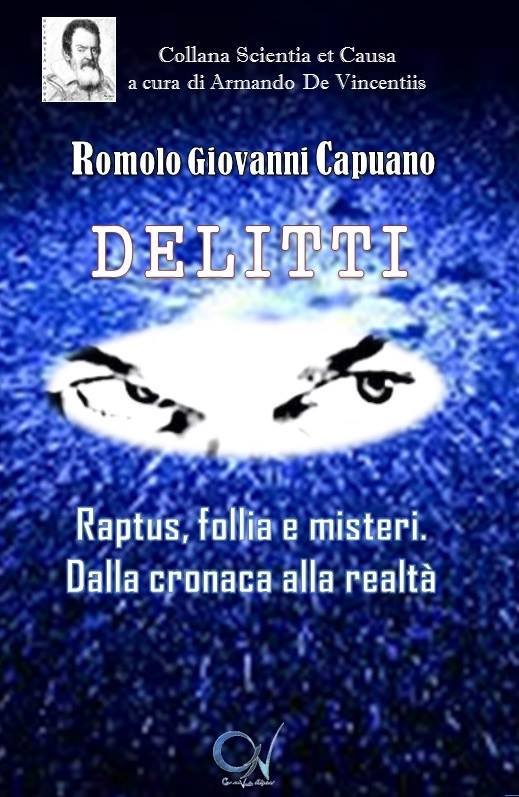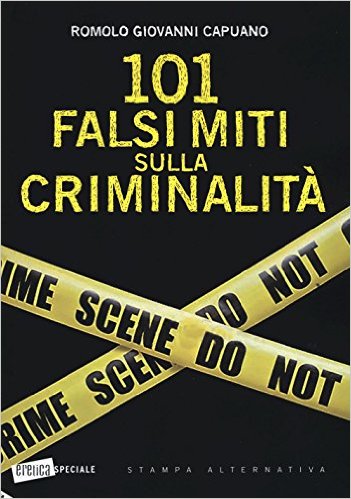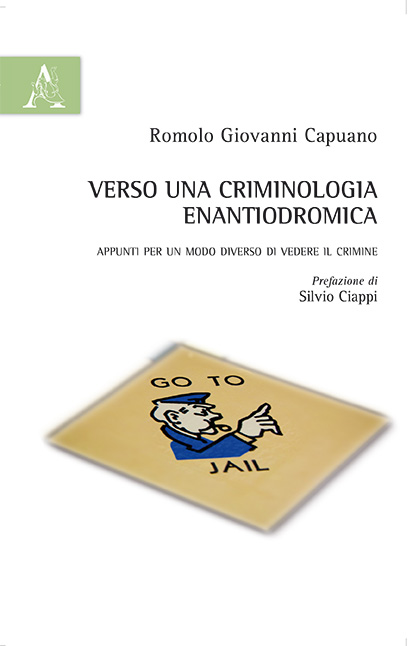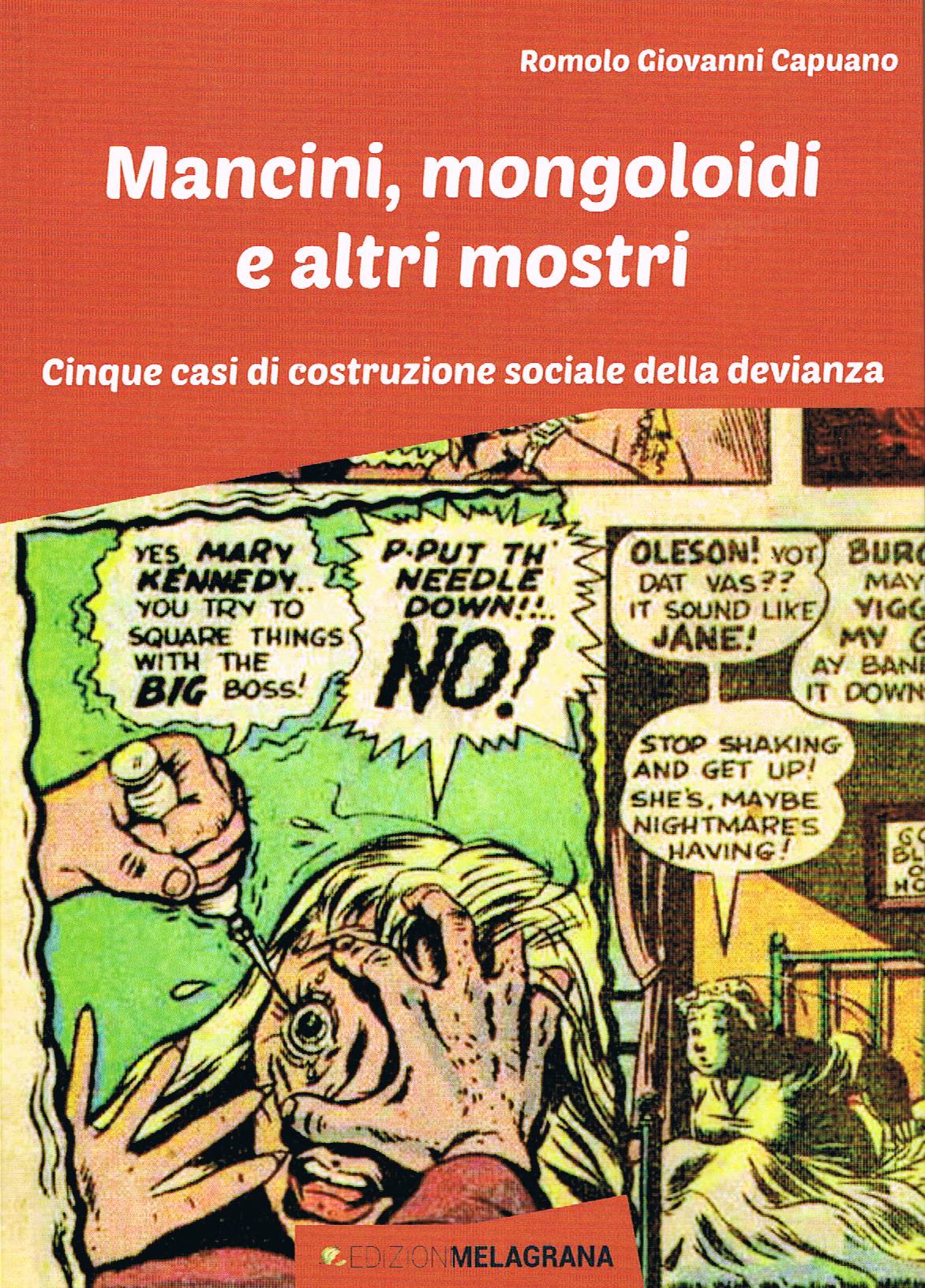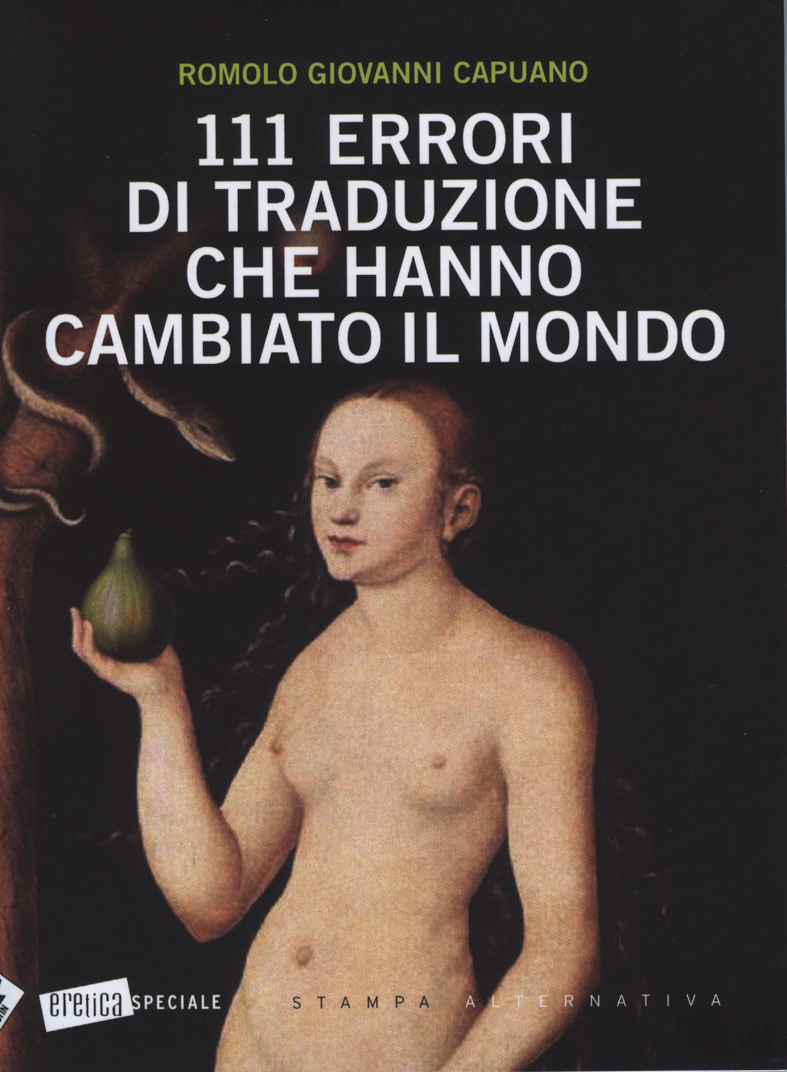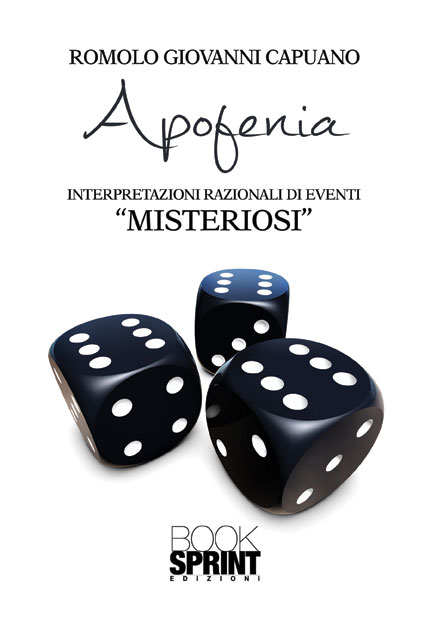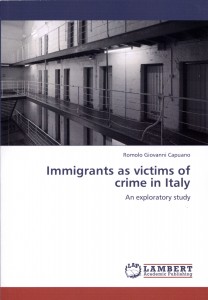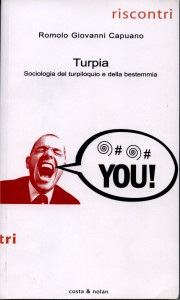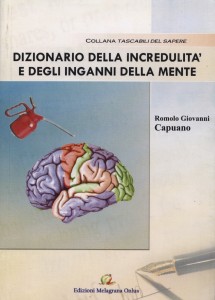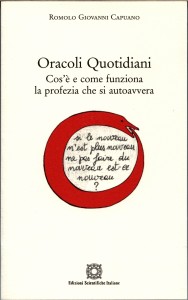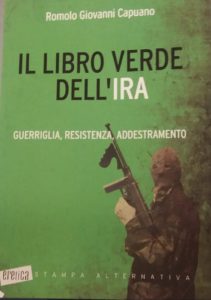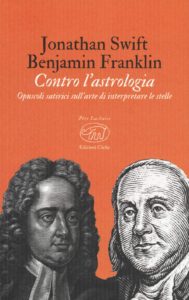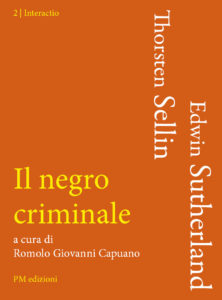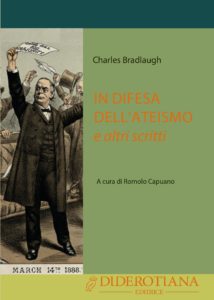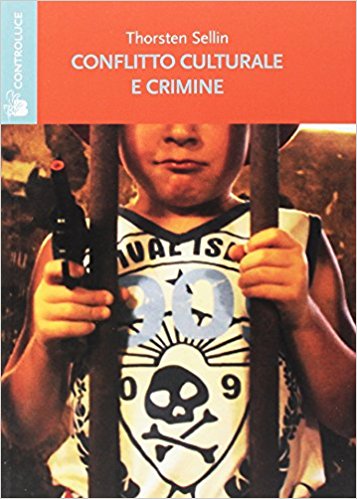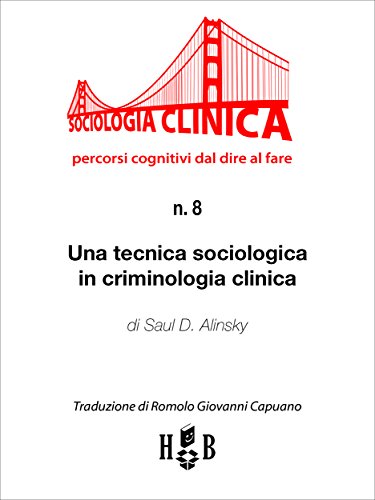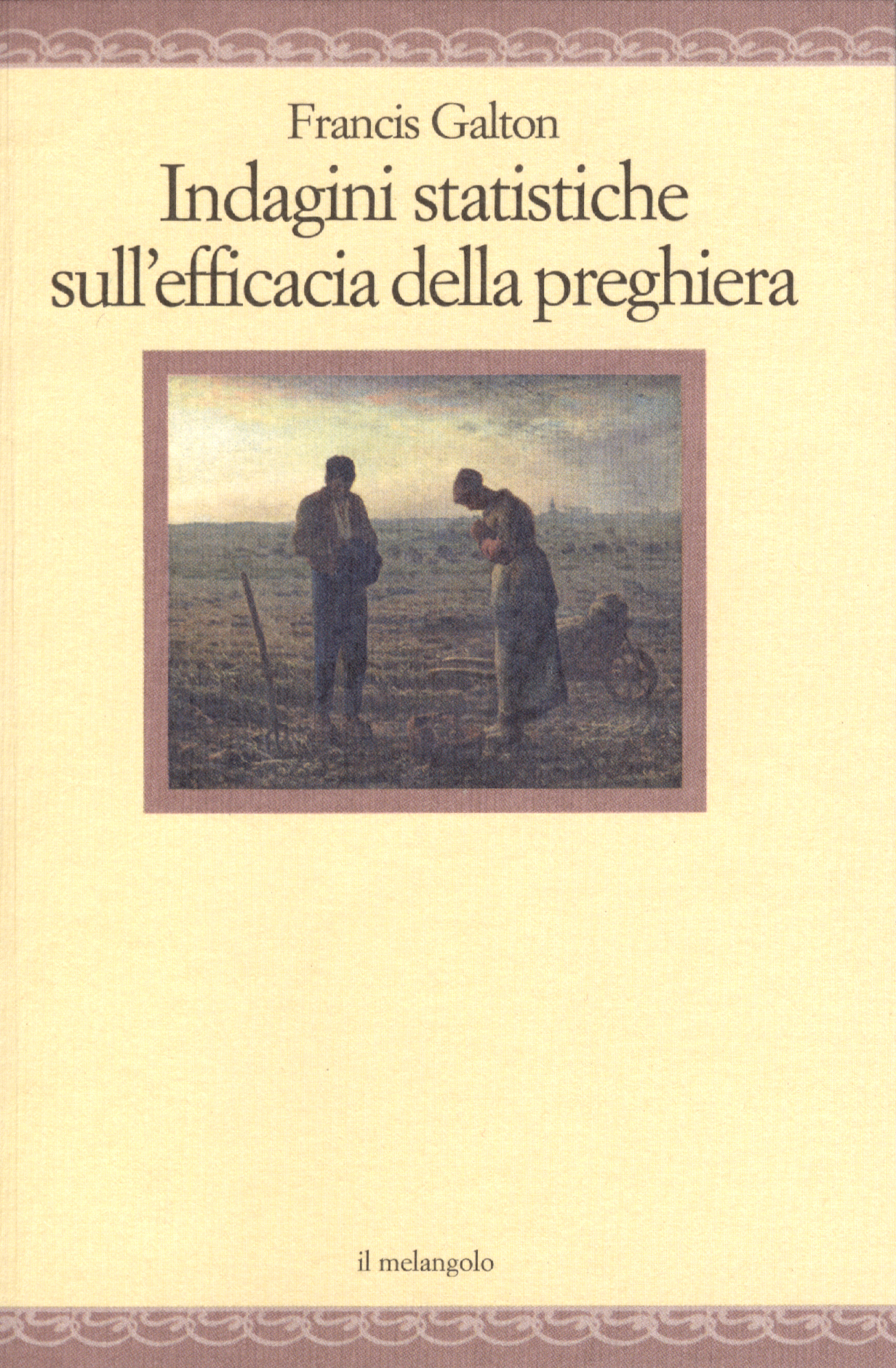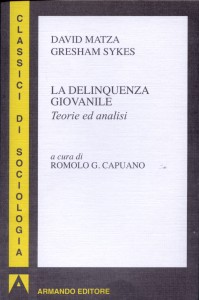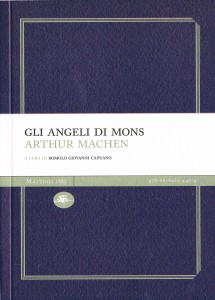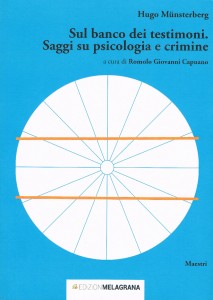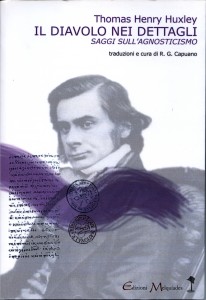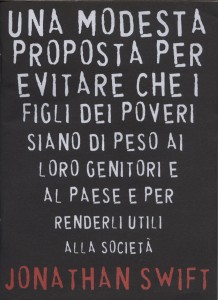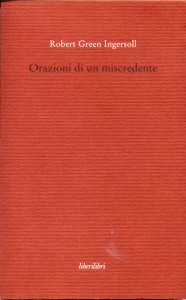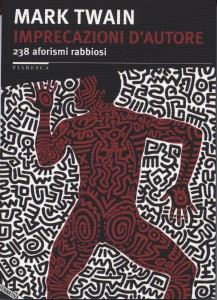Esaltati e vituperati, magnificati e riprovati, indice di gusto, ma anche “disgrazia sgraziata”, i tatuaggi occupano un ruolo sempre più centrale nell’immaginario estetico della contemporaneità, tanto da essere diffusissimi nelle nuove generazioni che vedono in essi un ornamento, ma anche una modalità espressiva, un segno identitario, una forma di comunicazione.
Non era così ai tempi di Cesare Lombroso. Il “padre” della criminologia contemporanea vedeva in essi un chiaro significato delinquenziale e non aveva remore a definire chi vi ricorreva un criminale, riflettendo, in questo, il senso comune della sua epoca (fine Ottocento – inizio Novecento).
Per Lombroso, il tatuaggio era frequente in certe categorie ed in particolare nei detenuti. Più in dettaglio, tra i recidivi e i delinquenti nati. Inoltre, mentre nei “normali” i tatuaggi apparivano per lo più sulle braccia o sul petto, nei delinquenti apparivano distribuiti su tutta la superficie della pelle. Non a caso, Lombroso considerava i tatuaggi un importante riscontro della teoria dell’atavismo secondo cui la delinquenza si spiega con il riemergere di tratti primitivi dell’evoluzione umana.
Secondo Lombroso nelle popolazioni selvagge, il tatuaggio era soprattutto un segno di casta e di prestigio e, se è sopravvissuto nella modernità, ciò può essere accaduto solo negli strati più marginali e atavici della popolazione, quindi tra delinquenti e prostitute. La persistenza del tatuaggio in questi gruppi era dovuta, secondo lui, alla vanità e all’imitazione, caratteri tipici delle classi inferiori della società.
Dopo Lombroso, l’interpretazione del tatuaggio è diventata molto più articolata. Esso è stato, di volta in volta, considerato sintomo di immaturità, di caratteropatia, di psicopatia sessuale, di omosessualità, sadismo e masochismo, di alienazione mentale; «indizio di predisposizione criminale ovvero di contatti con il mondo criminale; conseguenza della deprivazione della libertà: sfida al potere, espressione di ribellione o almeno desiderio di mostrarsi in contrasto con l’ordinamento, la società o la gerarchia; tentativo di identificarsi in un gruppo; espressione di disadattamento sociale; tentativo di compensazione di sentimenti o di una situazione di inferiorità» (Baima Bollone, P. L., 1992, Cesare Lombroso ovvero il principio di irresponsabilità, SEI, Torino, 128-130).
Sono trascorsi pochi decenni e lo status del tatuaggio è completamente cambiato. Da stigma criminale e psicopatologico, è divenuto segno normale, o almeno accettato, in tutti gli strati della popolazione e non incontra quasi più resistenza estetica, se non presso i meno giovani.
Certo, non è la prima volta che un fenomeno, inizialmente relegato alle classi inferiori, ascende fino a divenire prassi ordinaria. La storia della moda è piena di fenomeni simili.
Ciò che un sociologo – ma chiunque, in realtà – può imparare dalla storia del tatuaggio è che i segni non sono mai neutri e possono essere esaltati o condannati in virtù delle interpretazioni prevalenti in un determinato tempo e in una determinata società. Sono queste interpretazioni che conducono a elogiare oggi personalità “tatuate” del mondo dello spettacolo come Angelina Jolie e Fedez, che probabilmente sarebbero state giudicate alla stregua di prostitute o delinquenti ai tempi di Lombroso.