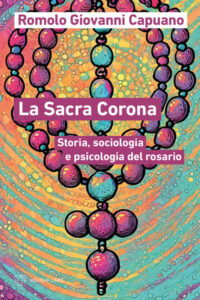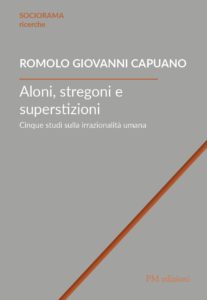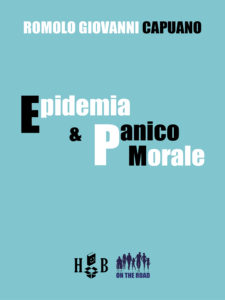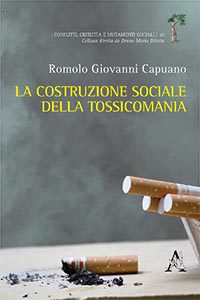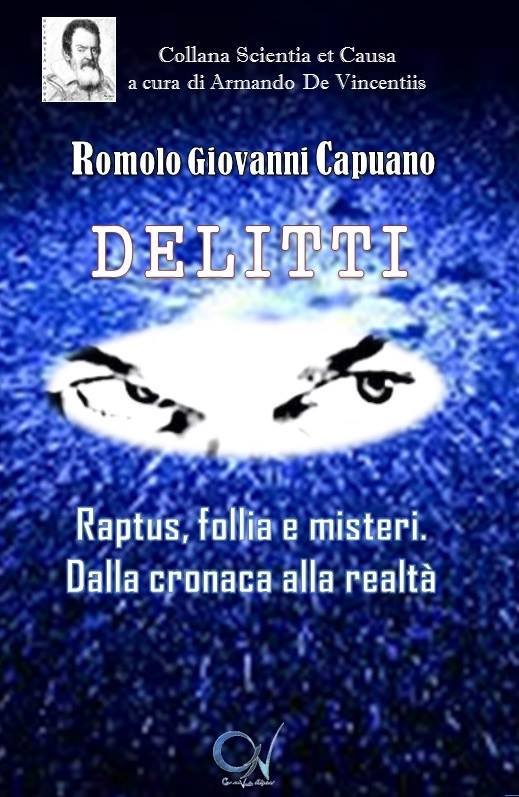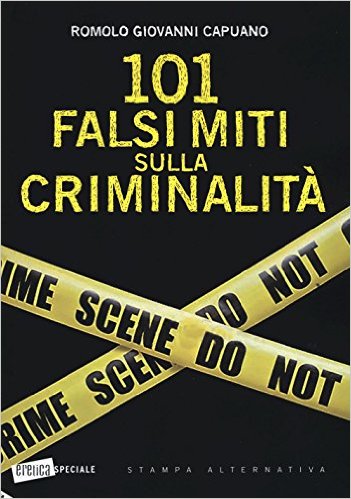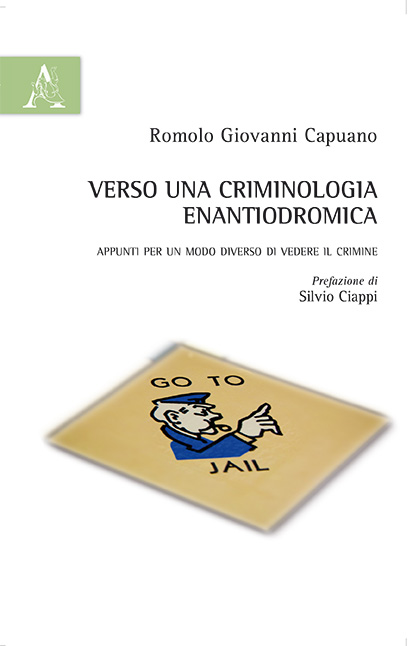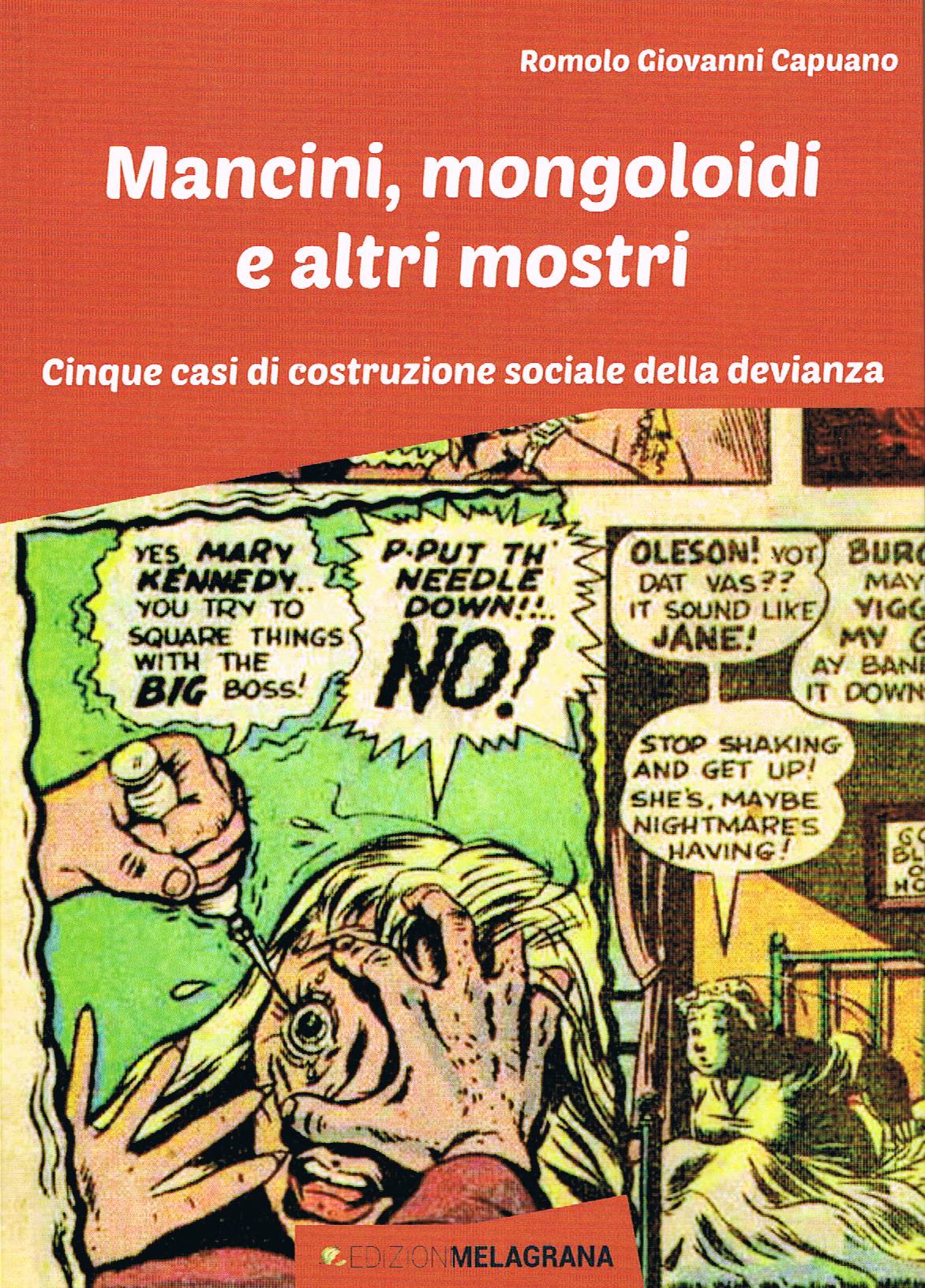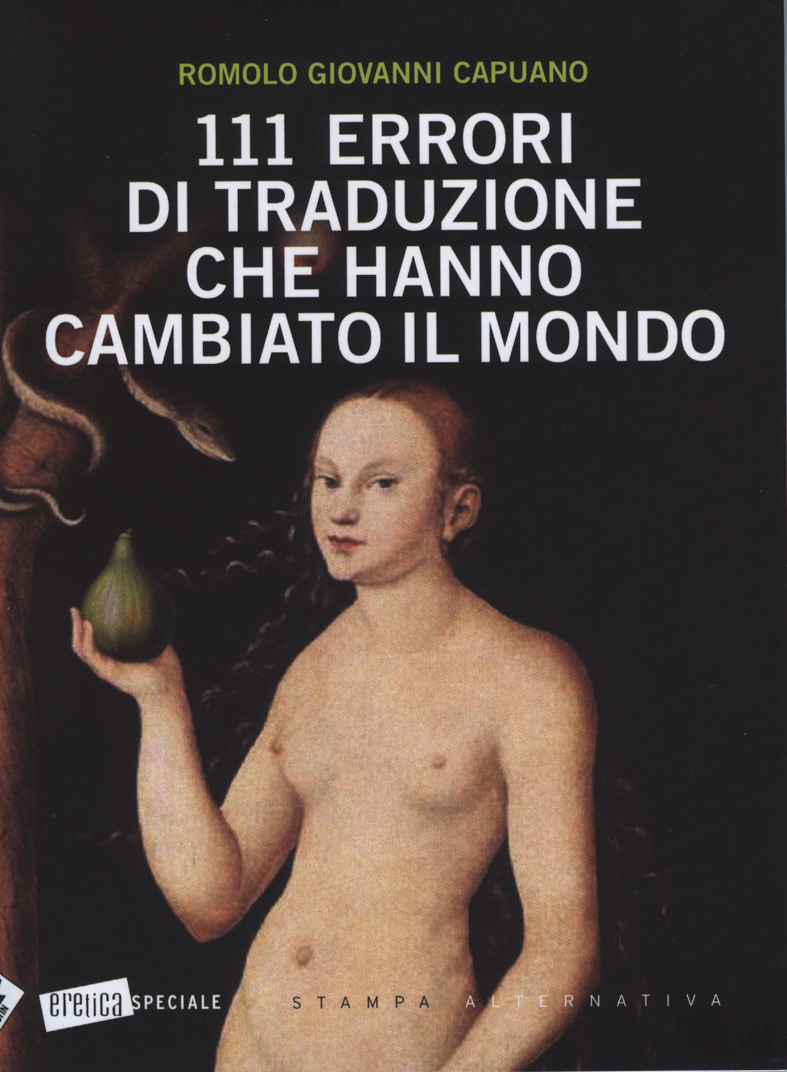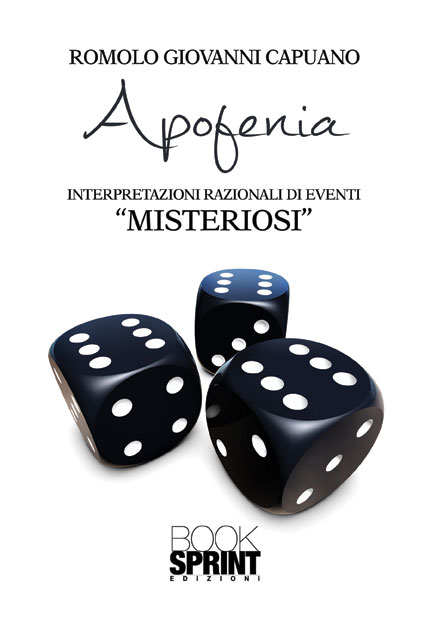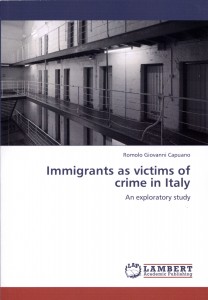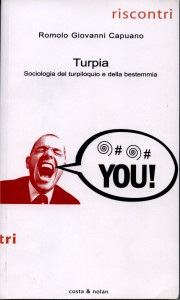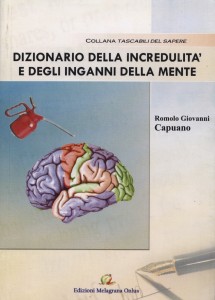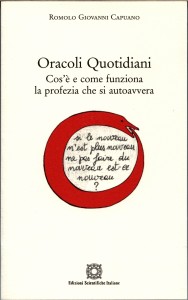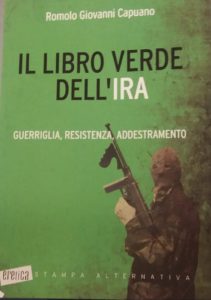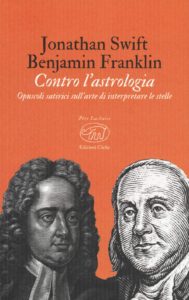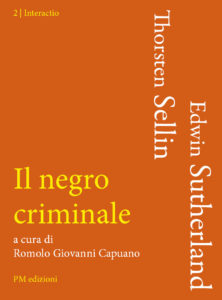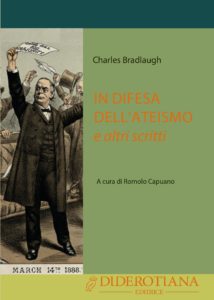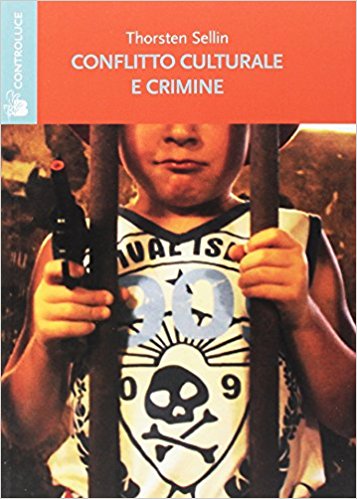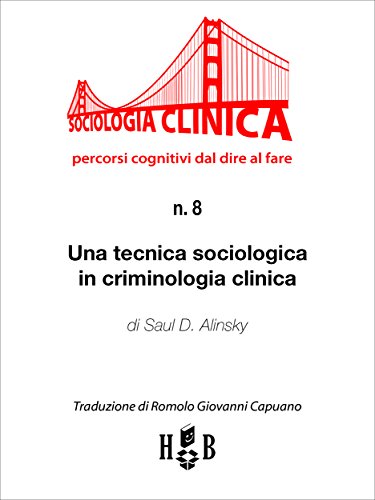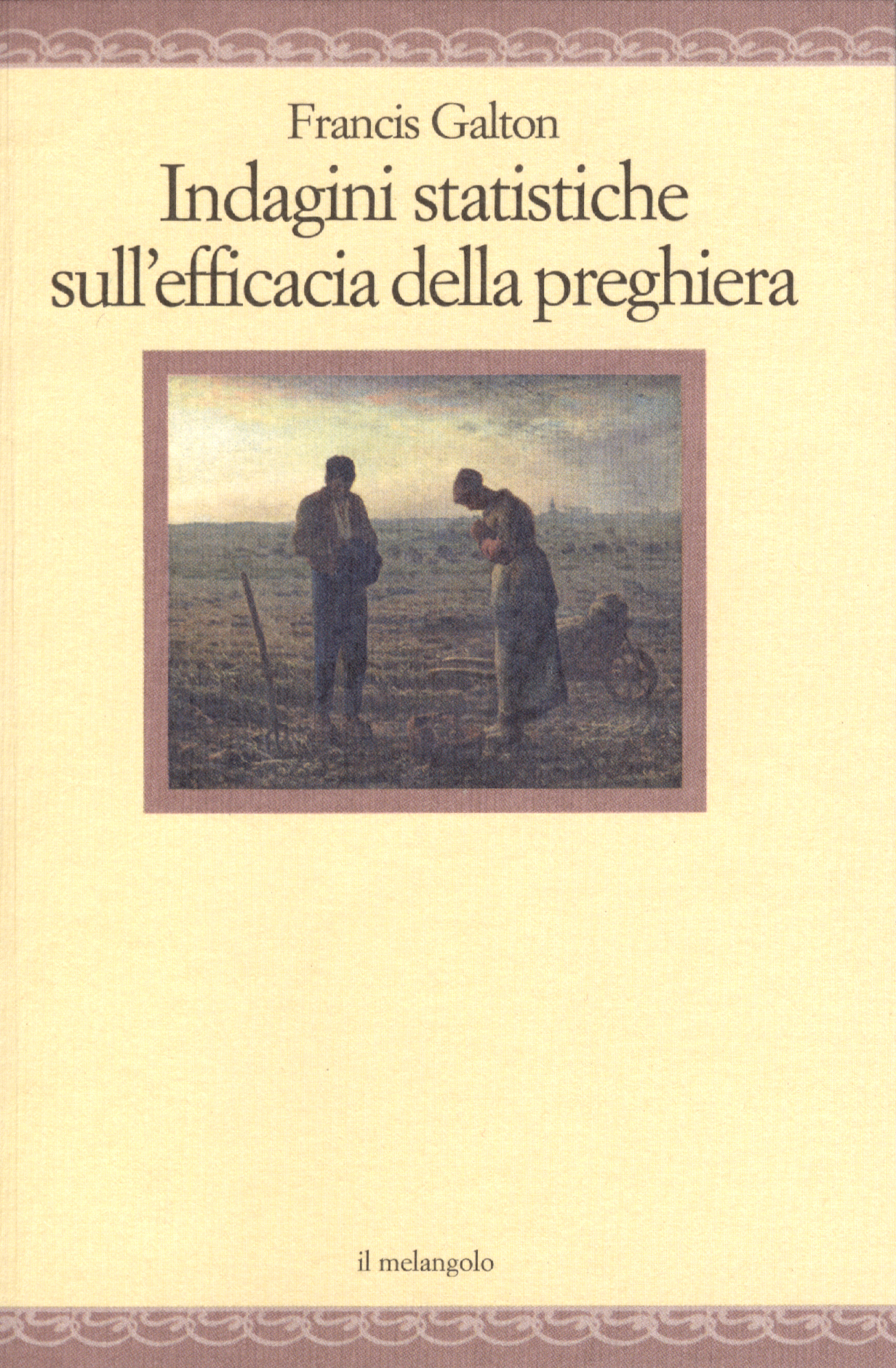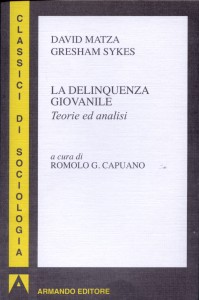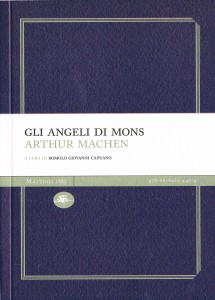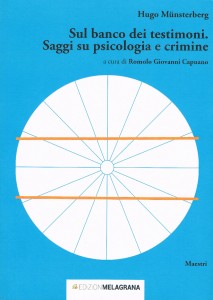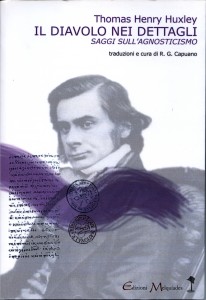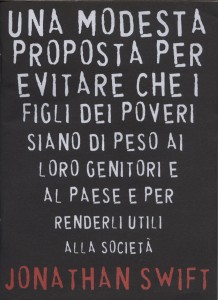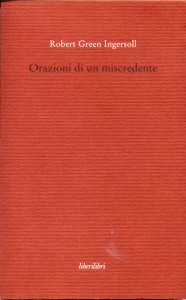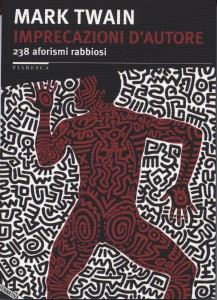Il tema è diventato “caldo” da quando Roberto Vannacci ne ha parlato nel suo Il mondo al contrario. Stando all’ultima indagine ISTAT sull’argomento, La popolazione omosessuale nella società italiana (che risale però al 2012, e non può dirsi certamente aggiornata),
circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale, più tra gli uomini, i giovani e nell’Italia Centrale. Altri due milioni circa hanno dichiarato di aver sperimentato nella propria vita l’innamoramento o i rapporti sessuali o l’attrazione sessuale per persone dello stesso sesso.
Rapportato alla popolazione complessiva di quell’anno, la percentuale di omosessuali o bisessuali dichiarati si aggira intorno al 2%. Al netto di risposte compiacenti nei confronti della morale sessuale dominante e della necessità di una indagine più recente, tale percentuale è evidentemente risicata e fa di questo orientamento sessuale un orientamento statisticamente minoritario.
Un errore frequentemente commesso in ambito sessuale è quello di confondere la normalità con la maggioranza statistica. La normalità statistica è solo una delle possibili declinazioni della normalità. Esistono, infatti: una normalità medico-legale (normale è ciò che la medicina o la legge dicono normale. Secondo la medicina e la legge, ad esempio, l’omosessualità è normale); una normalità morale (normale è ciò che la morale definisce tale, ma esistono varie morali); una normalità psicologica (un comportamento sessuale è normale se la persona si sente a proprio agio nel praticarlo); una normalità di coppia (un comportamento sessuale è normale se riflette la convergenza di un desiderio di coppia) e altre ancora.
Altro errore consiste nel confondere la normalità statistica con quella morale per cui se un comportamento sessuale è praticato da una minoranza statistica, allora è moralmente anormale. Secondo questa prospettiva, la maggioranza numerica coincide con la maggioranza morale. Conclusione che favorisce una dittatura della maggioranza inconciliabile con la forma attuale della democrazia occidentale che fa della tutela delle minoranze uno dei cardini principali della civile convivenza.
Al di là di queste precisazioni, l’argomentazione di Vannacci è che, a fronte del fatto che gli omosessuali costituiscono una minoranza sociale, essi sarebbero “palesemente sovra-rappresentati” dai mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali.
Non dispongo di dati in materia. Posso solo offrire qualche riflessione a naso. Chi consuma abitualmente intrattenimento su mass media non potrà che convenire con il fatto che mai come oggi omosessuali e bisessuali siano presenti in televisione, al cinema, nelle piattaforme streaming. Si ha l’impressione che, sulla scia dei progressi ottenuti dai movimenti per i diritti degli omosessuali, sia diventato quasi obbligatorio, o almeno opportuno, per qualsiasi produzione televisiva, ad esempio, inserire nel cast dei personaggi un omosessuale (maschio o femmina) o un bisessuale. L’omosessualità è diventata quasi una funzione di proppiana memoria. Un ingrediente di successo che viene incontro a una particolare sensibilità contemporanea. Una “moda” del momento, destinata forse a essere superata o a cristallizzarsi. Forse.
O forse tale impressione è la conseguenza di una percezione condizionata da un’omofobia diffusa, che rende più sensibili nei confronti della presenza mediatica dell’omosessualità. O forse ancora di un’omofilia patente o latente. Come chi vuole avere un figlio improvvisamente “è colpito” dal numero di donne incinte che incontra nella vita quotidiana; chi è affetto da una malattia ha l’impressione che i mezzi di informazione parlino spesso di quella malattia; chi è razzista è “colpito” dal numero crescente di “neri” nella società, così chi è particolarmente sensibile nei confronti dell’omosessualità, in senso omofobico o omofiliaco, può avere la percezione che essa sia “troppo” presente nei media.
Che l’impressione di una “omosessualità eccessiva” in televisione sia giusta o sbagliata, bisogna comunque considerare che serie televisive e film non fanno altro che sovrarappresentare determinati fenomeni sociali, tanto che questa è una caratteristica distintiva della fiction televisiva.
Si pensi alla violenza. Nei film è sempre presente una dose di violenza superiore alla realtà. Anzi, molto superiore. Sparatorie, uccisioni, ferimenti vi compaiono in maniera statisticamente maggiore rispetto alla vita reale. Stesso discorso per la criminalità. Quanto più questa è efferata e disumana – si pensi al fenomeno dei serial killer – tanto più è presente. Si può dire che ogni forma di devianza sia sovrarappresentata in televisione: dalle truffe alla corruzione, dalla violenza sessuale alla pedofilia.
Anche il sesso è costantemente iperrappresentato. Tanto da costituire un ingrediente immancabile di ogni serie televisiva. Con i suoi corollari di tradimenti, conflitti familiari, molestie, nudi mostrati e non mostrati ecc.
Sono sovrarappresentati i belli rispetto ai brutti, i giovani rispetto ai vecchi, i sani rispetto ai malati.
Insomma, la fiction è per antonomasia sovrarappresentazione. Perché lo scopo della fiction non è informare, ma intrattenere, colpendo i sensi. E a questo scopo, tutto fa audience. Soprattutto se viene incontro a particolari sensibilità del momento.
La preoccupazione di Vannacci e di chi la pensa come lui sulla sovrarappresentazione dell’omosessualità in TV potrebbe essere, dunque, un falso problema. La fiction non ha interesse a rappresentare “statisticamente” la realtà. Al contrario, la manipola, la distorce e la plasma in base ai propri interessi e necessità. Che sono quelli di attirare quanti più ascolti possibili. Fregandosene dell’adesione rigorosa alla realtà.