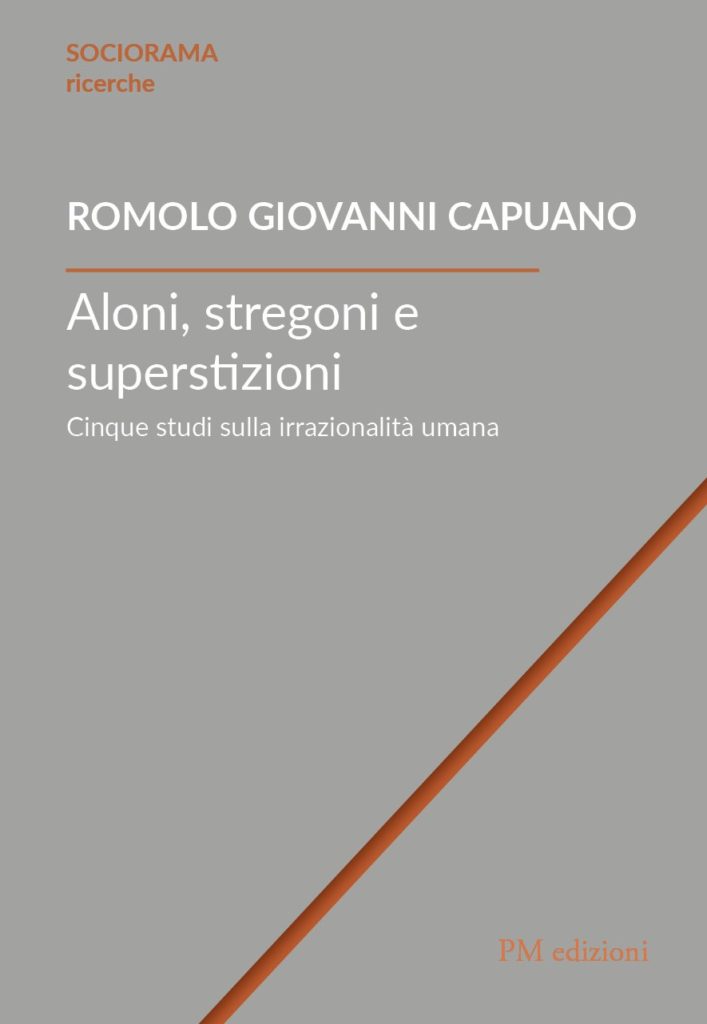Una delle conseguenze spinte della secolarizzazione profonda delle nostre società è che il posto degli dei è a disposizione di chiunque, per ragioni puramente contingenti e storiche, sia ritenuto degno di occuparlo.
Prendiamo il caso degli chef. Questo termine, che deriva dal francese “chef de cuisine, indica “una figura professionale della ristorazione, responsabile della cucina” (come ci informa Wikipedia). Da tale definizione neutra, ci aspetteremmo che lo chef abbia competenze ben precise in fatto di cucina, che sappia preparare il cibo, impostare un menù o interpretare una ricetta.
Data tale definizione, non avremmo motivo di rivolgerci a uno chef per apprendere come votare, come guadagnare in borsa, come vestirci per apparire eleganti, come essere in salute, che cosa aspettarci dall’andamento dell’ultimo virus che condiziona le nostre esistenze.
Eppure, questo è esattamente quello che succede nella nostra società secolarizzata. In mancanza di meglio, avendo data scarsa prova di sé politici, sacerdoti, maestri, scienziati (a volte), abbiamo pensato bene di sostituirli con gli chef, che, se non altro, vellicano e aggraziano la più forte pulsione primaria dell’umanità, quella della fame, a sua volta strettamente associata a un fondamentale istinto: quello della sopravvivenza.
Con gli chef, in un certo senso, torniamo alla nostra natura più primitiva, alle origini, a ciò che fa di noi ciò che siamo. Ed è per questo forse che abbiamo deciso di rimpiazzare con essa le altre figure alle quali, per tradizione, affidavamo il ruolo di bussole della nostra vita.
Tale sostituzione, tuttavia, è avvenuta nelle forme di una glamourizzazione del cuoco, che da semplice mescolatore di ingredienti, è diventato star dell’esistenza, faro della vita, barometro in un mondo senza più punti di riferimento. A tale glamourizzazione hanno contribuito inevitabilmente i media che sovraesponendone le funzioni, celebrandole, esaltandone al limite dell’apoteosi la figura, hanno installato il cuoco nel punto più eminente dell’empireo, sfrattandone i precedenti occupanti.
Assurto al ruolo di dio onnipotente, lo chef si è visto circondare il capo da un alone di nobiltà e competenza come mai prima nella storia dell’umanità. E, in virtù di quello che gli psicologi definiscono proprio “effetto alone”, che indica il fenomeno per cui un’impressione generale positiva di un individuo domina la percezione che gli altri hanno di lui anche relativamente a tratti diversi, tendiamo a pensare che, come la bellezza fisica condiziona la percezione di altre qualità della persona quali l’intelligenza o la professionalità, così l’alone glamour dello chef ci induce a pensare che chiunque vi si identifichi abbia competenze speciali anche relativamente ad altre dimensioni, come la politica, l’economia, la salute pubblica ecc.
Si tratta di un errore diffusissimo che, nello chef, vede oggi la sua manifestazione più evidente (e forse raccapricciante), ma che da sempre offusca il nostro modo di percepire persone e cose.
Se desiderate sapere di più sull’effetto alone e su come questo condiziona le nostre vite, vi rimando al mio recente Aloni, stregoni e superstizioni. Cinque studi sulla irrazionalità umana, un libro unico nel suo genere che illustra cinque meccanismi che ci rendono, ancora oggi, individui profondamente superstiziosi.