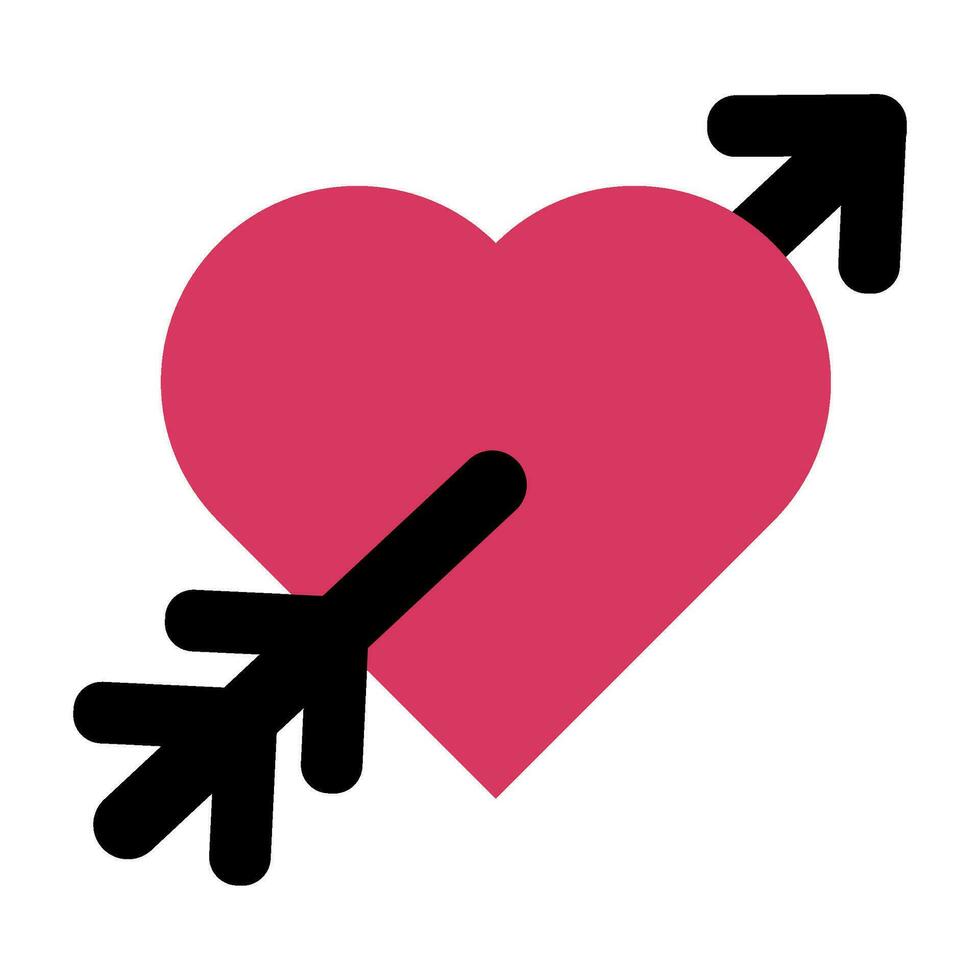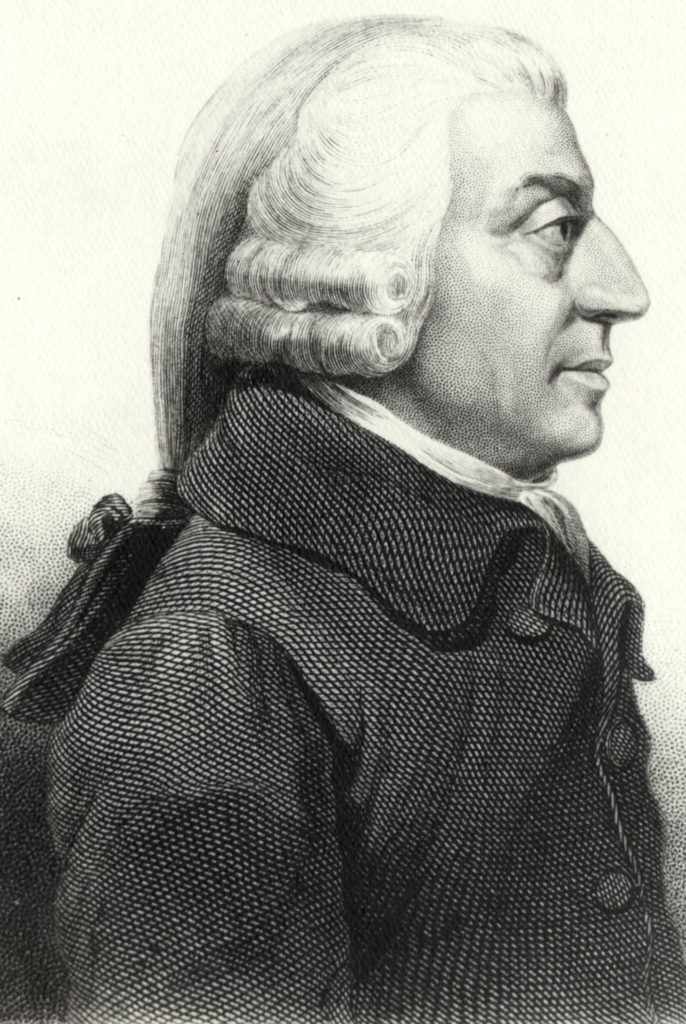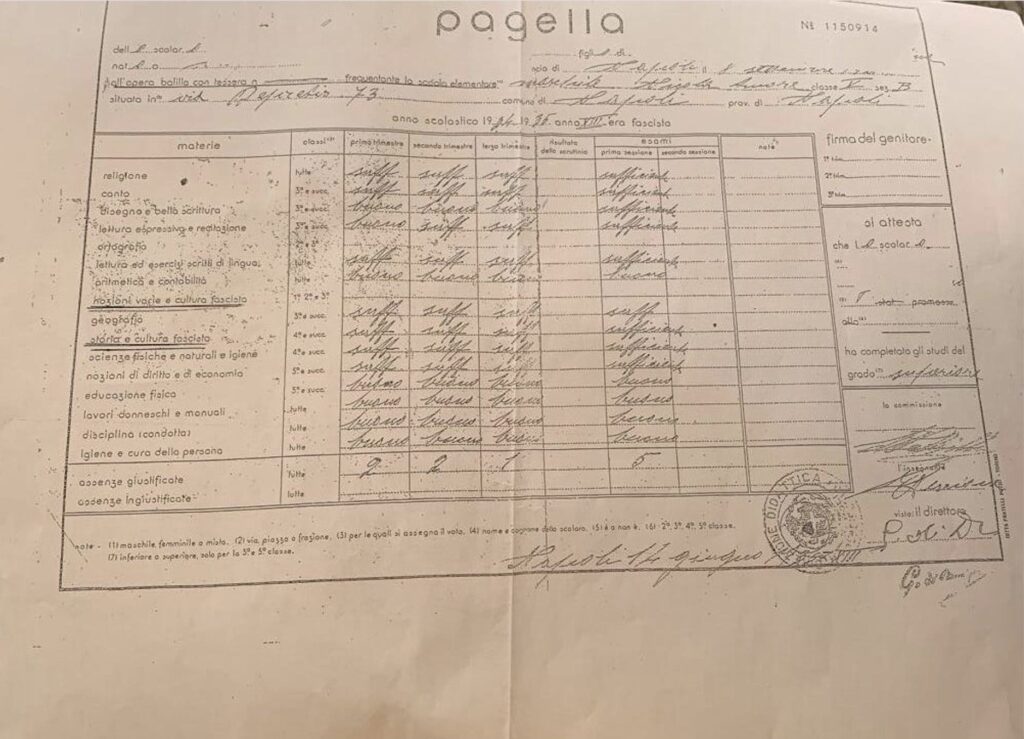Quando si tratta di prendere una decisione, quando non sappiamo che cosa fare, quando il dubbio ci attanaglia in una morsa di acciaio, è il mantra di ogni psicologia popolare, la soluzione di ogni problema, la panacea di ogni male esistenziale.
“Va’ dove ti porta il cuore”, consiglia l’amico in vena di facile altruismo. A dargli man forte, troviamo Susanna Tamaro, con l’omonimo bestseller del 1994, Laura Pasini con il singolo “Ascolta il tuo cuore” (1996) in cui gorgheggia «Dentro te ascolta il tuo cuore/E nel silenzio troverai le parole» e perfino Pocahontas della Disney, che non ha esitazioni a proclamare: «Ascolta il tuo cuore/Il tuo cuore sa e tu capirai» (1995).
Del resto, lo sapevano già il critico letterario William Hazlitt (1778-1830), al quale è attribuita la frase: «Il luogo della conoscenza è nella testa, della saggezza è nel cuore», la volpe saggia del Piccolo Principe (1943) di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), che rivela al protagonista del romanzo il segreto per affrontare la vita: «È solo con il cuore che si può vedere veramente, l’essenziale è invisibile agli occhi», e il giovane Santiago, protagonista del romanzo di Paulo Coelho L’alchimista (1988), la cui massima ispiratrice è: «Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose».
Il riconoscimento supremo della funzione dirimente del muscolo cardiaco si trova nella Bibbia. Ecclesiaste 12, 1 afferma perentoriamente:
Rallegrati, giovane, nella tua adolescenza il tuo cuore stia in allegria nei giorni della tua giovinezza. Va’ dove ti conducono gli impulsi del tuo cuore, segui ciò che piace agli occhi.
E Proverbi 3, 5–6 ribadisce:
Confida nell’Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento; riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri.
Si potrebbe continuare. Ciò che colpisce in tutte queste occorrenze è che il cuore viene identificato con la parte più spontanea di noi, quella più autentica, genuina, incontaminata, in grado di scorgere la verità al di là dei filtri della ragione.
Il cuore è la vocina interiore che ci indica la strada giusta; la pura intuizione che illumina la strada da prendere, la sede dei sentimenti più schietti. Il cuore custodisce i segreti più intimi della nostra anima, sa quali sono le nostre vocazioni, i nostri sogni e i nostri desideri più reconditi, conosce ciò che è meglio per noi. Perché, dunque, non affidarsi serenamente ai suoi impulsi?
Per almeno due ragioni: una di ordine sociologico, l’altra di ordine logico e psicologico.
Cominciamo dalla prima.
Come osserva icasticamente il filosofo israeliano Yuval Noah Harari, «il cuore è un doppiogiochista che di solito prende ordini dai miti dominanti in quel momento, e la stessa raccomandazione “Segui il tuo cuore” è stata impiantata nelle nostre menti da una combinazione di miti romantici ottocenteschi e miti consumistici del Novecento» (Harari, 2023, p. 151).
È ingenuo pensare che il “cuore” sia avulso dalla società in cui palpita. Noi desideriamo ciò che la collettività desidera, amiamo ciò che le persone intorno a noi amano, sogniamo di essere o avere ciò che i media, la famiglia, gli amici, i parenti, i vicini di casa sognano di essere o avere. Nessuno desidera in un vuoto sociale. Posto di fronte alla scelta tra un lavoro e un altro, il “mio cuore” mi spingerà, comunque, verso una scelta approvata dalla società in cui vivo. Indeciso tra giurisprudenza e scienze dello spettacolo, deciderò, in ogni caso, per una delle opzioni offertemi dal sistema universitario vigente. Perfino in ambito sentimentale, seguirò “il mio cuore” in base a ciò che il mio gruppo sociale di riferimento mi “indicherà”, non necessariamente in maniera esplicita e diretta, come desiderabile. Insomma, vocazioni, preferenze, scelte non hanno un’origine puramente individuale o “cordiale” (aggettivo che significa “che viene dal cuore”), ma sono forgiate dalla società in cui viviamo.
La stessa raccomandazione “Va’ dove ti porta il cuore”, come osserva Harari, è un misto di miti romantici e consumistici con la loro enfasi sull’individualismo, la realizzazione del sé, l’edonismo, la felicità a ogni costo, l’insoddisfazione continua nei confronti della vita da “riempire” attraverso continui atti di consumo materiale e spirituale.
Un’altra ragione, di ordine logico e psicologico, dovrebbe metterci in guardia dal fare troppo affidamento sul nostro cuore. Si tratta di una fallacia cognitiva piuttosto comune che prende il nome di wishful thinking o “pensiero orientato dal desiderio”, termine con cui si indica la tendenza a ritenere che qualcosa sia vero perché risponde a un desiderio intenso.
Essa assume la forma:
Voglio che P sia vero
Pertanto, P è vero
Oppure:
Desidero che non sia il caso che Y
Pertanto, non credo che Y
In un certo senso, nessuno di noi è immune da questa forma di illusione. A tutti piace credere che qualcosa sia vero solo perché sarebbe bello che fosse tale. In materia di religione, alcuni credenti fondano la propria fede nell’esistenza di Dio sul fatto che la vita sarebbe intollerabile se la divinità non esistesse. In politica, gli elettori tendono sistematicamente a distorcere le probabilità di vittoria del proprio schieramento in base ai propri desideri. In campo sentimentale, gli innamorati tendono regolarmente a interpretare parole e comportamenti della persona amata sulla base delle aspettative del proprio cuore. In tutti questi casi, «si tende ad attribuire un valore eccessivo all’evidenza in favore della credenza che le cose stiano in un certo modo semplicemente perché si desidera che stiano in quel modo» (Diez, Iacona, 2014, p. 95). Una conseguenza frequente è che, se la credenza dettata dal cuore trova fondamento nella realtà, ne ricordiamo l’esito felice; se ciò non accade, tendiamo a dimenticare l’insuccesso della nostra scelta perché “il cuore ha sempre ragione”.
Il wishful thinking è particolarmente rilevante nelle situazioni caratterizzate da forte intensità emotiva. Al riguardo lo psicologo Daniel Kahneman parla di “euristica dell’affetto”, per indicare quel modo di pensare consistente nel formulare giudizi e prendere decisioni consultando le proprie emozioni (“Come mi fa sentire?”) piuttosto che la ragione (“Che cosa ne penso?”) (Kahneman, 2012, p. 154). In altre parole, gli individui si appellano alle emozioni per decidere se un ragionamento è efficace o no. Questa euristica è molto sfruttata in politica, pubblicità e anche nelle normali relazioni quotidiane. I politici, ad esempio, vi ricorrono spesso per sostenere la bontà delle proprie argomentazioni (“Lasciate stare le statistiche. Gli immigrati fanno paura ed è meglio che tornino a casa!”). In pubblicità, quasi tutti gli spot commerciali fanno appello alle emozioni piuttosto che spiegare quali siano le qualità del prodotto commercializzato. Nella vita quotidiana, la testimonianza di una persona in lacrime può risultare più credibile dei numeri snocciolati da uno scienziato algido.
Sempre a proposito di emozioni, in psicologia, un modello molto interessante è quello definito affect as information (Storbeck, Clore, 2008). Secondo questo modello le persone tendono a inferire informazioni su fatti, fenomeni, condizioni a partire dal proprio stato affettivo-emozionale. L’emozione, dunque, viene utilizzata come informazione che orienta le conoscenze e, soprattutto, conferma la bontà/verità delle conoscenze che hanno dato origine alla stessa emozione. Ad esempio, alcune persone tendono a inferire un pericolo a partire dall’ansia che provano (se mi sento ansioso, vuol dire che c’è qualcosa che causa la mia ansia e la giustifica).
È immediatamente evidente la rilevanza di questo modello per la tematica di cui stiamo parlando. Ad esempio, uomini e donne tendono a ricavare una “predizione” sul futuro delle loro relazioni amorose in base a ciò che sentono per la persona amata “nel profondo del cuore”. Il meccanismo funziona così: ciò che provo per questa persona è così speciale che sicuramente la nostra relazione durerà per sempre/saremo sempre felici insieme. Purtroppo, è facile constatare che a questa sicumera affettiva non corrisponde sempre ciò che si sente. Ognuno di noi conosce persone costrette a disilludersi sentimentalmente dopo un certo periodo, a dispetto dell’iniziale intensità emotiva.
Insomma, nonostante le pretese della saggezza popolare, come afferma (contraddittoriamente, bisogna ammettere) ancora la Bibbia,
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato; chi lo può conoscere? (Geremia 17, 9).
È vero che «vivere nella beata illusione che le nostre speranze e aspirazioni si realizzeranno può essere una scelta di vita; e ci sono ottimisti incrollabili che, sperando contro ogni speranza, alla fine vedono i propri desideri prendere corpo o almeno il mondo adattarsi alla loro realtà mentale» (Cattani, 2011, p. 170), ma, con buona pace di Susanna Tamaro e Pocahontas, confondere desiderio e realtà, affect e information, in altre parole, “seguire il proprio cuore”, conduce spesso a scelte sbagliate o discutibili, di cui è facile pentirsi in seguito.
Lo testimonia Anne, la protagonista di uno degli episodi della quinta stagione della celebre serie degli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo Ai confini della realtà, dal titolo “L’impulso del momento” (Spur of the moment), la quale rovina la sua vita per ascoltare il proprio cuore, scegliendo di sposare un giovane fallito, che condurrà in disgrazia la sua intera famiglia.
«If it makes you happy, then it can’t be that bad» (“Se ti fa sentire felice, non è poi tanto male”) canta Sheril Crow in If it makes you happy.
Purtroppo, seguire il proprio cuore e sentirsi happy non garantiscono affatto che le proprie scelte non saranno bad. Anche se tanti dicono, scrivono e cantano il contrario.
Riferimenti:
Cattani, A., 2011, 50 discorsi ingannevoli, Edizioni GB, Padova.
Diez, J.A., Iacona, A., 2014, Amore e altri inganni, Indiana Editore, Milano.
Harari, Y. N., 2023, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano.
Kahneman, D., 2012, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano.
Storbeck, J., Clore, G. L., 2008, “Affective Arousal as Information: How Affective Arousal Influences Judgments, Learning, and Memory”, Social and Personality Psychology Compass, vol. 2, n. 5, pp. 1824-1843.