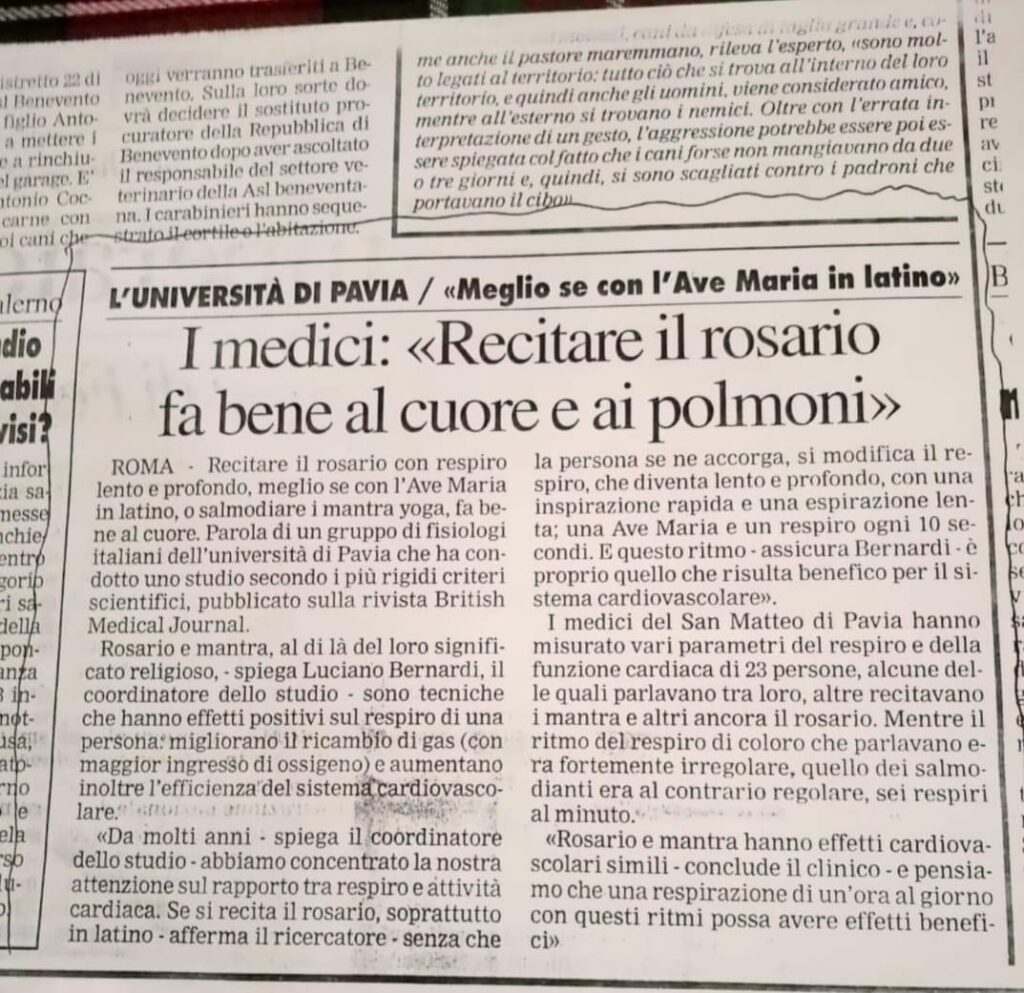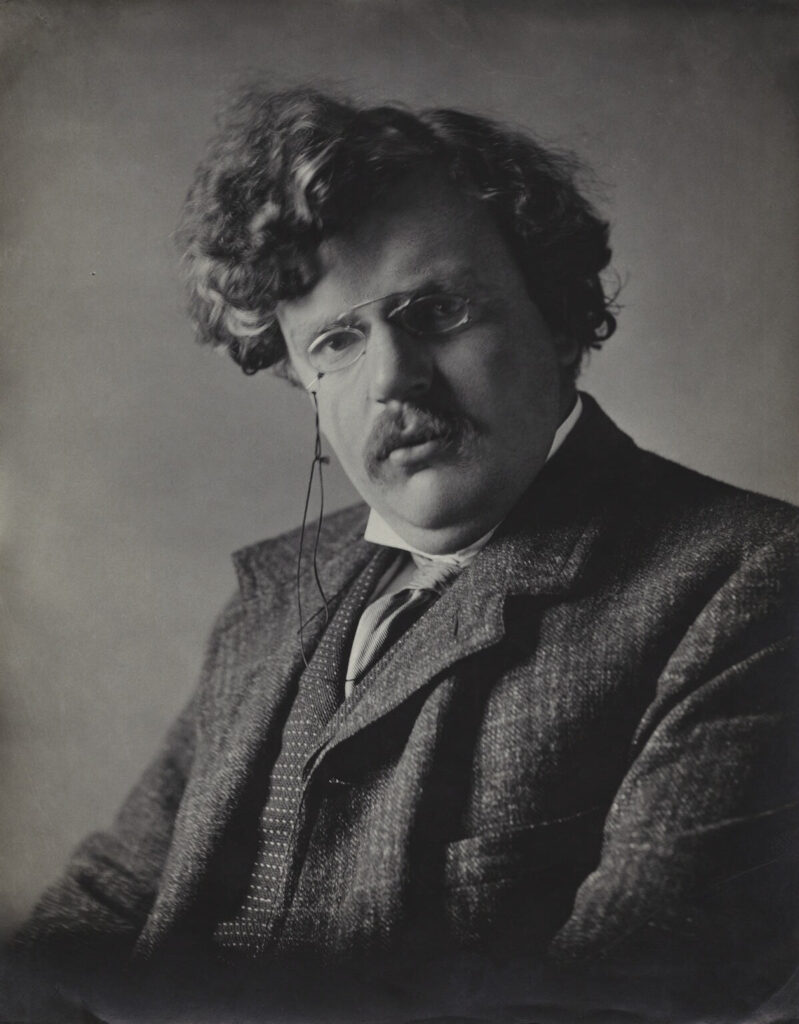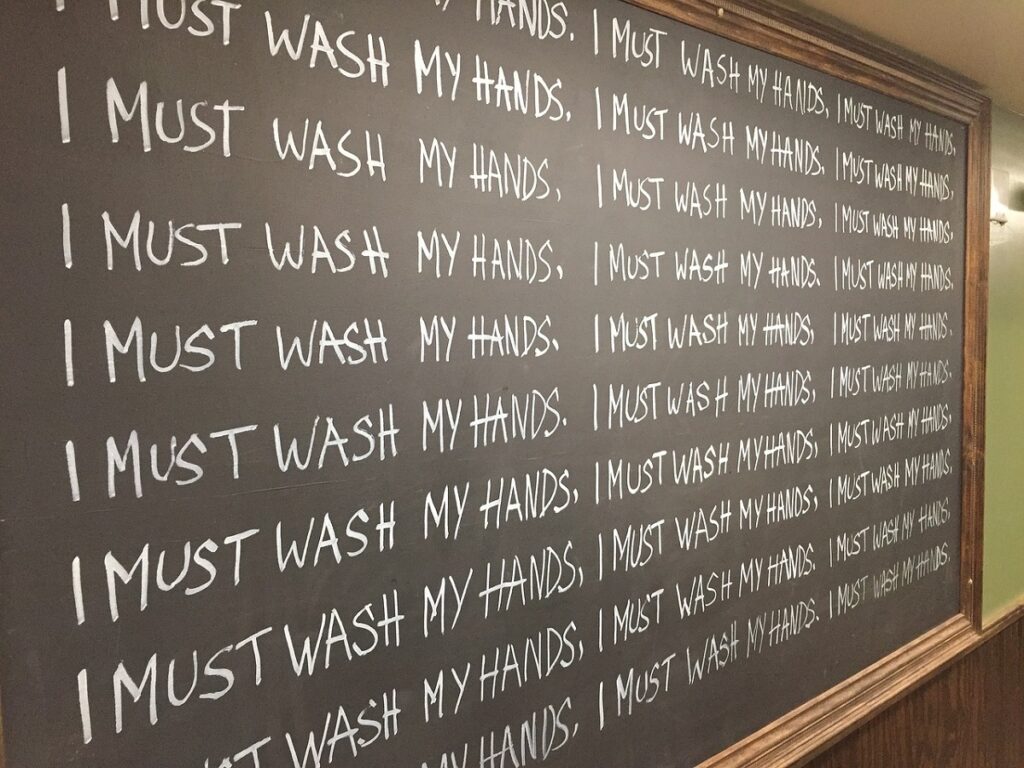Nel capitolo XXV dei Promessi sposi, Alessandro Manzoni fa esclamare a Don Abbondio impegnato in dialogo con il cardinale Borromeo: «Il coraggio, uno non se lo può dare». Come dire: “Che cosa ci posso fare se sono un codardo? Sono fatto così!”. E a nulla valgono le rimostranze del cardinale secondo cui «in codesto ministero, comunque vi ci siate messo, v’è necessario il coraggio, per adempir le vostre obbligazioni». Il silenzio vergognoso del parroco rafforza il senso delle sue prime parole. La frase «Il coraggio, uno non se lo può dare» diventa la certificazione della immodificabile, insanabile pusillanimità del curato più famoso della letteratura italiana.
Il personaggio manzoniano non è l’unico a giustificare i propri difetti con la frase “Sono fatto così”. Anzi, come dice Marco Presta in Un calcio in bocca fa miracoli (p. 27), «“Sono fatto così” è la giustificazione che tutti usiamo quando, sorpresi a fare una puttanata, vogliamo continuare a farla».
Così, diciamo: “Non sono portata per la matematica/per le lingue. Sono fatta così” per dare un senso ai nostri fallimenti scolastici e non sforzarci di imparare.
Diciamo: “Sono timido/introverso/riservato. Non posso farci niente” per giustificare le nostre difficoltà relazionali.
Diciamo: “Sono un imbranato a calcio/disegno/recitazione. Lo sono sempre stato” per rafforzare la nostra inerzia e trovare una scusa per non cambiare.
Diciamo: “Sono svagata/irresponsabile/disorganizzata. Lo sono per natura” per non impegnarci a essere responsabili e maturi. Del resto, se è scritto nei nostri geni, che cosa possiamo farci?
Il luogo comune “Sono fatto così” diviene così una stampella a cui aggrapparci per non cambiare, per evitare un certo tipo di attività, per rendere plausibile un difetto, per sfuggire alle nostre responsabilità, per scansare la fatica e il pericolo inerente al tentativo di modificare la nostra condotta, per evitare di metterci in discussione. Con il rischio di perpetuare ad infinitum un comportamento sgradevole, producendo una “profezia che si autoavvera”. Così, ad esempio, una ragazza che va a una festa convinta di essere timida, si comporterà come se lo fosse davvero, e questo comportamento rafforzerà ulteriormente l’immagine negativa che ha di sé, inibendole possibilità di socializzazione; inibizione che, a sua volta, consoliderà la sua timidezza, portando a compimento il circolo vizioso (Dyer, 1977, pp. 72-77).
Il guaio è che la convinzione espressa dalla frase “Sono fatto così” pone un problema non solo a noi, ma anche a chi ci circonda. Quanti matrimoni sono falliti perché traditrici seriali, giocatori d’azzardo compulsivi e fannulloni cronici hanno giustificato le loro condotte deleterie con la fatidica scusa “Sono fatto/a così”? Quante volte, nel corso di confronti con partner, genitori, amici, colleghi che fanno notare le nostre mancanze, obiettiamo, anche con aggressività: “Non posso cambiare”; “Vado bene così come sono”; “Se non ti sto bene, è un problema tuo”; “Sono così da sempre”?
E tutto questo per timore di cambiare.
Certo, cambiare non è semplice. Al di là della facile retorica ottimistica dei manuali di self-help, la verità è che cambiare vuol dire uscire dalla propria comfort zone (termine al momento tremendamente di moda), rinunciare ad abitudini inveterate, assumere un atteggiamento diverso nei confronti della vita, non cedere alla tentazione sempre incombente di fare solo ed esclusivamente i propri comodi.
Cambiare significa anche imparare ad ascoltare l’altro (“attivamente”, come si usa dire nel gergo della psicologia), prestare attenzione alle sue esigenze, soddisfare le sue richieste. Dicendo: “Sono fatto così” erigiamo un muro, teniamo a distanza ogni possibilità di dialogo, inventiamo una retorica dell’impossibilità che è tutta nella nostra testa, indossiamo una maschera dietro la quale ci rifugiamo per evitare di assumerci responsabilità.
Inoltre, ripetere in continuazione “Sono fatto così” nelle sue innumerevoli varianti ci condanna all’inerzia, alla ripetizione disperata degli stessi schemi di vita, alla ossessiva riproposizione delle stesse routine quotidiane, addirittura alla credenza infondata secondo cui non solo noi, ma neppure le cose nel mondo non potranno mai cambiare. Un incubo che, però, spesso preferiamo al cambiamento perché, come detto, cambiare è difficile. “Sono fatto così” è paragonabile allora a un meccanismo di difesa dai pericoli della vita, una forma di rassicurazione dalla paura di fallire, e forse anche dal timore di vincere e migliorare la propria esistenza.
Le cose si complicano quando “Sono fatto così” diventa “Lui/Lei è fatto/a così”, ossia quando congeliamo l’altro/a in una etichetta inscalfibile e perpetua per cui “Tizio è un pessimista”, “Caio è un pettegolo”, “Lucrezia è incapace di avere una relazione stabile”. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma, così facendo, attestiamo indubitabilmente che l’altro/a è così e non altrimenti, con il rischio di produrre catastrofiche profezie che si autoavverano – se per noi l’altro non è in grado di sostenere un carico di lavoro impegnativo perché “è fatto così”, il fatto che il bersaglio del nostro giudizio continui a occuparsi di mansioni poco faticose non gli permetterà di acquisire le necessarie competenze per occuparsi di compiti più complessi, finendo con il confermare l’assunto squalificante di partenza – e veri e propri comportamenti discriminatori o di disapprovazione morale.
Infine, “Sono fatto così” può divenire, in alcuni casi, “Si è sempre fatto così”. L’esempio più vivido è offerto dalla cosiddetta “cultura del precedente” in voga nelle pubbliche amministrazioni, nelle quali l’apprendimento lavorativo si basa spesso sull’imitazione pedissequa di ciò che fanno (e hanno sempre fatto) i colleghi anziani.
Si tratta di un comportamento antico, che risale agli albori della pubblica amministrazione, quando alcune consuetudini, alle quali si ispiravano dirigenti, funzionari e impiegati per risolvere problemi, divennero ben presto leggi ferree alle quali tutti dovevano attenersi a dispetto di ogni irrazionalità o incongruenza. È così che nacque l’archetipo dell’impiegato che osserva irriflessivamente la procedura burocratica, anche se inadeguata o farraginosa al contesto, con la conseguenza di sviluppare tunnel mentali che rendono virtualmente impossibile sperimentare nuove soluzioni o adeguarsi ai tempi.
Il sociologo americano Robert K. Merton definì “incapacità addestrata” il fenomeno per cui «azioni basate sull’addestramento e l’abilità tecnica, che in passato avevano dato un risultato positivo, possono risultare in risposte inappropriate sotto mutate condizioni» (Merton, 1970, pp. 407-408). È quello che succede quando si agisce in un modo perché “si è sempre fatto così”, perseverando in condotte che forse erano adatte un tempo, ma che, nel presente, non hanno più senso di esistere.
È l’ossequio all’abitudine, a quel benedetto avverbio “sempre”, a illuderci che le cose abbiano bisogno immancabilmente della medesima soluzione a dispetto di tempi e ambienti diversi. Un luogo comune perniciosissimo a cui cediamo fin troppo volentieri e che talvolta eleggiamo addirittura a massima di vita lavorativa.
“Sono fatto così”; “Lui/Lei è fatto/a così”; “Si è sempre fatto così” sono credenze, convinzioni, certezze che dovrebbero essere eliminate dal nostro lessico quotidiano perché impongono una visione rigida, immobile, ingessata alla nostra esistenza, impedendoci di viverla nella sua complessità e di cambiare in ragione di situazioni, tempi, luoghi e persone diverse.
Riferimenti
Dyer, W. W., 1977, Le vostre zone erronee. Guida all’indipendenza dello spirito, Rizzoli, Milano.
Merton, R. K., 1970, “Struttura burocratica e personalità” in Idem, Teoria e struttura sociale, vol. II, Il Mulino, Bologna.
Presta, M., 2014, Un calcio in bocca fa miracoli, Einaudi, Torino.