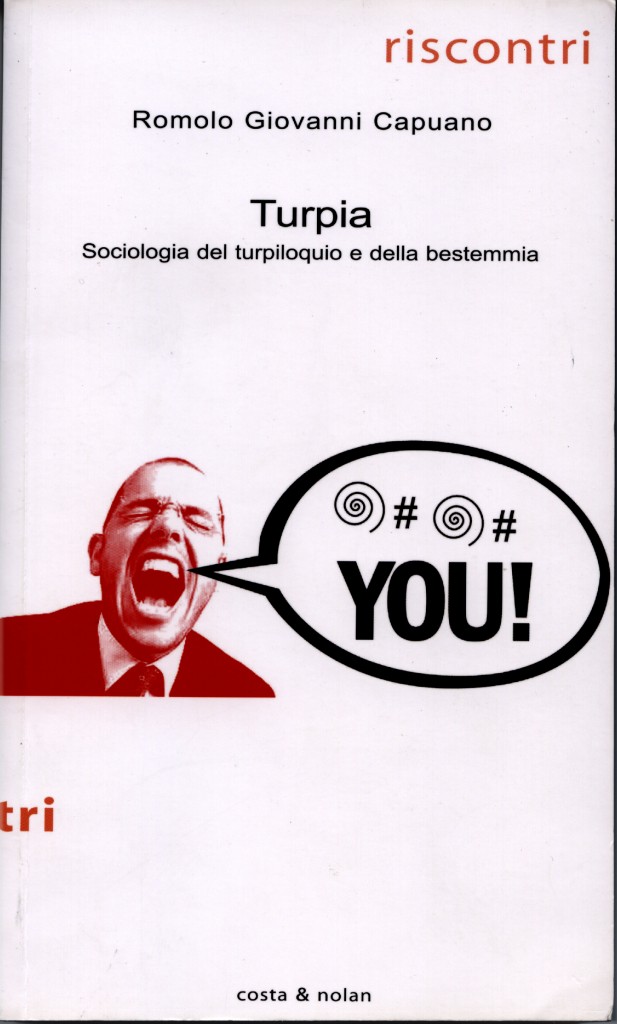Nel Discorso 241 (405-410) “Nei giorni di Pasqua sulla risurrezione dei corpi, contro i pagani”, sant’Agostino (354-430) scrive che per i filosofi pagani la bellezza dell’universo costituiva un richiamo a ricercare l’Artefice delle cose e che la bellezza della terra, del mare, dell’aria rarefatta, del cielo e dell’ordine delle stelle permetteva di risalire a Dio. Per il santo di Ippona, la pulchritudo dei è una forza salvifica in grado di trasformare il mondo. Essa non è solo una caratteristica estetica, ma rimanda ai concetti di grazia, armonia, equilibrio del tutto. La bellezza avvicina a Dio perché è una qualità che Dio stesso ha conferito al creato. Tramite essa, gli esseri umani sono tutt’uno con il loro creatore.
Quest’idea influenzò sicuramente Fedor Dostoevskij (1821-1881), il quale, nell’Idiota (1868), fa dire a Ippolit in conversazione con il principe Myskin, le seguenti parole:
È vero, principe, che una volta diceste che il mondo sarà salvato dalla bellezza? Signori – si mise a gridare a tutti – il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza! E io affermo che ha idee così giocose perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato; me ne sono convinto poco fa, appena è entrato. Non arrossite, principe, mi fareste pena. Quale bellezza salverà il mondo? È Kolja che me l’ha riferito… Siete un fervente cristiano? Kolja dice che voi stesso vi dite cristiano. Il principe l’osservò con attenzione, ma non rispose (Dostoevskij, 1988, pp. 857-858).
Giacché il principe Myskin non risponde alla domanda di Ippolit, ancora oggi gli esegeti del grande scrittore russo continuano a porsi domande su quale senso attribuire a questo passo dell’Idiota. In particolare, a quale bellezza fa riferimento Ippolit? Alla bellezza di una donna (come sembra lasciare intendere l’allusione all’innamoramento di Myskin)? Alla bellezza della natura? Alla bellezza dell’arte, del cosmo, della letteratura, della cultura, degli esseri umani? Non possediamo una risposta definitiva a questi interrogativi perché non sappiamo quale idea di bellezza avesse in mente Dostoevskij in questo passo.
Se, tuttavia, Dostoevskij non si pronuncia sull’argomento, lasciando il lettore con più di un’incertezza sul senso dell’interrogativo di Ippolit, non sembrano avere alcun dubbio i tanti filosofi, insegnanti, moralisti, pedagogisti, funzionari pubblici, esperti d’arte, giornalisti, artisti e persone comuni che oggi ripetono psittacisticamente la frase “La bellezza salverà il mondo”, come se essa contenesse una sua saggezza intrinseca, a tutti evidente, che l’incessante reiterazione serve solo a confermare. A ciò contribuisce inevitabilmente anche il fatto che il termine “bellezza”, dotato com’è di una sua inattingibile astrattezza olimpica, comunica una positività tanto immediata quanto indeterminata, con cui è difficile non entrare in sintonia.
Ma cosa significa davvero “La bellezza salverà il mondo”? Che cos’è questa bellezza capace di salvarlo?
Implicita nei discorsi dei fautori della bellezza è la convinzione che chi contempla il bello elevi il proprio spirito e si senta attirato verso l’alto, mentre chi contempla il brutto, degrada il suo spirito e si sente attirato verso il basso. Contemplare il bello esalta e nobilita. La magnificenza del bello conduce al divino, alla trascendenza. Anzi, la bellezza è salvezza e, quindi, coincide con la stessa divinità perché solo la divinità salva. La bellezza assume, dunque, un significato soteriologico: la bellezza salva e il salvato assurge dalla condizione di reietto, alienato, degradato, alla più sublime altezza. Non solo. Alla bellezza sono attribuite funzioni di riscatto e avanzamento morale. La bellezza diventa l’antidoto all’assenza di speranza, alle perenni umiliazioni della vita, alla presenza avvilente del male, all’inanità del quotidiano. Attraverso l’arte, la letteratura, la poesia, il teatro, il cinema – questa è la persuasione dei “fautori della bellezza” – si possono compiere miracoli per l’affrancamento e il miglioramento di chi vive in condizioni di miseria materiale e morale. “Abbandonatevi al bello, lasciatevi abbacinare dalla bellezza, e la vostra vita sarà migliore”, questo in definitiva il messaggio di chi crede nel dogma della bellezza salvatrice.
Ma le cose stanno davvero in questi termini? Proviamo a sottoporre al tribunale della ragione le pretese di chi ritiene che “la bellezza salverà il mondo”.
Alla base di questo topos della contemporaneità si trova l’idea fallace che la bellezza sia qualcosa di immediatamente percepibile sul cui riconoscimento tutti convergono univocamente in virtù di qualche facoltà innata e caratteristica del nostro essere umani.
In realtà, non esiste una bellezza assoluta e fuori dal tempo. Come dicono gli anglofoni, Beauty is in the eye of the beholder, ovvero “La bellezza è nell’occhio di chi guarda”. Ne era già consapevole nel XVIII secolo, il filosofo David Hume (1711-1776), il quale, nello scritto Of the Standard of Taste (1760), affermava: «La bellezza non è una qualità delle cose in sé: essa esiste meramente nella mente che le contempla; e ogni mente percepisce una bellezza differente. Un individuo può perfino avere un’impressione di deformità, laddove un altro ha un’impressione di bellezza».
Nell’arte, ad esempio, è noto che alcune rappresentazioni artistiche un tempo considerate brutte o discutibili (si pensi ai quadri di Van Gogh e Picasso) sono oggi considerate belle, mentre alcuni modelli di bellezza, come le donne dei dipinti di Rubens, non sono più attuali oggi (Pulvirenti, E., 2005). Come negare, poi, che anche la bruttezza esercita un suo fascino estetico e che alcune forme di deformità o mostruosità possono indurre pensieri elevati e nobili sulla vita e sull’arte al pari delle forme più armoniche?
Probabilmente, la formulazione più concisa ed efficace dell’idea della relatività della bellezza si deve a Voltaire (1694-1778), il quale nella voce del suo Dizionario filosofico dedicato al bello e alla bellezza scrive:
Bello, Bellezza. Chiedete a un rospo cos’è la bellezza, il bello assoluto, il to kalòn. Vi risponderà che è la sua femmina, con i suoi due grossi occhi rotondi sporgenti dalla piccola testa, la gola larga e piatta, il ventre giallo, il dorso bruno. Interrogate un negro della Guinea: il bello è per lui una pelle nera, oleosa, gli occhi infossati, il naso schiacciato. Interrogate il diavolo: vi dirà che la bellezza è un paio di corna, quattro artigli e una coda. Consultate infine i filosofi: vi risponderanno con argomenti senza capo né coda; han bisogno di qualcosa conforme all’archetipo del bello in sé, al kalòn.
Assistevo un giorno a una tragedia, seduto accanto a un filosofo. «Quant’è bella!», diceva. «Cosa ci trovate di bello?» domandai. «Il fatto,» rispose, «che l’autore ha raggiunto il suo scopo». L’indomani egli prese una medicina che gli fece bene. «Essa ha raggiunto il suo scopo,» gli dissi, «ecco una bella medicina!» Capì che non si può dire che una medicina è bella e che per attribuire a qualcosa il carattere della bellezza bisogna che susciti in noi ammirazione e piacere. Convenne che quella tragedia gli aveva ispirato questi due sentimenti e che in ciò stava il kalòn, il bello.
Facemmo un viaggio in Inghilterra: vi si rappresentava la stessa tragedia, perfettamente tradotta, ma qua faceva sbadigliare gli spettatori. «Oh! Oh!» disse, «il kalòn non è lo stesso per gli inglesi e per i francesi». Concluse, dopo molte riflessioni, che il bello è assai relativo, così come quel che è decente in Giappone è indecente a Roma e quel che è di moda a Parigi non lo è a Pechino; e così si risparmiò la pena di comporre un lungo trattato sul bello (Voltaire, 1981, pp. 49-50).
Se è vero che il kalòn non è uguale per gli inglesi e i francesi, è anche vero che, talora, la bellezza non solo non salva il mondo, ma lo perde. Pensiamoci. Per una bella ragazza si tradisce, si fa a pugni, ci si lascia corrompere, si uccide addirittura. Per una magnifica opera d’arte, si ruba e si commettono altri atti illegali. Alcuni grandi artisti, come Van Gogh ed Edvard Munch, hanno pagato con la malattia la loro creatività artistica. La contemplazione di un’opera d’arte può indurre forme patologiche più o meno gravi, come la cosiddetta “sindrome di Stendhal”, una neuropatologia di carattere psicosomatico che provoca vertigini, confusione mentale, svenimenti, allucinazioni, palpitazioni e attacchi di panico in chi si trova di fronte a un’opera d’arte (Magherini, 1992). Per la bella vita si vende l’anima al diavolo, come Faust.
Soprattutto, la bellezza è spesso superficiale ed effimera e, nella società contemporanea, viene spesso utilizzata per vendere, sedurre, ingannare, conquistare più che nobilitare. Essa, inoltre, genera tutta una serie di distorsioni nella mente delle persone.
La ricerca psicologica, ad esempio, ha dimostrato che alle persone belle sono di solito associate caratteristiche positive, come la bontà, l’onestà, l’affidabilità, la socialità, che in realtà, di per sé, non hanno nulla a che fare con la bellezza e che possono generare impressioni false o distorte. Si parla al riguardo di “effetto alone”: un singolo tratto – la bellezza – influenza la percezione di altre caratteristiche della persona (Capuano, 2021). Questo effetto viene utilizzato dalla pubblicità e dalla propaganda per favorire processi di acquisto o di consenso politico
È noto come uomini, donne, bambini e animali di aspetto gradevole siano costantemente rappresentati nella pubblicità per promuovere questo o quel prodotto. Meno noto è il fatto che perfino le nostre scelte politiche avvengono, spesso, non tanto sulla base di idee, valori e programmi, quanto dell’aspetto fisico di chi chiede il nostro voto. Una conclusione amara, da cui traiamo la lezione che la bellezza è spesso seduzione e fascino, mirati non a elevare quanto a sedurre e confondere la mente. Questo perché gli elettori – asseriscono alcuni studi – tendono a percepire le persone di aspetto gradevole come più competenti, sincere, oneste, carismatiche. Come già riconosceva Napoleone, «se si vuole appassionare la folla, bisogna prima di tutto parlare ai suoi occhi» (cit. in Costa, Corazza, 2006, p. 157).
In base al contesto, chi è bello è ritenuto, inoltre, anche più gentile, felice, fortunato, intelligente, intraprendente della media. Questo stereotipo è valorizzato nel cinema dove l’eroe virtuoso, altruista e buono è quasi sempre bello, mentre il criminale è quasi sempre brutto. Del resto, questo errore della mente è presente già nell’antica Grecia dove il corpo era considerato specchio dell’anima, per cui l’uomo virtuoso era anche bello: tutto ciò è sintetizzato nella nota diade kalòs kaí agathòs, dalla quale scaturisce anche il sostantivo kalokagathía, che conduce a un’immediata identificazione di bello e buono. In sostanza, ciò che è bello non può non essere buono e ciò che è buono non può non essere bello.
Anche nella Bibbia, in Genesi, l’aggettivo ebraico tôb (pronunciato tôv), spesso tradotto con “buono” in frasi come “Dio vide che era cosa buona”, potrebbe essere tradotto anche con “bello” dal momento che il suo significato oscilla tra “buono” e “bello”, a testimonianza del fatto che per gli antichi ebrei, come per noi consumatori contemporanei, bontà e bellezza coincidono o quasi.
La bellezza ha ripercussioni distorcenti anche in contesti scolastici e lavorativi. La ricerca psicologica ha rilevato che chi è bello tende a ricevere più messaggi positivi, verbali e non verbali, da parte degli insegnanti, il che aumenta la sua autostima e favorisce maggiori chance di successo scolastico. Inoltre, la bellezza attira maggiori aspettative positive rispetto alla bruttezza, circostanza che può favorire una maggiore attenzione e considerazione da parte degli educatori con inevitabili effetti positivi sul futuro scolastico della persona bella (Costa, Corazza, 2006, pp. 117-127).
L’apparenza esteriore è spesso ritenuta indice di maggiori capacità professionali e di qualità particolari. La bellezza è inconsciamente associata a maggiore stima di sé, ambizione e forza d’animo per cui, in ambito lavorativo, i valutatori tendono a preferire, a parità di condizioni, le persone di aspetto gradevole a quelle di aspetto sgradevole. Come affermano gli psicologi Marco Costa e Leonardo Corazza, «la bellezza è una sorta di diploma o di capitale umano che il mercato del lavoro riconosce e ricompensa finanziariamente» (Costa, Corazza, 2006, p. 143). Questo perché la bellezza facilita le relazioni di lavoro e i rapporti con i colleghi, accelera avanzamenti e promozioni di carriera, favorisce successo e popolarità.
Molti studi hanno, poi, rivelato che, se imputate in un processo, a parità di situazione giudiziaria, le persone di bell’aspetto tendono a ricevere sanzioni più miti rispetto agli imputati di aspetto sgradevole. La stessa distorsione agisce nel caso delle testimonianze: i testimoni di bell’aspetto sono generalmente considerati più credibili di chi ha un aspetto mediocre o brutto. Gli avvocati giudicati avvenenti guadagnano di più e sembrano avere una influenza considerevole sulla decisione finale di giudici e giurati (Costa, Corazza, 2006, pp. 152-153). E tutto ciò a dispetto dell’idea che la giustizia debba essere imparziale.
Rimanendo in ambito giudiziario, corollario dell’idea secondo cui “La bellezza salverà il mondo” è la convinzione che la “bellezza” debba essere identificata con la “cultura” e che solo questa possa risparmiare al mondo le brutture della criminalità. L’ignoranza genera delinquenza, che è cosa brutta. Cultura e conoscenza, invece, generano bellezza. Si leggano, dunque, libri in quantità e si sarà salvati!
Ora, è vero, in generale, che ignoranza e criminalità vanno spesso a braccetto. Studi e statistiche criminologiche mostrano una chiara correlazione fra mancanza di istruzione e delinquenza. I delinquenti comuni presentano maggiori carenze scolastiche rispetto al resto della popolazione. Inoltre, nelle loro carriere scolastiche troviamo spesso problemi disciplinari, assenze da scuola, punteggi più bassi. L’evasione scolastica, infine, è particolarmente associata a forme di delinquenza comune (Capuano, 2016).
L’equazione ignoranza = criminalità è, dunque, fino a un certo punto, giustificata. Non del tutto, però.
Già il padre della criminologia italiana Cesare Lombroso, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, faceva notare che esistono vari tipi di reato che richiedono un’istruzione generale e specifica, specialmente tecnica, di non poco conto, tanto che il criminale che vuole eccellere in essi deve essere molto abile e competente (cit. in Mannheim, 1975, vol. 2, p. 716). Come riassume il criminologo Hermann Mannheim nel suo imponente Trattato di criminologia comparata:
Le complicate transazioni finanziarie, le falsificazioni ordinarie o di opere d’arte, lo spionaggio, e molte altre forme di reati del colletto bianco richiedono non solo una intelligenza superiore alla media, ma anche cognizioni specializzate superiori a quelle degli ordinari cittadini rispettosi della legge, o a quelle della media degli scassinatori, dei borsaiuoli, dei ladri di negozi o di simili gruppi a bassa abilità (Mannheim, 1975, vol. 2, p. 716).
Oggigiorno, l’esecuzione di reati finanziari presuppone una conoscenza del funzionamento dei mercati e delle borse che pochi, anche tra le persone considerate colte, posseggono. Stesso discorso si può fare per i crimini informatici e per le azioni degli hacker: in alcuni casi, si tratta di possedere capacità e competenze che solo una élite di individui normalmente possiede.
Insomma, se l’ignoranza sembra condurre al crimine, anche competenze, conoscenze e saperi – ciò che passa abitualmente per cultura – possono produrre lo stesso risultato. Come osserva ancora Mannheim, «delitti molto gravi sono stati commessi da persone molto istruite […] le cacce medievali alle streghe erano quasi sempre organizzate da studiosi» (Mannheim, 1975, vol. 2, p. 717). Ciò non significa che l’istruzione debba essere criminalizzata, ma semplicemente che l’ignoranza non è l’unica variabile associata alla criminalità.
È dubbio, poi, che i libri producano sempre effetti positivi su chi li legge. Ne La città di Dio (426), Agostino racconta la vicenda di Teombroto, il quale, in seguito alla lettura di un libro di Platone sull’immortalità dell’anima, si gettò da un muro, passando così a quella che riteneva miglior vita (Agostino, 2015, p. 112). I Dolori del Giovane Werther (1774) di Goethe incoraggiò un’ondata di suicidi nei lettori più sensibili dell’epoca, tanto che si parla ancora oggi di “effetto Werther” per designare l’effetto imitativo prodotto dalla pubblicazione di notizie riguardanti suicidi nei mezzi di comunicazione di massa. Gli omicidi di Jesse Harding Pomeroy, assassino seriale del XIX secolo, furono imputati alle letture dei romanzi d’azione a buon mercato che circolavano all’epoca. Altri serial killer si dilettavano della lettura della Bibbia come David Berkowitz, John George High, Earle Leonard Nelson (Schechter, 2005, pp. 323-326). Mark David Chapman, l’uomo che nel 1980 uccise John Lennon, aveva con sé una copia del Giovane Holden di Salinger. Quando la polizia arrivò sul luogo del delitto, lo trovò che stava leggendo alcune pagine del romanzo. Infine, è noto come tante guerre religiose siano state combattute nel nome di alcuni libri (la Bibbia, il Corano ecc.).
Se è dubbio, quindi, che la bellezza, intesa come bellezza fisica, arte, letteratura, cultura (e potremmo aggiungere anche musica, teatro, cinema), abbia sempre effetti salvifici, perché il luogo comune – ormai uno slogan – “la bellezza salverà il mondo” ha tanta presa presso intellettuali, amministratori, politici, scienziati e persone comuni?
È possibile indicare almeno tre ragioni.
La prima ha a che vedere con la connotazione estremamente positiva che il concetto di “bellezza” ha assunto nella società contemporanea. La bellezza è la meta a cui tutti aspirano (basti pensare al boom della chirurgia estetica e dei ritocchi digitali), una vera e propria ossessione estetica che coinvolge ognuno di noi, minacciando talvolta la nostra autostima, ma imponendosi sempre come un dovere sociale a cui è quasi impossibile sottrarsi. La bellezza è il destino e la dannazione della contemporaneità.
La seconda riguarda il tema della salvezza. Nella nostra società secolarizzata, ci piace l’idea che a salvarci sia una qualità così immanente come la bellezza. Non si tratta più, come in Agostino, della bellezza divina, ma di una bellezza terrestre, materiale, capace, tuttavia, di innalzare i nostri animi a livelli di sublimità quasi divini. Una bellezza che non dobbiamo immaginare perché persa negli empirei delle religioni, ma che possiamo “toccare” con tutti i nostri sensi. Gli umani possono così ringraziare un “salvatore sensibile” a cui possono attingere quotidianamente senza l’intermediazione di preghiere o altri appelli alla divinità.
La terza e ultima ragione è di ordine cognitivo. La nostra mente predilige spiegazioni semplici e lineari degli eventi che accadono intorno a essa. In altre parole, ci piace l’idea di essere “salvati” da un unico rimedio che guarisca miracolosamente tutti i nostri mali, un’unica sostanza che metta a posto il mondo. In questo senso, la bellezza diventa, nella nostra epoca, il surrogato cognitivo della divinità, ormai scalzata dal trono dei medicamenti salvifici. Le nostre aspettative vengono così riversate su un’entità più empiricamente appagante di tante altre entità eteree, pur conservando una sua inebriante astrattezza concettuale.
Naturalmente, è possibile indicare una quarta ragione: lo slogan “la bellezza salverà il mondo” ha presa presso il pubblico semplicemente perché tutti lo ripetono in continuazione. E la ripetizione incessante di un luogo comune – lo sanno bene i persuasori di professione – è un’ottima tecnica per far credere che esso sia vero. La massima di Dostoevskij, dunque, è condannata a subire la sorte di tutti i luoghi comuni, ovvero a essere percepita come vera per eccesso di reiterazioni.
Riferimenti
Agostino, 405-410, Discorso 241.
Agostino, 2015, La città di Dio, Bompiani, Milano.
Capuano, R. G., 2016, 101 falsi miti sulla criminalità, Stampa Alternativa, Viterbo.
Capuano, R. G., 2021, Aloni, stregoni e superstizioni. Cinque studi sulla irrazionalità umana, PM Edizioni, Varazze (SV).
Costa, M., Corazza, L., 2006, Psicologia della bellezza, Giunti, Firenze.
Dostoevskij, F., 1868, L’idiota, in Idem, 1988, Tutti i romanzi, Sansoni, Firenze, vol. 1.
Hume, D. 1760, Of the Standard of Taste.
Magherini, G., 1992, La sindrome di Stendhal, Feltrinelli, Milano.
Mannheim H., 1975, Trattato di criminologia comparata, Einaudi, Torino, vol. 2.
Pulvirenti, E., 2005, “Sette luoghi comuni sull’arte”, Didatticarte, 2 aprile.
Schechter, H., 2005, Furia omicida, Sonzogno, Milano.
Voltaire, 1981, “Bello, bellezza” in Dizionario filosofico, Garzanti, Milano.