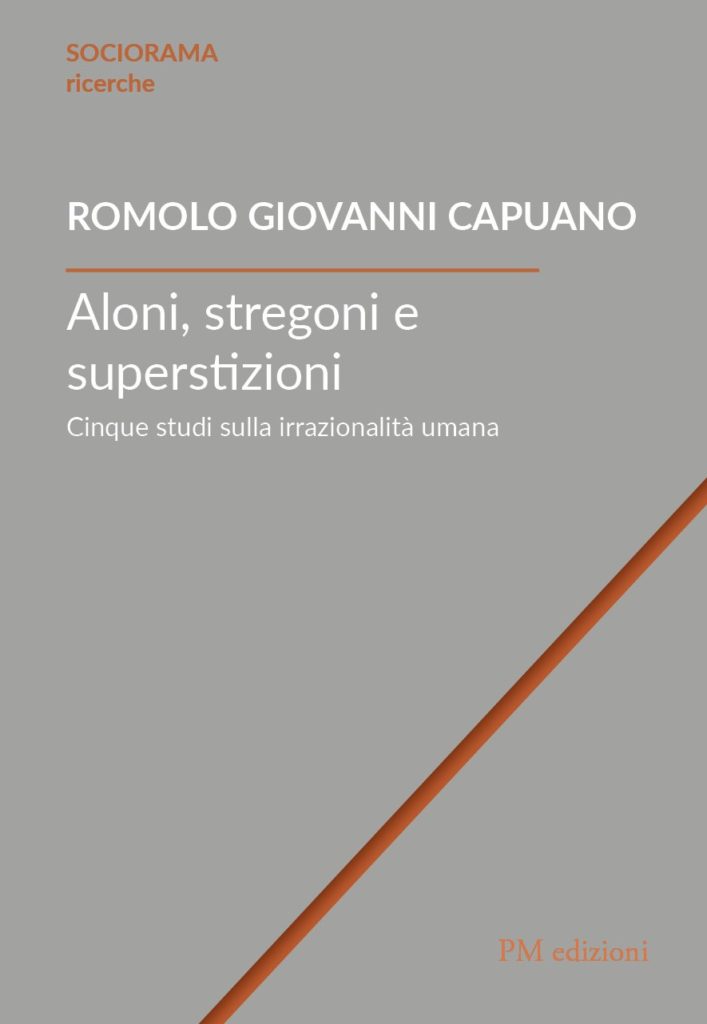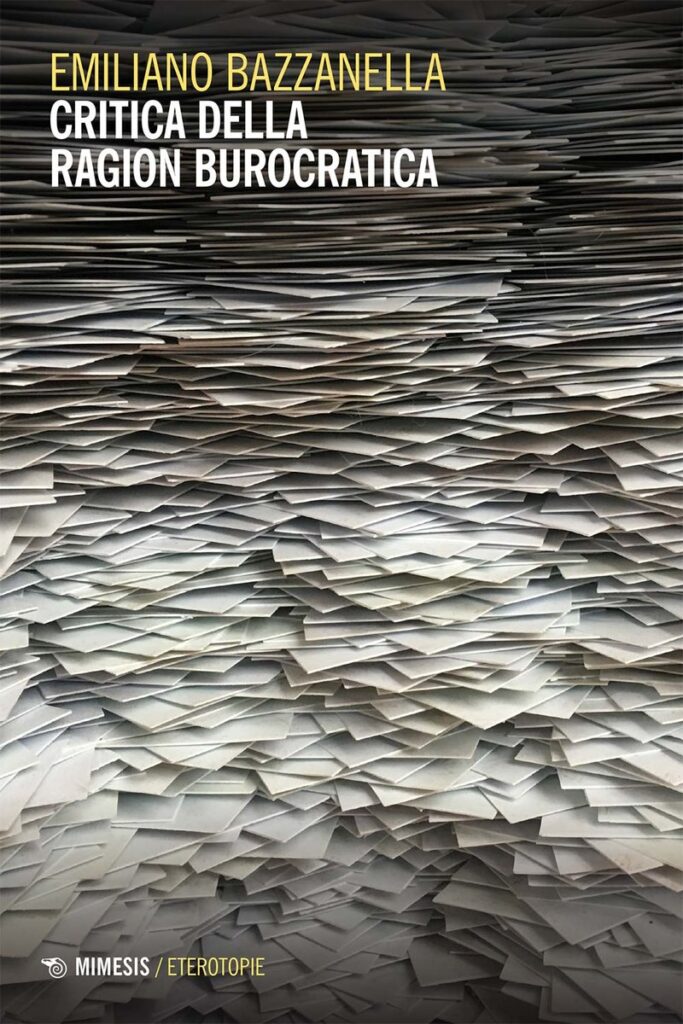In uno dei lavori più celebri della sociologia contemporanea, Asylum (1961), Erving Goffman, esamina le cosiddette istituzioni totali. Per il sociologo canadese, «un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato» (Goffman, 1968, p. 29). Oggetto privilegiato di analisi di Goffman sono soprattutto carceri e ospedali psichiatrici, ma, a mio avviso le sue riflessioni possono estendersi a realtà apparentemente insospettabili come le amministrazioni pubbliche. Anche l’amministrazione pubblica, infatti, può configurarsi come un luogo, se non di residenza, almeno di lavoro, di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un numero prestabilito di ore giornaliere e per molti anni – si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime parzialmente chiuso e formalmente amministrato.
Un’amministrazione pubblica non può evidentemente essere equiparata, da molti punti di vista, a un carcere o a un ospedale psichiatrico, ma il fatto che in essa si trovino riuniti gruppi di persone che, per anni e anni, condividono i medesimi luoghi, conoscenze, pratiche, forme organizzative, gerarchie ecc. per buona parte delle loro waking hours favorisce l’azione di meccanismi di adattamento che ricordano quelli in uso presso prigioni e ospedali psichiatrici.
A tal riguardo, Goffman conia i concetti di “adattamento primario” e “adattamento secondario”.
Quando un individuo contribuisce cooperativamente ad un’attività richiesta da una organizzazione, in determinate condizioni – con l’appoggio, nella nostra società, di modelli di assistenza istituzionalizzati, lo stimolo di incentivi e valori comuni, la minaccia di penalità designate – ne diventa un collaboratore; ne diventa cioè il membro «normale» «programmato» o «determinato». Dà e prende in modo appropriato ciò che è stato sistematicamente progettato, sia che la cosa comporti, da parte sua, un coinvolgimento notevole o minimo. In breve, gli viene ufficialmente richiesto di essere né più né meno di ciò che è preparato ad essere, ed è obbligato a vivere in un mondo che gli è, di fatto, congeniale. In questo caso dirò che l’individuo ha un adattamento primario all’organizzazione, tralasciando il fatto che sarebbe altrettanto ragionevole parlare dell’adattamento primario che l’organizzazione assume nei suoi confronti.
Ho usato questo termine impreciso per ottenerne un altro, quello cioè degli adattamenti secondari, che definisco come adattamenti abituali, per mezzo dei quali un membro di un’organizzazione usa mezzi od ottiene fini non autorizzati, oppure usa ed ottiene entrambi, sfuggendo a ciò che l’organizzazione presume dovrebbe fare ed ottenere, quindi a ciò che dovrebbe essere. Gli adattamenti secondari rappresentano il modo in cui l’individuo riesce ad evitare il ruolo e il sé che l’istituzione ha presi per garantiti per lui (Goffman, 1968, p. 212).
Tra gli esempi di adattamenti secondari, Goffman cita:
La prima cosa da notare è la prevalenza di usi individuali ricavati da oggetti disponibili. In ogni istituzione sociale coloro che vi fanno parte usano gli oggetti accessibili in un modo e per un fine non ufficialmente previsto, modificando così le condizioni di vita programmate per loro. In ciò può essere compresa la ricostruzione fisica dell’oggetto o semplicemente un modo illegittimo di usarlo: in entrambi i casi si tratta di esempi casalinghi del tema di Robinson Crusoe. I casi più ovvi ci provengono dalle carceri dove, per esempio, si ricava un coltello da un cucchiaio, inchiostro per disegno dalle pagine di un giornale illustrato, i quaderni sono usati per scrivere le scommesse e le sigarette vengono accese in tutti i modi – provocando un cortocircuito, con un accendino fatto in casa, un fiammifero tagliato in quattro (Goffman, 1968, p. 230).
In taluni casi, gli adattamenti secondari consentono di ricavare piccoli e grandi vantaggi personali, attività che Goffman definisce “lavorarsi il sistema”:
Considero ora una serie di pratiche che implicano una maggior partecipazione al mondo legale dell’istituzione. Il significato dell’attività legittima può essere conservato, ma può arrivare ad oltrepassare la meta prefissa; si assiste ad una sorta di ampliamento o elaborazione delle fonti di soddisfazioni illegittime, o alla utilizzazione, a fini personali, di interi cicli di attività ufficiali. In questo caso parlerò di «lavorarsi» il sistema (Goffman, 1968, p. 232).
Anche i dipendenti pubblici ricorrono a tutta una serie di adattamenti secondari per prendere le distanze dal proprio ruolo, vissuto spesso come noioso e poco gratificante.
Esempi di adattamenti secondari dei dipendenti pubblici sono: ridurre il proprio rendimento per “non stressarsi”; gironzolare per gli uffici con un foglio in mano per dare l’impressione di essere impegnati a fare qualcosa; entrare nella stanza del collega per iniziare una conversazione privata con la scusa di parlare di lavoro; leggere il giornale in ufficio; approfittare di un servizio esterno concesso per eseguire un compito lavorativo al fine di svolgere affari privati; compiere lavori extra per arrotondare; giocare al solitario in ufficio; spettegolare e lamentarsi dei colleghi o dei superiori.
A proposito di quest’ultima pratica, è noto in sociologia che il pettegolezzo ha la funzione di preservare, confermare e convalidare i valori collettivi della comunità, consolidare i legami normativi e la coesione di gruppo; mantenere l’unità e l’equilibrio del gruppo sociale e facilitare l’emersione di criticità e problemi che affliggono gli individui; indicare appartenenze di gruppo (chi ne fa parte “veramente”) e disseminare informazioni, anche riservate, sulle personalità dei suoi membri e sulle sue dinamiche interazionali. Il dipendente pubblico, dunque, nel mentre prende le distanze dal proprio ruolo spettegolando, ravviva e conferma i rapporti sociali nei quali è coinvolto nel proprio luogo di lavoro. Una funzione – questa del pettegolezzo – spesso trascurata a favore della sua netta condanna morale.
Anche il dipendente pubblico sa come “lavorarsi il sistema”. Tra i modi più comuni troviamo: usare il telefono, il computer, la stampante, lo scanner e altri strumenti per fini personali; sottrarre articoli di cancelleria per destinarli a uso privato; vendere servizi o merci private ai colleghi (alimenti prodotti in proprio, articoli di artigianato; organizzazione di eventi in locali intestati al coniuge); andare a prendere il caffè senza timbrare l’uscita; timbrare e uscire a fare la spesa.
Tutte queste condotte, abitualmente vituperate e che suscitano scandalo quando sono rese pubbliche, segnalano la necessità per il dipendente pubblico di non essere totalmente asservito a un ruolo percepito come umiliante e spersonalizzante: una sorta di meccanismo di difesa per allontanare dalla propria mente il peso considerevole di mansioni ripetitive e istupidenti che pure l’amministrazione dà per scontate.
Fonte: Goffman, E., 1968, Asylums, Einaudi, Torino.