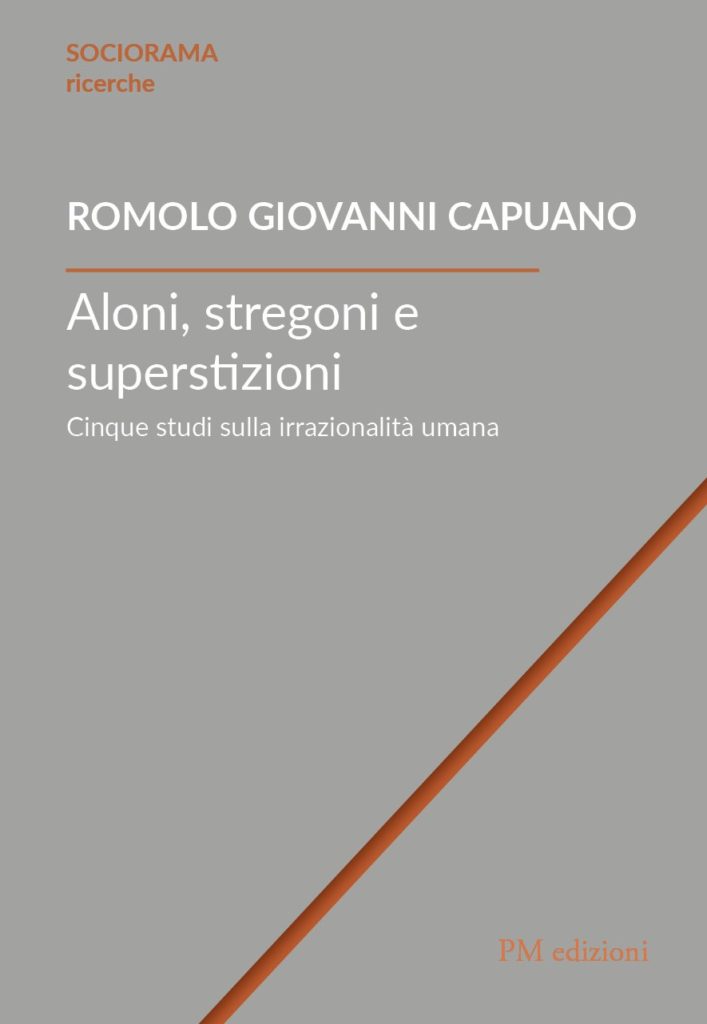Ne Il santo di Antonio Fogazzaro, pubblicato nel 1905 e messo all’indice dalla Chiesa cattolica pochi mesi dopo, Pietro Maironi, alias Benedetto, il protagonista del romanzo, è indotto da una improvvisa vocazione a condurre una vita monacale e profondamente religiosa, da cui è interamente assorbito. La pienezza del suo sentire religioso spinge il popolo a considerarlo un santo, in grado di guarire gli infermi e operare miracoli.
La fama di santo gli attira, però, antipatie, invidie e diffamazioni, in seguito alle quali viene convocato in Questura, dove un “funzionario pubblico”, con argomenti pretestuosi, tenta di persuaderlo ad abbandonare Roma, città in cui Maironi vive, per trovare casa all’estero o, comunque, lontano dalla capitale. Maironi si oppone alla decisione che altri, anche per motivi politici, oltre che di ordine pubblico, hanno preso per lui, ma, il funzionario ribatte proponendo una interessante teoria protosociologica sull’origine della santità:
La santità non è mai reale, è sempre, più o meno, una idealizzazione che lo specchio fa dell’immagine. Se c’è una santità è quella dello specchio, è quella della gente che crede ai Santi. Io non ci credo. […] Io non sono credente ma però apprezzo il principio religioso come elemento di ordine pubblico [perciò] il Governo non può avere piacere che si faccia un processo scandaloso a qualcuno che presso il popolo passa per santo: un processo che potrebbe poi anche provocare dei disordini (Fogazzaro, A., 1970, Il Santo, Mondadori, Milano, p. 266).
Per il funzionario governativo, la santità è una creazione sociale, il prodotto dei bisogni e delle necessità umanissime di una comunità che vive in un determinato luogo e in un determinato tempo. Donne e uomini che vivono in realtà contadine, sopraffatti da problemi concretissimi di alimentazione, abitazione, salute fisica e mentale, tendono a creare un santo taumaturgo, in grado di risolvere i problemi che la medicina ufficiale non è in grado di risolvere e a offrire opportunità di riscatto da un contesto percepito come infido, precario e pericoloso. Il santo è una idealizzazione, un precipitato di qualità indispensabili per superare i problemi dell’esistenza quotidiana; è uno specchio che riflette l’immagine di una comunità alienata, vinta dalla vita, schiacciata dal corso della storia.
La creazione del santo sortisce effetti di acquietamento sociale, di ordine pubblico in quanto i membri della comunità, affascinati dall’azione putativamente taumaturgica dell’uomo, si astengono dal riunire le proprie energie per contrastare l’ordine sociale responsabile della loro condizione di minorità. Il santo, in altre parole, come oppio sociale, come narcotico politico ed economico, come ipnotico dell’anima ribelle.
Non so se Antonio Fogazzaro fosse a conoscenza delle teorie sociologiche che, negli anni della composizione delle sue opere principali, tentavano di spiegare in termini di conflitto di classe i contrasti tra i membri delle società dell’epoca. Le osservazioni del suo funzionario governativo lasciano intravedere, però, una visione sociologica del mondo in cui il sacro è un prodotto eminente della società e il santo una risposta ai suoi bisogni più profondi.
Alla fine del romanzo, Pietro Maironi, alias Benedetto, muore sopraffatto dalla cattiveria degli uomini, forse inconsapevole dell’ambigua potenza della santità a lui attribuita. Ma, si potrebbe dire, morto un santo se ne fa un altro. Non a caso la storia del XX secolo è segnata dall’emergere di tanti santi “reali” – san Pio, santa Faustina Kowalska, santa Teresa di Calcutta ecc. – a cui il popolo cattolico si è rivolto per tentare di trovare un senso e una soluzione alle proprie vicende personali, minacciate da forze sociali avvertite come potenti e invincibili con mezzi umani.