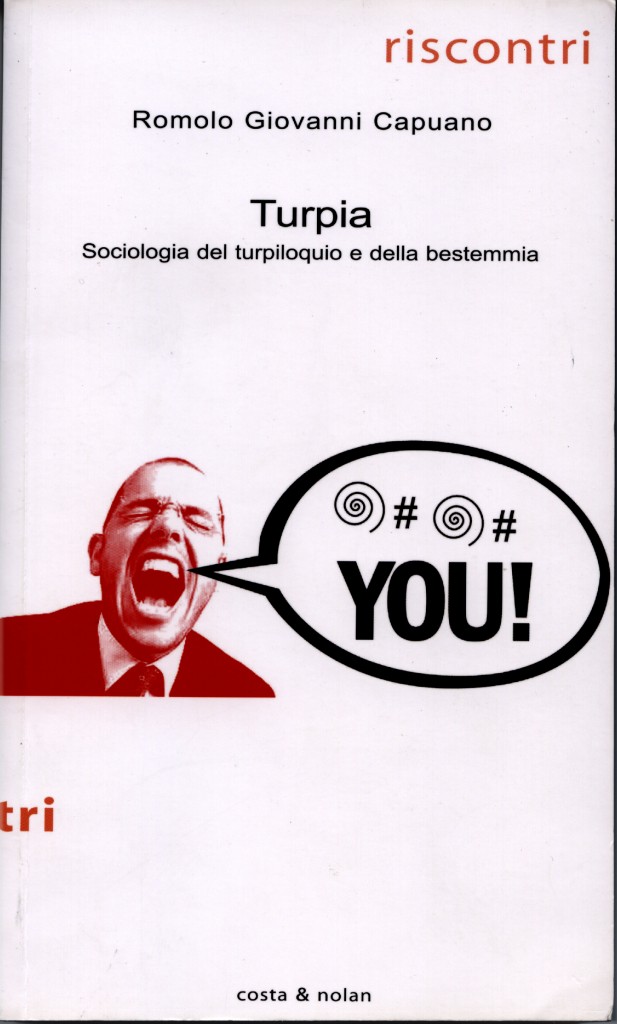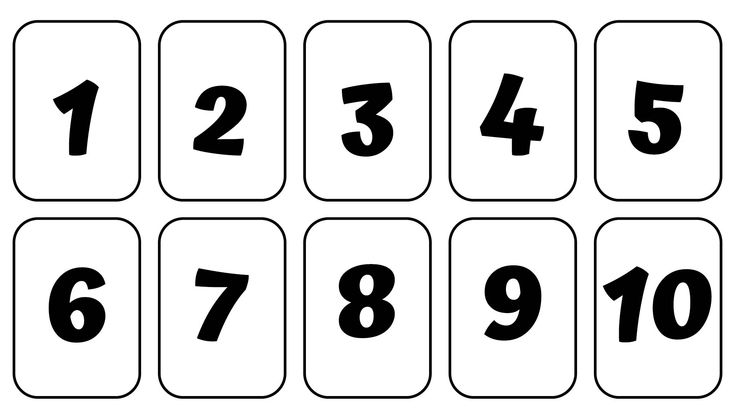Insultare, offendere, indulgere in atteggiamenti razzisti, anche nel calcio, sono condotte diffusamente vituperate. Ci aspetteremmo, dunque, che chiunque sia intervistato sul tema si esprima coerentemente con quello che viene ritenuto un sentire comune. Le cose, però, non stanno esattamente in questi termini.
Secondo un sondaggio CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) realizzato dalla SWG, società specializzata in ricerche di mercato, di opinione, istituzionali e studi di settore, tra il 24 e il 26 gennaio 2024, su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni, gli atteggiamenti al riguardo sono alquanto eterogenei ed esiste uno zoccolo duro che giudica positivamente l’offesa e l’insulto, anche a sfondo razzista.
Per il 20% del campione, ad esempio, seguire la propria squadra dal vivo porta ad un travolgimento emotivo per il quale è normale lasciarsi andare anche a comportamenti non proprio corretti.
Per metà circa degli italiani, insultare la propria squadra o il proprio campione in seguito a prestazioni negative, intimidire gli avversari e insultare l’arbitro sono un elemento del tifo. Per il 16% è normale scontrarsi fisicamente con i tifosi avversari. Per il 29% è normale utilizzare petardi e fumogeni. Per 1 italiano su 5 sono normali gli insulti ai giocatori legati alla loro nazionalità ed etnia.
Per l’8% del campione, allo stadio è tutto concesso, è giusto che i tifosi vivano le partite con intensità e si lascino andare.
Per il 18% è un elemento del tifo insultare un giocatore per la sua nazionalità o le sue origini etniche, oltre che definire un giocatore “zingaro” o “ebreo”. Per il 16% è normale fare il verso della scimmia o lanciare banane ai giocatori di colore
Tuttavia, dagli sportivi oggetto di insulti ci si attende un comportamento esemplare e, secondo il 74% degli italiani, uno sportivo dovrebbe cogliere queste occasioni per sensibilizzare le persone con le proprie azioni anche a rischio di assumere posizioni forti e ricevere squalifiche.
Sembra, dunque, che, per una parte degli italiani, il calcio sia da considerare una sorta di terra di nessuno in cui comportamenti proibiti in altre dimensioni della vita sono, invece, da considerare leciti. Eppure, tre quarti degli intervistati ritiene che sia necessario sensibilizzare sulle tematiche del razzismo nel corso degli eventi calcistici. Una sorta di schizofrenia, spiegabile forse con l’idea che l’offesa, l’ingiuria abbiano più che altro una finalità retorica nel calcio: l’obiettivo, cioè, è opporsi all’avversario in ogni modo possibile e, a tal fine, anything goes, come dicono gli inglesi.
Si tratta di dinamiche complesse e non sempre intuitive, che ho cercato di dipanare nel mio Hanno visto tutti! Nella mente del tifoso (Meltemi, Milano, 2020).