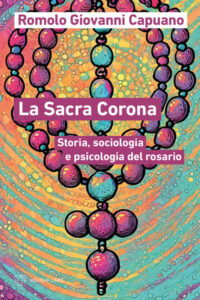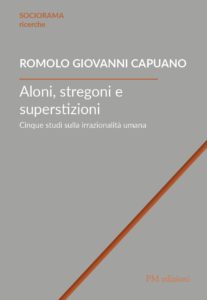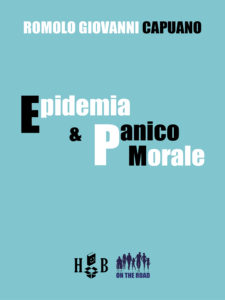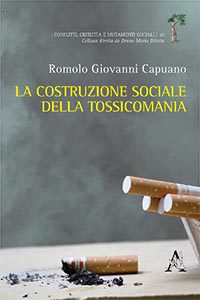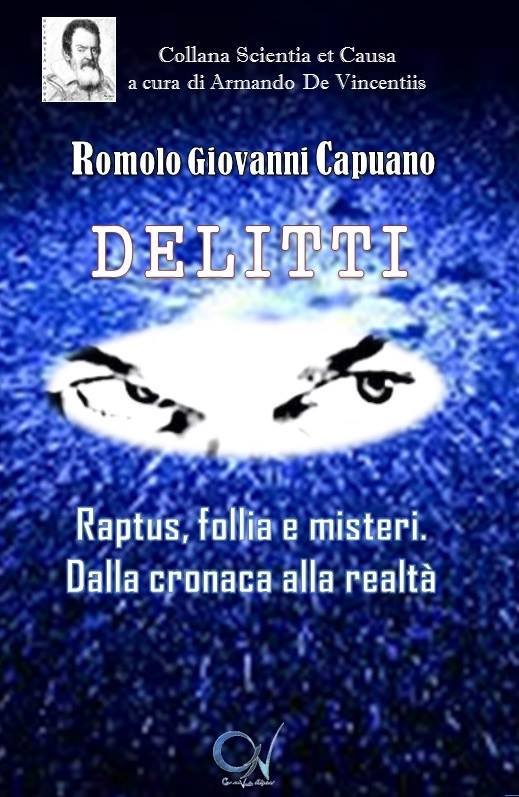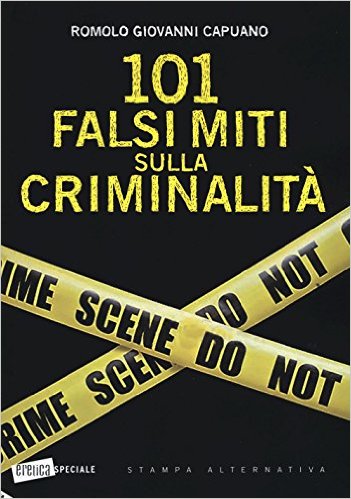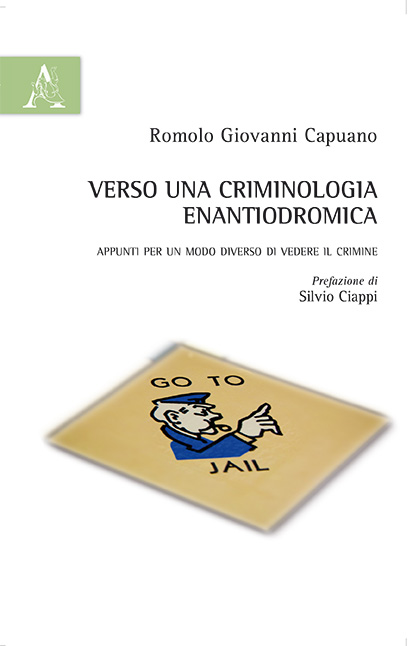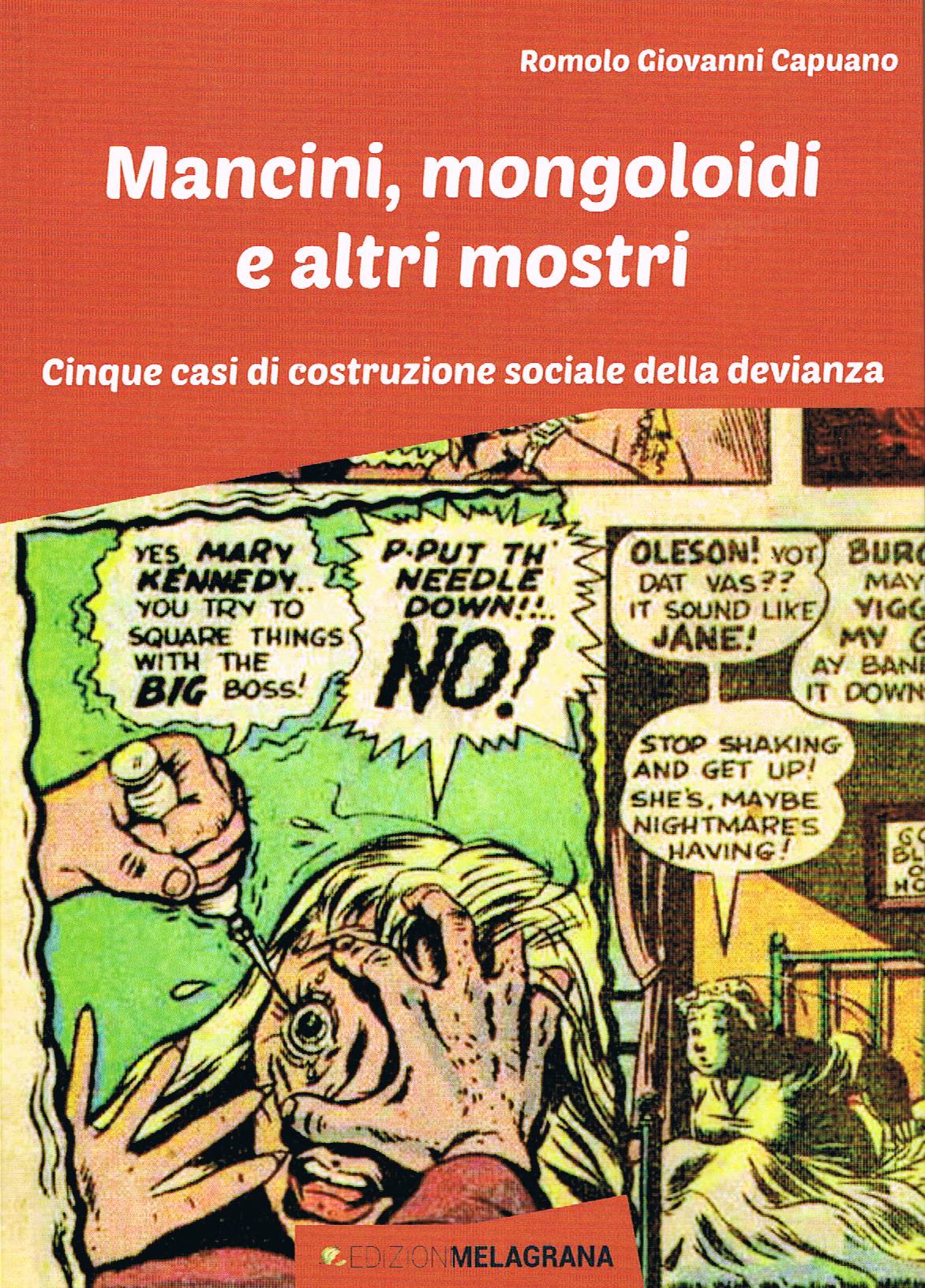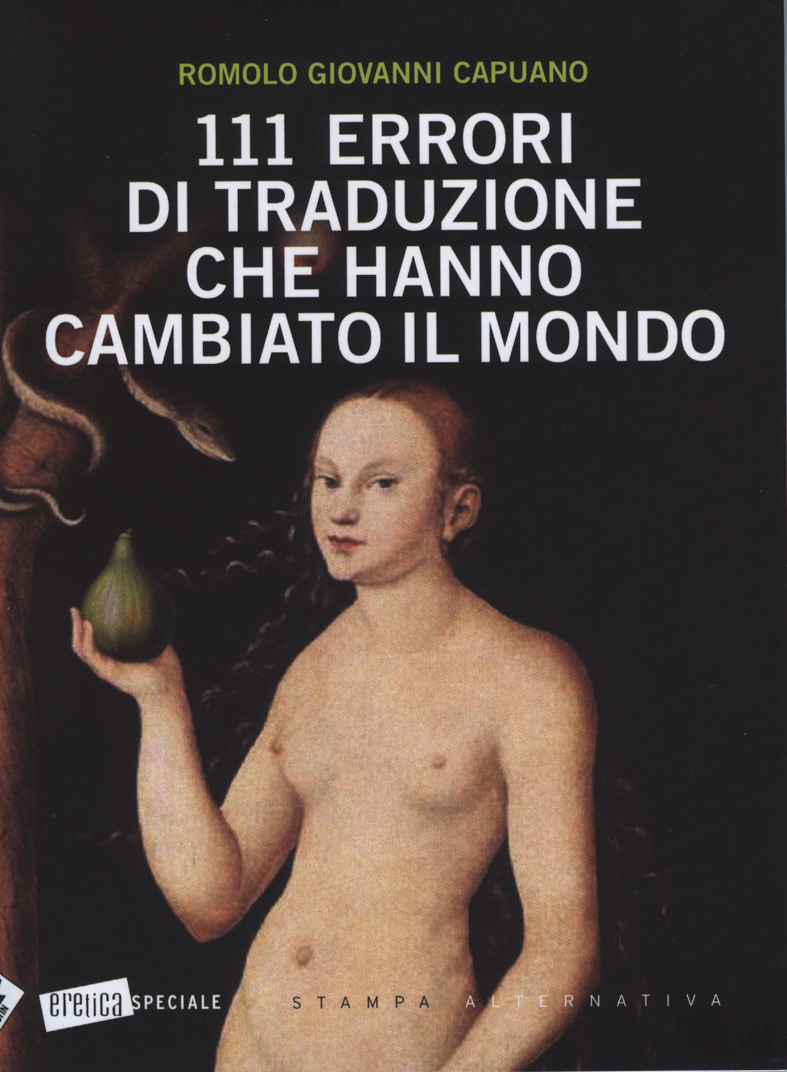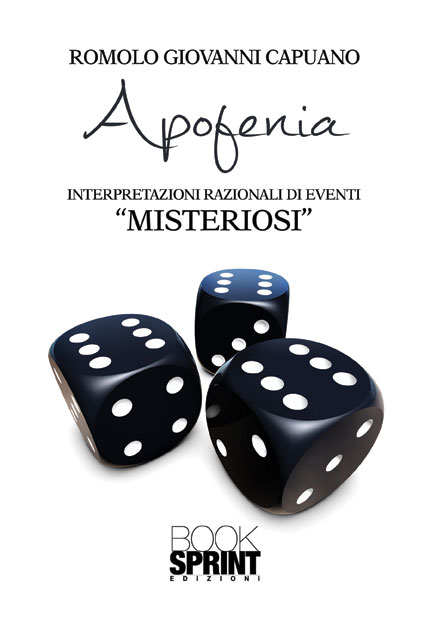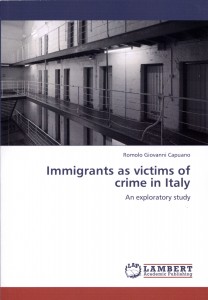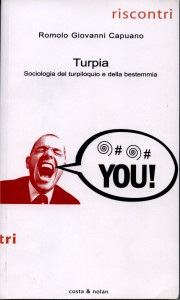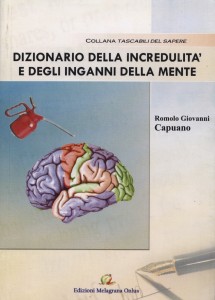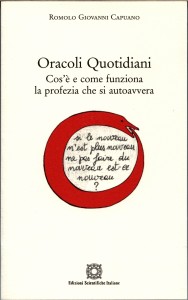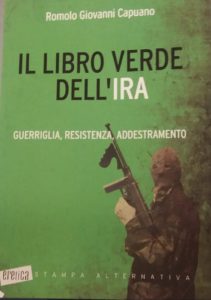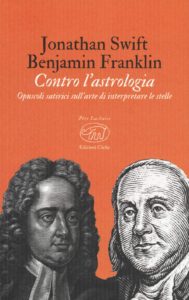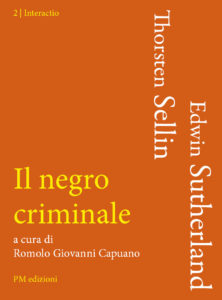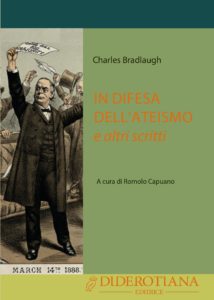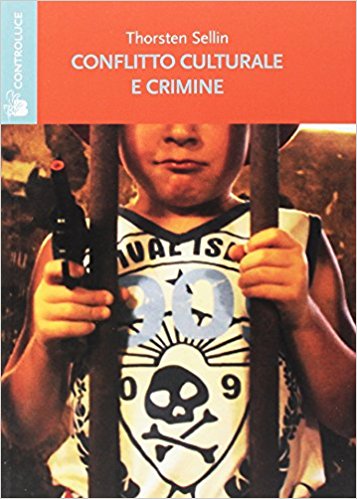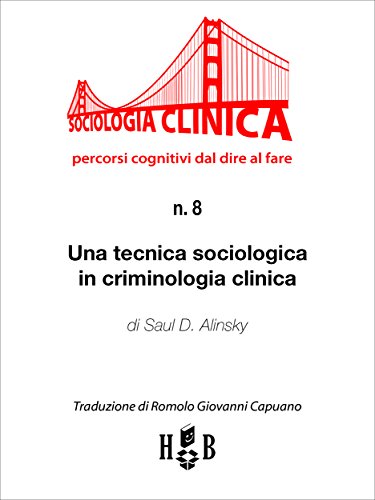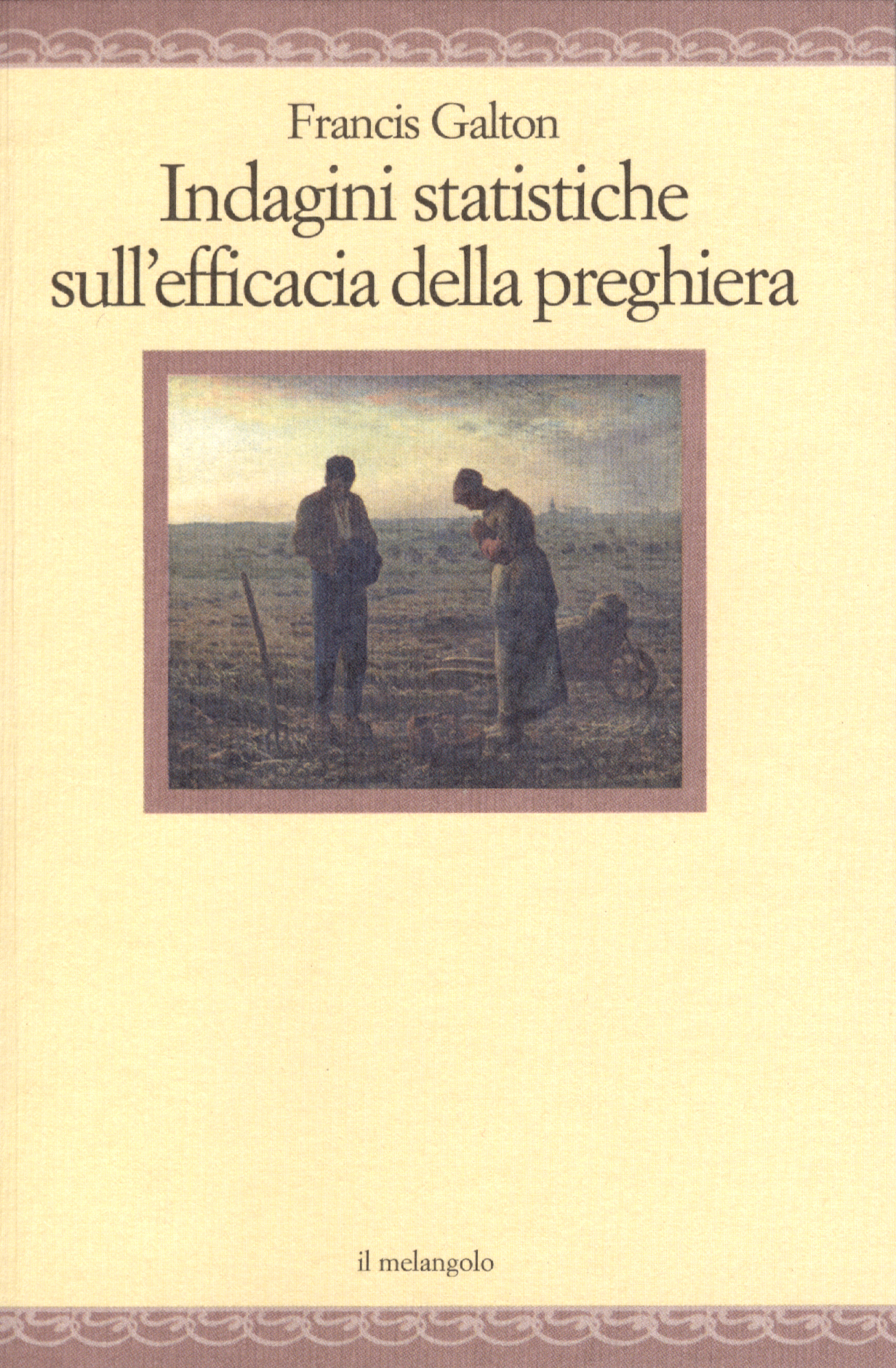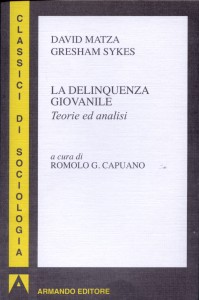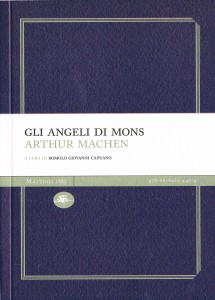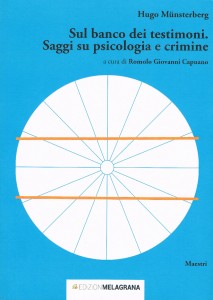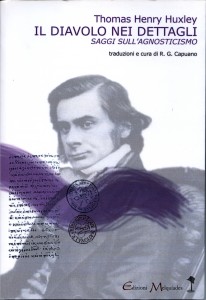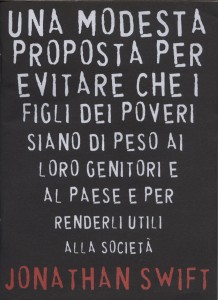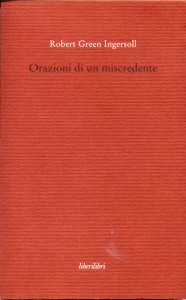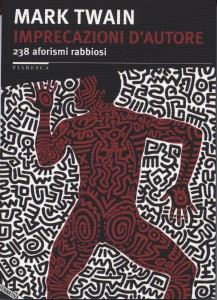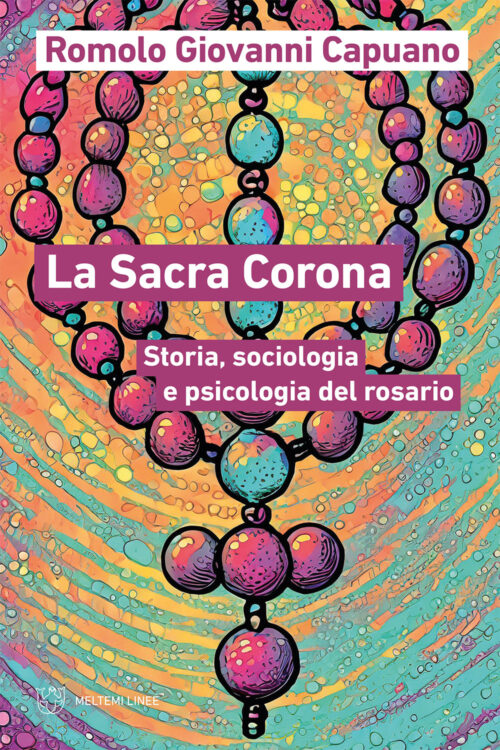
Romolo Giovanni Capuano
La Sacra Corona. Storia, sociologia e psicologia del rosario
Meltemi Editore, Milano
pp. 250, 2024
Nella nostra società secolarizzata e desacralizzata, il rosario è oggi considerato dai più una preghiera per bigotte e ottuagenarie, un patetico cascame di una religiosità destinata ad estinguersi, un’inutile giaculatoria di un tempo che fu, una devozione relegata a un numero trascurabile di imperterriti fanatici cattolici.
Eppure, il rosario è molto più di questo. La sua storia sorprendente comprende una narrazione mitologica, leggende varie, falsi storici acclarati, verità celate e inaccettabili, colpi di scena degni di un romanzo, curiosità inestimabili, equivoci tragici e ridicoli, eroi putativi ed eroi autentici, conflitti spirituali e materiali, difensori a spada tratta e oppositori virulenti.
Il rosario è un “oggetto culturale” interessante anche da un punto di vista sociologico e psicologico. Ad esso, ancora oggi, sono attribuiti cambiamenti di fede, guarigioni, successi militari, miracoli di ogni genere. In nome del rosario sono istituiti santuari e confraternite. Il rosario è presente in molte raffigurazioni pittoriche e artistiche. Lo troviamo nella letteratura, nella musica, nel cinema e nella cultura pop (Madonna e Lady Gaga, ad esempio). La sua presenza non è affatto limitata all’ambito religioso.
Per molti, la sua recita orienterebbe gli eventi del mondo in una determinata direzione e sarebbe stata decisiva nello stabilire l’esito di eventi importanti come la battaglia di Lepanto del 1571. Consentirebbe, inoltre, ai suoi devoti di essere immuni da eventi apocalittici, come l’esplosione della bomba atomica!
Alla recita sistematica del rosario sono inoltre associati precisi effetti psicosociali, psicofisici, comunicativi, persuasivi, pragmatici. Ad esempio, la storia ha dimostrato che esso può svolgere una funzione narcotizzante e anestetica nei confronti delle proteste sociali e religiose con la conseguente soppressione di ogni anelito rivoluzionario. Sociologicamente, esso si configura come un dispositivo disciplinare per tenere buone le masse e impedire loro di pensare con la propria testa. Ma il rosario può instillare anche pace e tranquillità, oltre che essere esibito come simbolo identitario ed estetico.
Insomma, il rosario è un oggetto estremamente complesso sul quale convergono suggestioni sociologiche, psicologiche, antropologiche, storiche, mediche insospettabili, che lo rendono singolarmente unico.
Attraverso un’analisi condotta con gli strumenti delle scienze umane, il testo propone, per la prima volta, una approfondita analisi storica e psicosociologica del rosario, illustrando la polifonia, la ricchezza semantica, le contraddizioni, ma anche l’importanza di un dispositivo ingiustamente trascurato, ma che ha avuto e ha ancora un ruolo importante nell’immaginario collettivo, non solo dei cattolici, e che ha ricevuto ampia tematizzazione da parte delle autorità cattoliche dal Medioevo ad oggi. Al riguardo, va ricordato che il rosario è la devozione extraliturgica più famosa associata al cattolicesimo.
Il tentativo è quello di avvicinare intellettualmente il rosario come fatto sociale complesso nella convinzione che il suo studio riveli aspetti interessanti dell’agire umano e religioso in particolare.
Da questo punto di vista, il volume cattura l’attenzione di sociologi, psicologi e storici, in primis, è di chiunque sia desideroso di vedere applicata a un oggetto apparentemente banale l’immaginazione sociologica di cui parlava Charles Wright Mills. Ne risulta un quadro estremamente accattivante e variegato in cui santi, sacerdoti e pontefici procedono a braccetto con sociologi, psicologi e storici come non è mai accaduto nella storia di una devozione religiosa. Un quadro che interesserà uomini di fede profonda come agnostici e atei radicali; studiosi e semplici curiosi. In definitiva, un libro per tutti.
Addenda
-
Indice e Introduzione. Le prime pagine del libro per entrare nell’atmosfera del testo.
-
Scritti sul rosario. Le voci “Rosario”, “Festa del Santo Rosario” e “Confraternita del Santo Rosario”, scritte dal gesuita Herbert Thurston (1856-1939) nel 1912 per la Catholic Encyclopedia, ancora oggi esempi mirabili di applicazione del metodo storico-critico alla religione. Da queste pagine straordinarie sono partito per un esame critico della storia del rosario e dei fenomeni sociali e religiosi a esso connessi. Una scoperta sensazionale che intrigherà anche il lettore italiano. Con una mia introduzione.
-
“La Santa Casa di Loreto“, altro articolo pubblicato da Herbert Thurston nel 1912 per la Catholic Encyclopedia, è un succoso esempio della inclinazione scettica del sacerdote gesuita nei confronti delle devozioni cattoliche. Un testo che riassume in maniera esemplare una vicenda su cui ancora oggi si discute.
-
Il Rosario. Studio storico-critico di Tito Signorelli (1932) è un esempio di come i protestanti hanno visto e vedono il rosario, oggetto “papista” per eccellenza. Al tempo stesso, le critiche in esso contenute offrono al lettore un punto di vista diverso e stimolante sul rosario fra centinaia di opuscoli, libri, manuali di parte cattolica che lo esaltano incondizionatamente. Qui la mia trascrizione (con una breve introduzione) di uno scritto ormai introvabile.
-
L’atto unico Il rosario (1899) di Federico De Roberto (1861-1927) vede come protagonista assoluta la devozione di san Domenico, rappresentata come un rituale quotidiano che, al tempo stesso, permette e ostacola la conversazione all’interno della famiglia. Probabilmente, la più importante espressione letteraria del rosario nella letteratura laica.
-
Er Rosario In famijja (1832) di Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) è un’ulteriore testimonianza letteraria sulla diffusione e importanza popolare della devozione del rosario e del suo radicamento nella psicologia delle classi subalterne. Da leggere.
-
Perché si dorme in chiesa? Che cosa spinge gli umani tra le braccia di Morfeo mentre assistono a una funzione religiosa? In questo delizioso sermone di Jonathan Swift, intitolato “Sul dormire in chiesa” (1776), tutti i motivi per cui “l’oppio non sortisce i medesimi effetti intorpidenti di un sermone quotidiano”.
-
Che effetti aveva il latino sulle masse incolte? Come venivano interpretate nei secoli scorsi le parole di un’altra lingua a cui veniva attribuito un significato sacro? Il latinorum di manzoniana memoria è davvero una lingua morta o si è radicato indelebilmente nella nostra mente? Da una lettera dal carcere di Gramsci, una risposta a questi interrogativi sotto forma di mistero: il mistero di “donna Bisodia”.
-
La lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae (2002) di Giovanni Paolo II che ha dato origine alla quarta corona del rosario e alla meditazione sui “misteri della luce”. Per chi crede che il rosario sia una faccenda solo medievale.