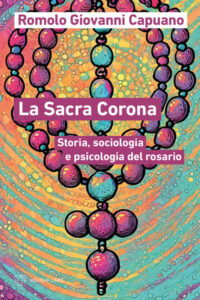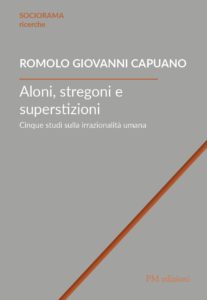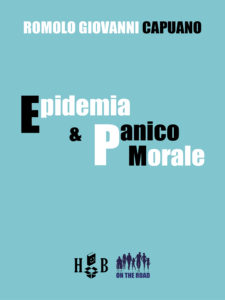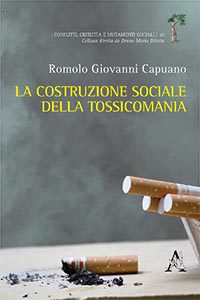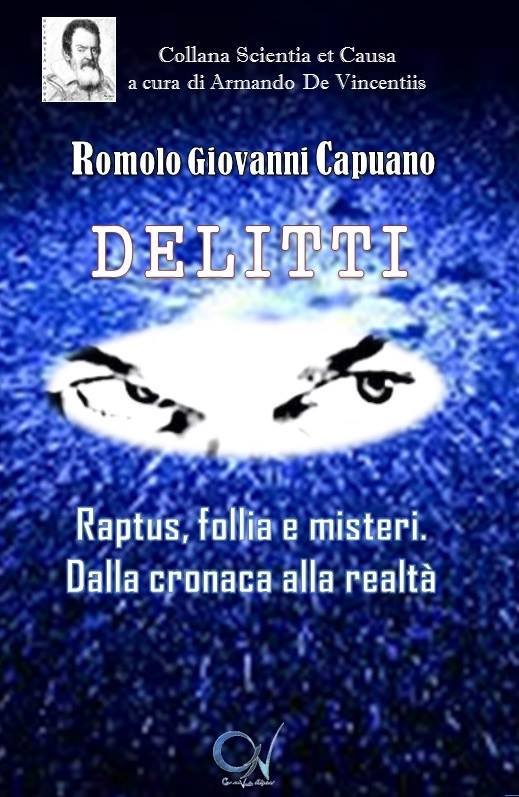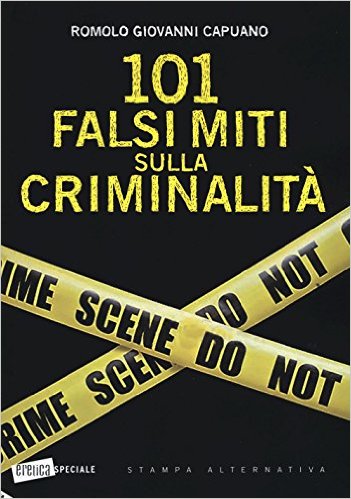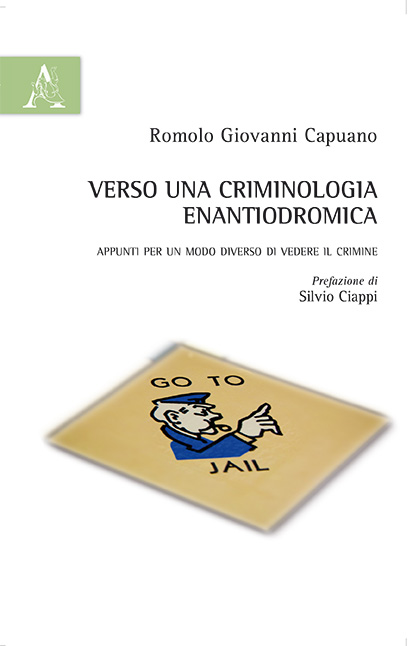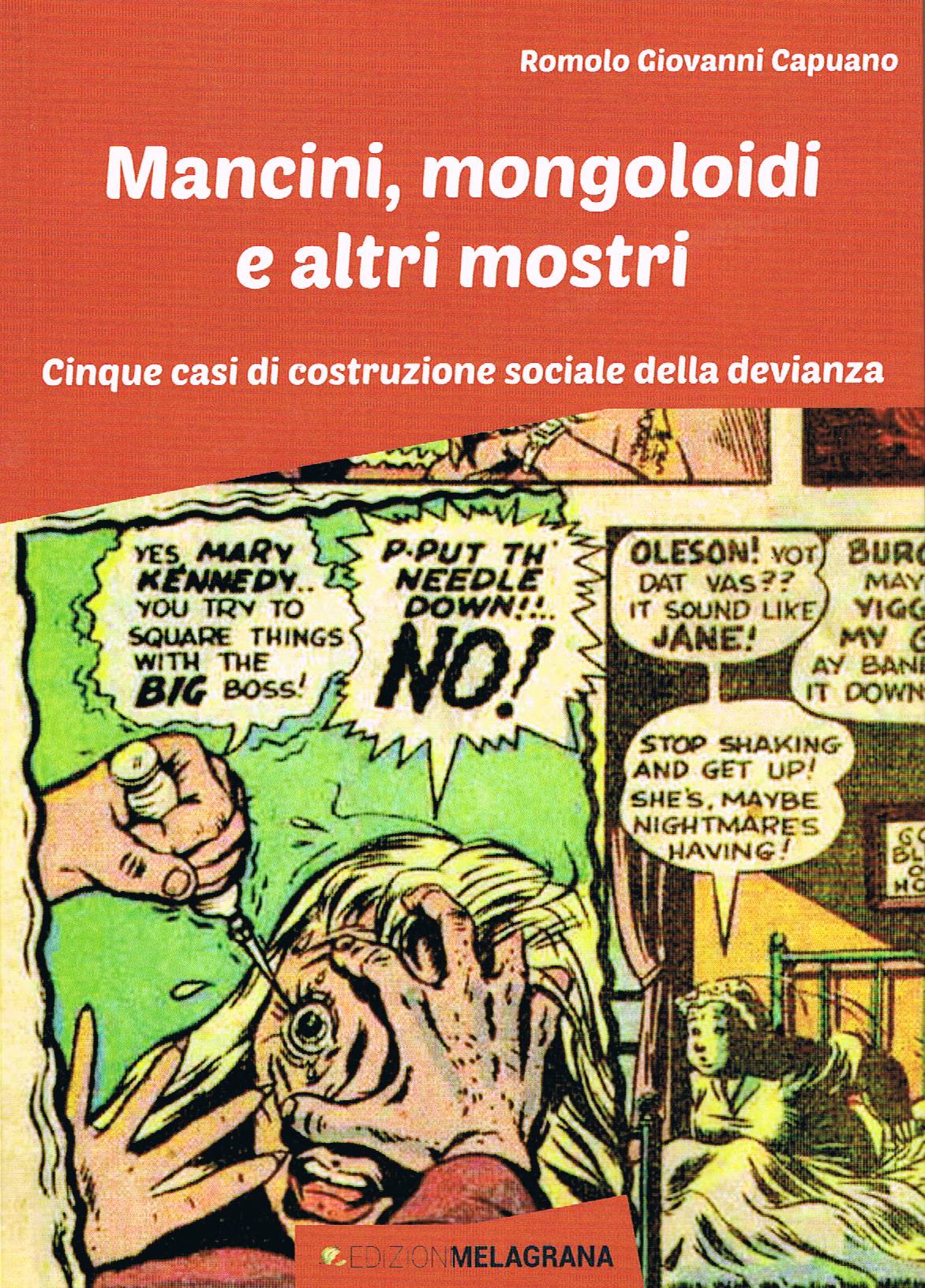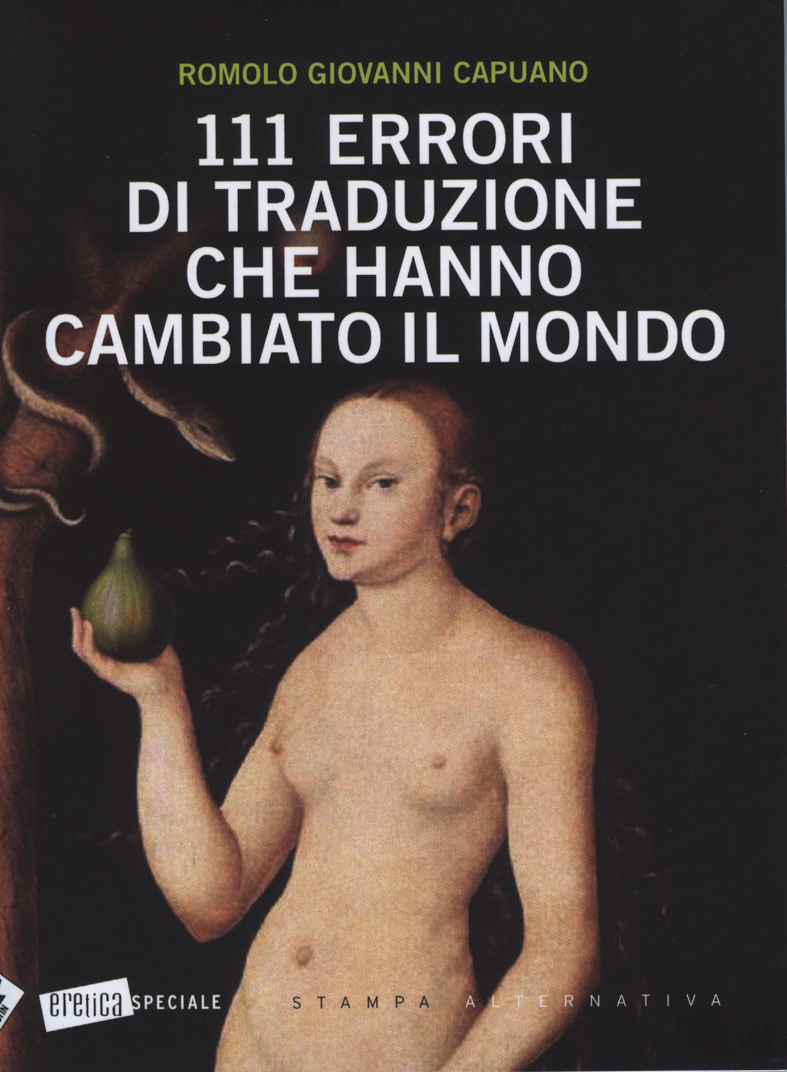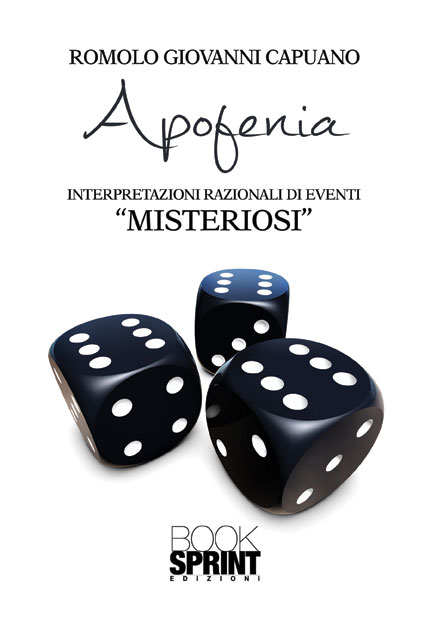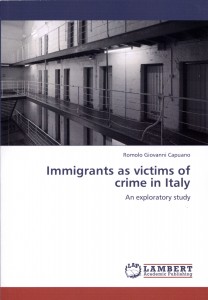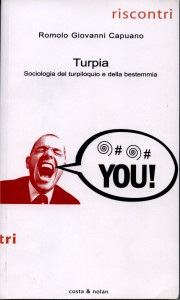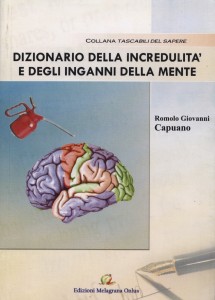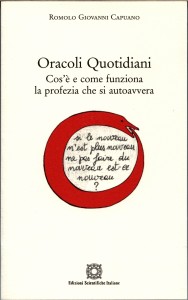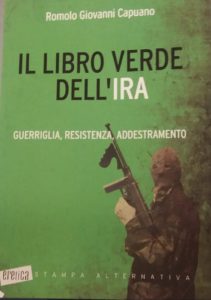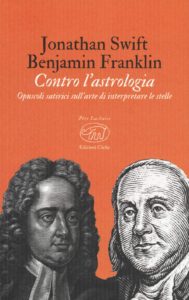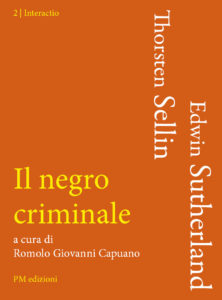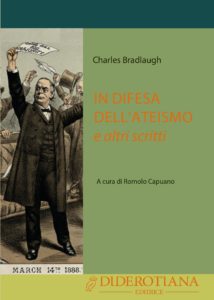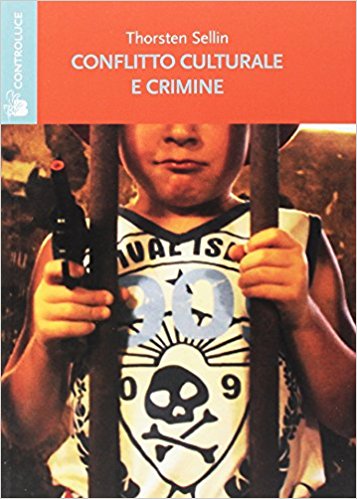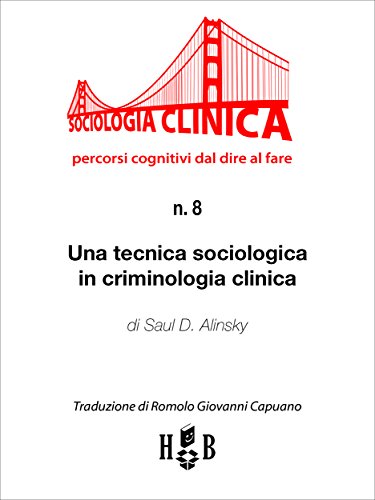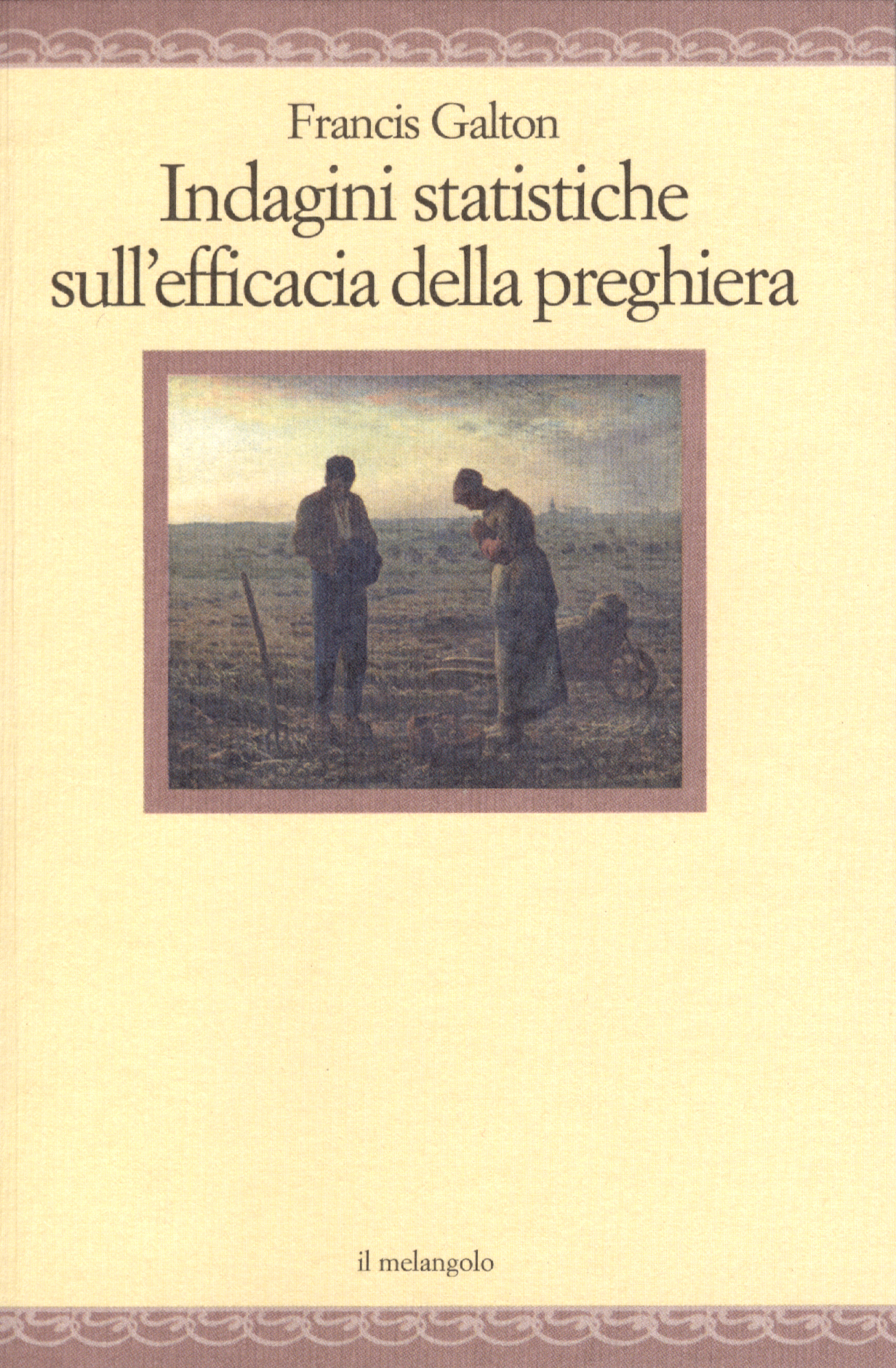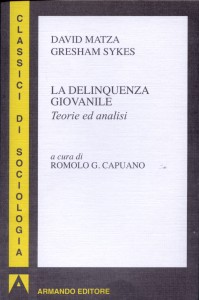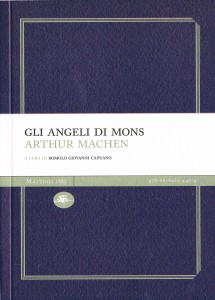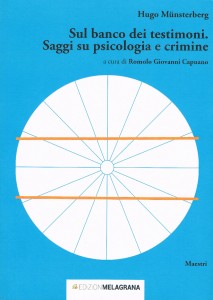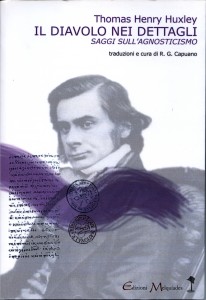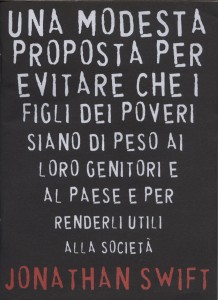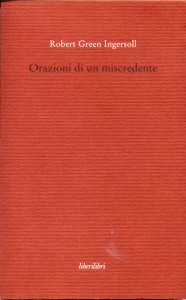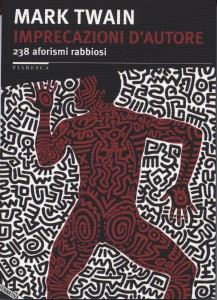I numeri caratterizzano e definiscono le nostre vite come mai in passato. La quantificazione dei fenomeni sociali – dall’istruzione alla povertà, dal lavoro al tempo libero, dalla sessualità alle attività amministrative – è talmente pervasiva da essere data per scontata. Eppure, avvertono i sociologi Espeland e Stevens nel loro pioneristico “A Sociology of Quantification”, la quantificazione, intesa come la produzione e la comunicazione di numeri, e le sue conseguenze sull’organizzazione e sulla vita moderna, è stata raramente esaminata da un punto di vista sociologico.
Se l’attenzione (e la preoccupazione) per l’accuratezza dei numeri prodotti è un aspetto costante di ogni organizzazione che si occupi di produrre cifre, minore attenzione è volta alle implicazioni sociali di tale “numerificazione” della vita quotidiana.
Si pensi, ad esempio, alla demografia. Se essa ha il compito di fornire una rappresentazione quanto più precisa possibile delle dimensioni delle popolazioni nazionali, una delle sue conseguenze è quella di creare categorie ad hoc di cittadini, cui viene spesso attribuito uno status ontologico e che sono oggetto costante di politiche di vario tipo. Le statistiche fornite dalla demografia non servono solo a “contare” i cittadini, ma ad assumere provvedimenti nei loro riguardi, a confrontare categorie con categorie, a individuare bacini elettorali e target pubblicitari ecc.
I numeri possono, inoltre, essere utilizzati come segni distintivi (marks) e come strumenti di misurazione per produrre valutazioni di ogni tipo. Si pensi ai prezzi delle merci, che servono a valutare il valore di beni e servizi, al conteggio dei voti, che consente la vittoria ad alcuni schieramenti politici a scapito di altri, al sistema dei voti scolastici, che consente di valutare il rendimento degli studenti. In tutti questi casi, una delle conseguenze più diffuse è la cristallizzazione, se non la feticizzazione, del numero a scapito di ciò che il numero dovrebbe misurare.
Un esempio su tutti è fornito proprio dal sistema dei voti scolastici. Da un lato, essi dovrebbero consentire di valutare in maniera “oggettiva” l’apprendimento e la cultura degli studenti. Tutti sanno, però, che essi finiscono con il diventare un obiettivo in sé con la conseguenza paradossale che non importa ciò che si è effettivamente imparato, ma il voto raggiunto, spesso espressione della conformità a procedure didattiche prestabilite o dell’adesione a programmi stabiliti dal ministero.
Oppure, si pensi al conteggio dei like ricevuti sui social, ritenuto un indicatore di qualità, ma, in realtà, indice di popolarità o di uso sapiente dei social stessi.
Quando il numero diviene fine a se stesso, si genera una forma di patologia che il sociologo americano Otis Dudley Duncan, in relazione alla statistica, definisce “statisticismo”, ossia:
l’idea che numero sia sinonimo di ricerca, l’ingenua fede che la statistica sia uno strumento completo o sufficiente per fare metodologia scientifica, la superstizione che esistano formule statistiche per valutare cose come i meriti relativi di diverse teorie sostanziali o l’“importanza” delle cause di una “variabile dipendente”; e l’illusione che la scomposizione delle covariazioni di un insieme arbitrario e casuale di variabili possa in qualche modo giustificare non solo un “modello causale” ma anche un “modello di misurazione (Duncan 1984, Notes on Social Measurement: Historical and Critical (New York, Russell Sage Foundation, p. 226).
Espeland e Stevens pongono in risalto anche un altro aspetto. La produzione e la comunicazione di numeri richiede l’istituzione di grossi apparati burocratici e organizzativi composti da personale adeguatamente formato, il cui lavoro è interamente dedicato a questo scopo. La quantificazione richiede, dunque, il possesso di precise competenze numeriche, acquisite, solitamente, nell’ambito di precisi percorsi didattici, e forme di cooperazione e controllo non dissimili da quelle che si hanno in altre organizzazioni.
I numeri forniscono anche una forma di legittimazione a scelte di ogni tipo – politiche, didattiche, culturali, economiche ecc. – in un modo che è oggi considerato assolutamente imprescindibile. Chiunque si rispetti ha bisogno di appoggiare argomentazioni, opinioni e tesi su statistiche, calcoli, grafici, forma di “garanzia retorica” paragonabile alle “garanzie” che, qualche tempo fa, fornivano i testi sacri della religione. Tale legittimazione conferisce ai numeri una forza persuasiva unica che demagoghi e pubblicitari conoscono bene.
I numeri forniscono anche un linguaggio comune per porre a confronto strategie, tesi, opinioni che non potrebbero che essere espressi in forma “qualitativa” e, quindi, non comparabile. Ad esempio, la quantificazione consente di conformarsi a standard predefiniti che consentono di pervenire agevolmente a valutazioni di ogni genere.
Le misurazioni numeriche agiscono anche sul modo in cui gli individui pensano e si comportano. Trasformando qualità in quantità, creano nuovi “oggetti” e nuove relazioni tra oggetti. Quando, ad esempio, Kinsey nel 1948 affermò che il 37% dei maschi bianchi da lui intervistati avevano avuto almeno una esperienza omosessuale nella loro vita “creò” una nuova categoria di individui che influenzò sensibilmente l’evoluzione dei moderni movimenti per i diritti delle persone omosessuali, fornendo una legittimazione statistica alle richieste degli stessi.
I numeri, infatti, tendono a creare categorie di individui dai confini più nitidi e meno incerti di quanto accada nella realtà, per cui sfumature e processi graduali acquistano improvvisamente una nettezza che prima non possedevano. Allo stesso tempo, tale nettezza esercita una funzione “disciplinante” nei riguardi dei membri di tali categorie, conferendo loro tratti distintivi precisi e richiedendo loro di conformarsi a tali tratti in maniera ordinata e coerente, pena l’accusa di devianza.
Come si vede i numeri sono più di un semplice strumento di individuazione o misurazione. Essi hanno implicazioni sociali notevolissime, che spesso comportano conseguenze di assoluto rilievo di cui non abbiamo consapevolezza. Di qui l’utilità di una sociologia della quantificazione che, al momento, sta compiendo solo i primi passi.
Fonte:
Espeland, W. N., Stevens, M. L., 2008, “A Sociology of Quantification”, European Journal of Sociology, vol. 49, n. 3, pp. 401-436.