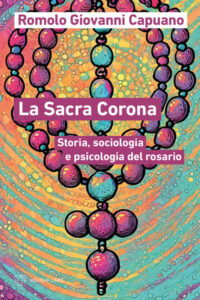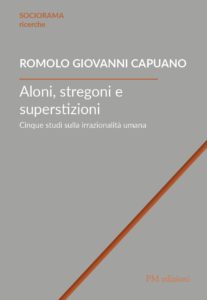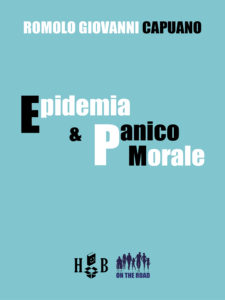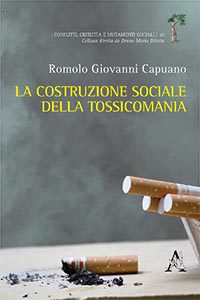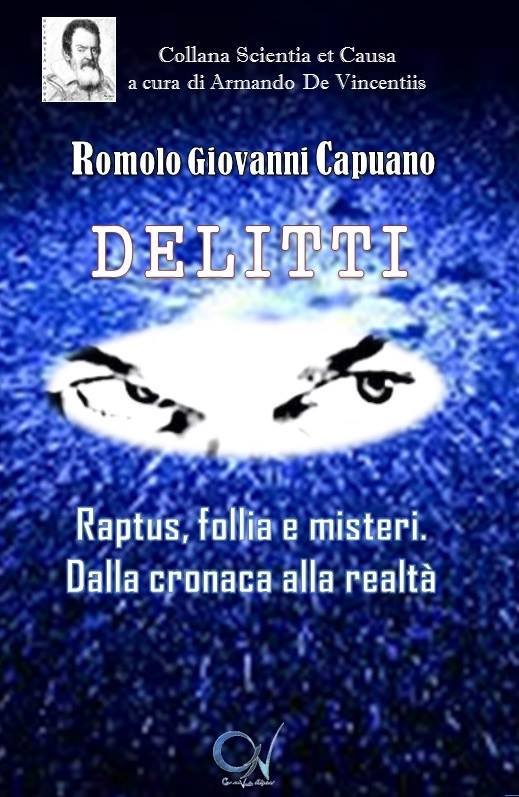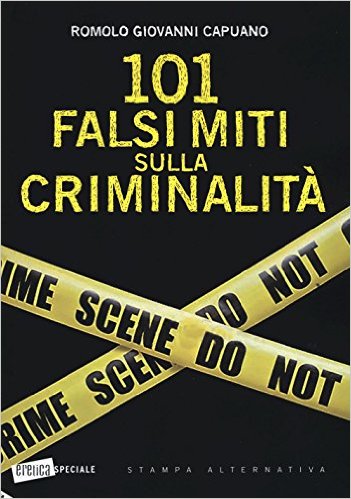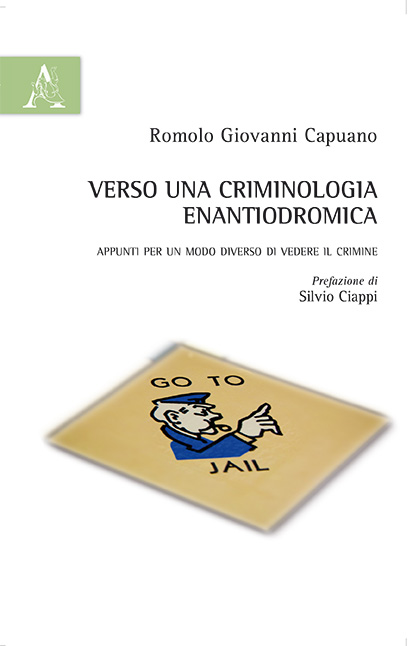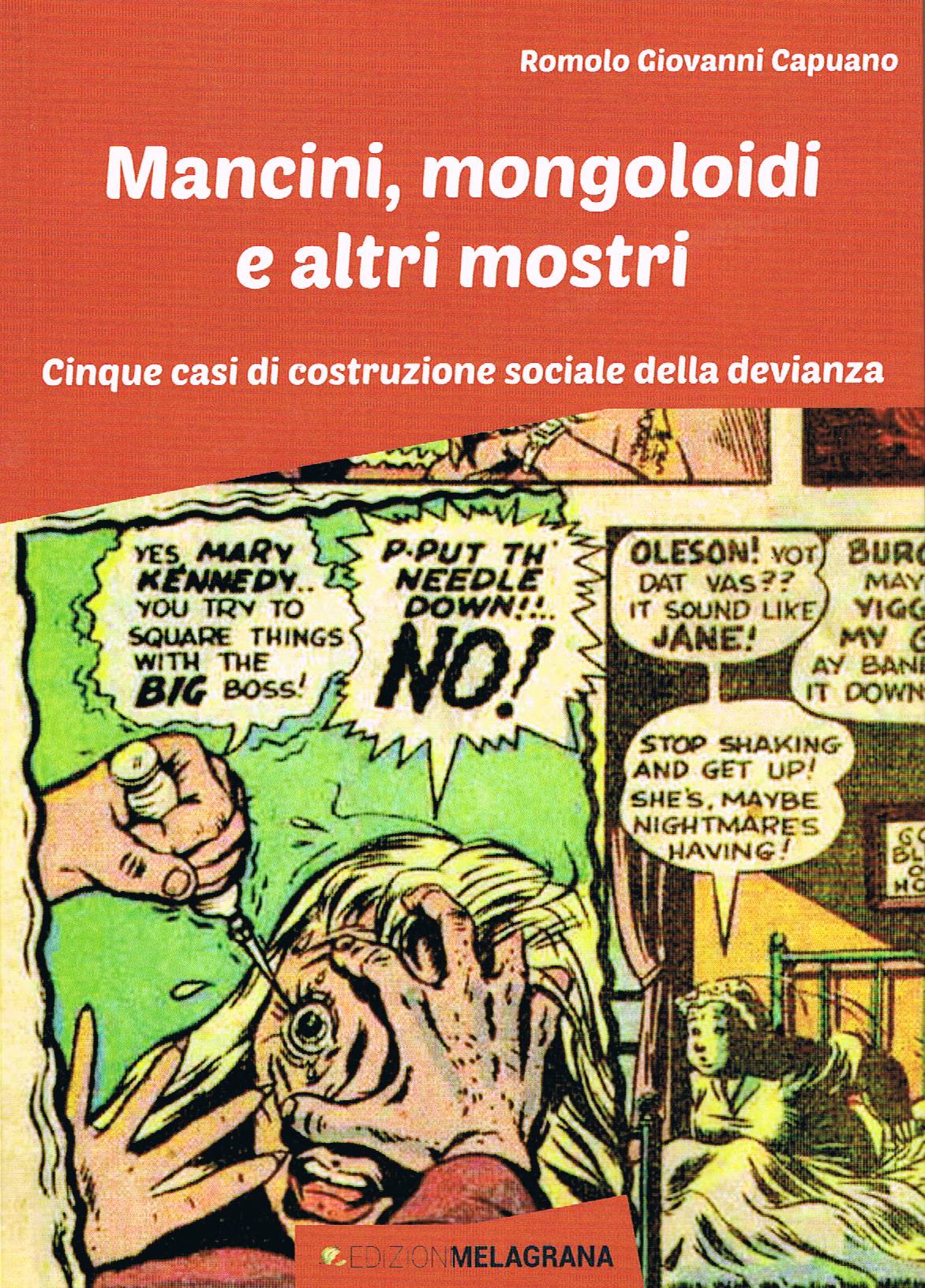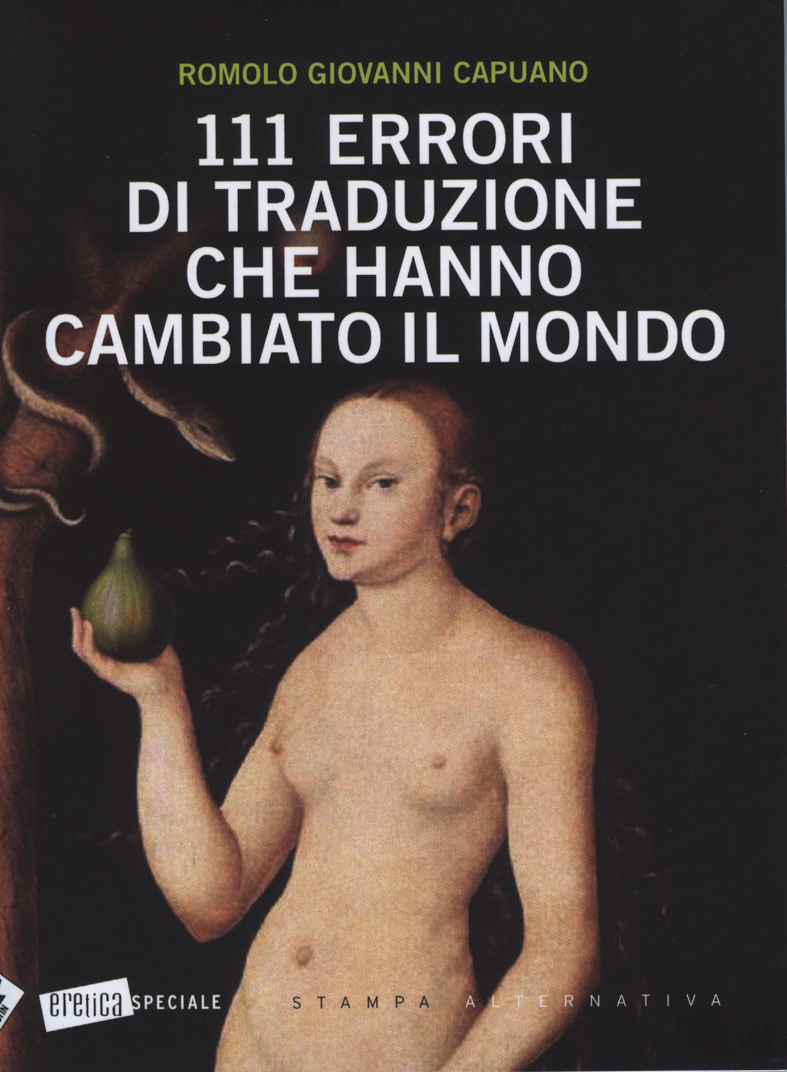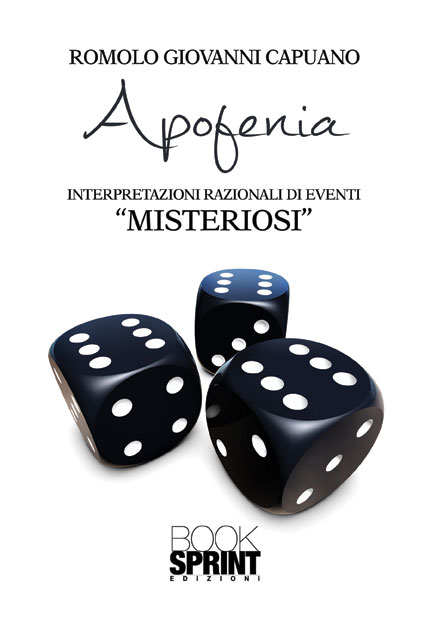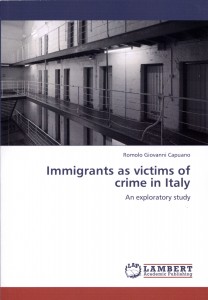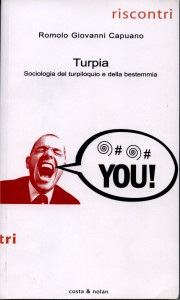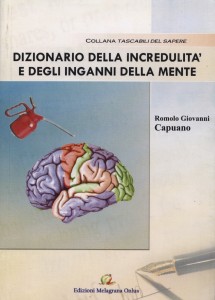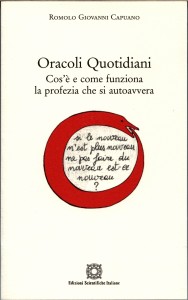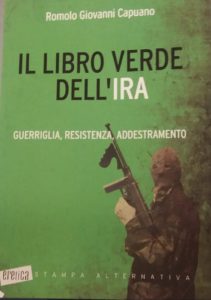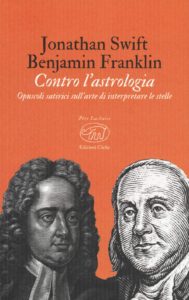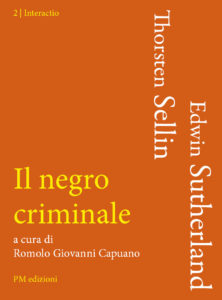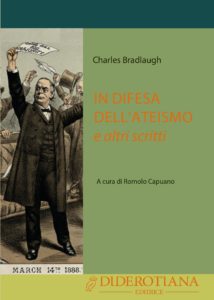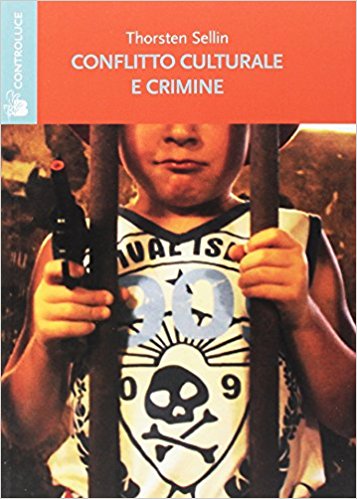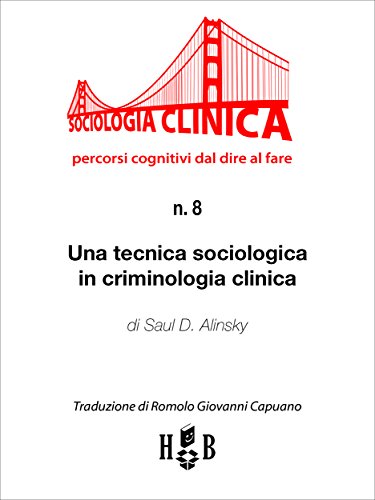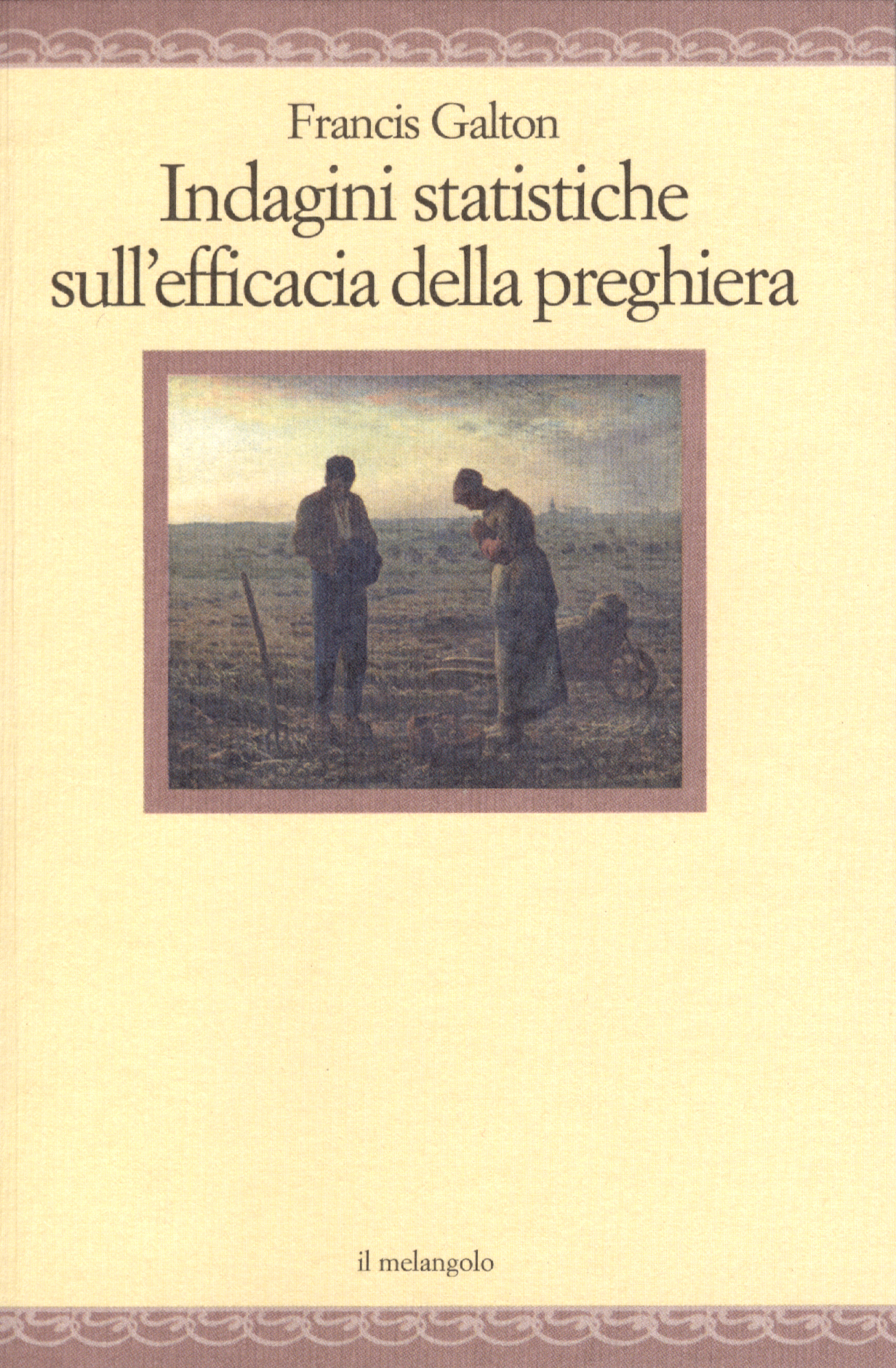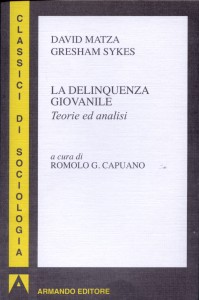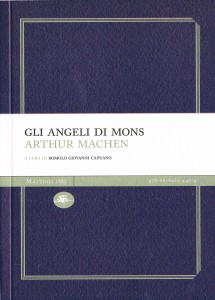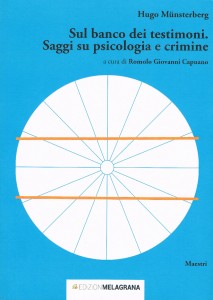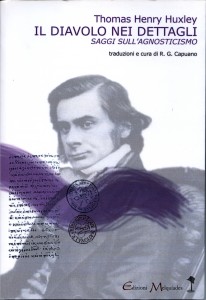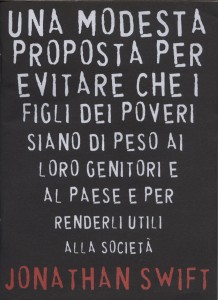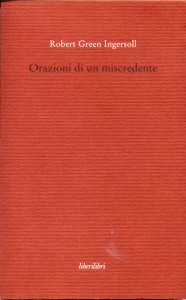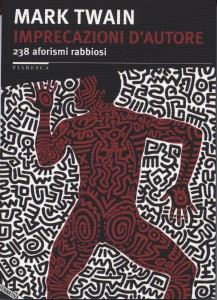Talvolta, i casi giudiziari sono interessanti non solo per i loro aspetti penali o criminali, ma anche per i loro aspetti linguistici.
Prendiamo il caso Cerciello Rega, che ha avuto una forte risonanza mediatica.
Come è noto, il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega fu ucciso a Roma con undici coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 per mano del giovane americano Lee Finnegan Elder. Insieme a questi un altro americano, Gabriel Christian Natale Hjorth, non responsabile direttamente dell’omicidio in quanto impegnato in una colluttazione con il compagno di pattuglia di Cerciello, Andrea Varriale.
La vicenda è complessa e, ancora oggi, non tutti i suoi aspetti sono stati chiariti. Mi limiterò a offrire tre osservazioni linguistiche di un certo interesse.
La prima è già stata fatta da me in un post di qualche anno fa, che qui ripeto quasi con le medesime parole.
I due americani sostennero di aver aggredito il carabiniere perché convinti che fosse uno spacciatore con cattive intenzioni nei loro confronti. Gli investigatori ribatterono che i due statunitensi conoscevano perfettamente l’identità dell’ucciso e chiamarono in causa il contenuto di diverse intercettazioni relative ad alcune conversazioni degli stessi.
Al riguardo, i difensori di Lee Finnegan Elder denunciarono errori e omissioni nelle traduzioni delle intercettazioni. In particolare, in una conversazione in cui Elder riferisce di un dialogo con la madre, l’americano afferma: «When I called mom and told her… police station and they’re saying I killed a cop». Questa frase può essere tradotta: «Quando ho chiamato mamma e le ho detto… stazione di polizia e dicono che ho ucciso un poliziotto». Il perito addetto alla traduzione rese, però, la frase in questo modo: «Ho chiamato casa dicendo di aver fatto la decisione sbagliata colpendo un poliziotto». Insomma, una sorta di confessione, dalle conseguenze disastrose per l’americano. Un esempio di come tradurre male una espressione nel corso di un’inchiesta giudiziaria può significare la condanna o l’assoluzione di una persona, come ho abbondantemente osservato nel mio libro 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo.
Altra osservazione linguistica.
Uno degli aspetti più dibattuti del caso è stata l’effettiva comprensione del termine “carabiniere” da parte dei due americani. Secondo la difesa, infatti, Lee Finnegan Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth non conoscevano sufficientemente l’italiano per comprendere il significato del termine “carabiniere”, titolo con il quale Cerciello Rega e Varriale si erano presentati a loro dopo aver ricevuto la segnalazione di un reato compiuto dagli stessi.
Il fatto interessante è che, mentre la Corte di Assise di Appello aveva ritenuto si trattasse di parola «ampiamente conosciuta anche all’estero», la Cassazione ha obiettato che tale assunto fosse una mera ipotesi congetturale, «non essendo in alcun modo sviluppato, né correlato a ragionevoli termini esperienziali, logici, oppure a dati obiettivi».
Su tale ipotesi, secondo la Corte di legittimità, «non può fondarsi il convincimento circa la esatta percezione e comprensione della qualifica in discussione da parte dell’imputato Elder, del quale la stessa Corte di merito ha messo in rilievo, a più riprese, l’ignoranza della lingua italiana».
La Corte di Cassazione ha, dunque, riconosciuto che non è legittimo presupporre che, all’estero, tutti sappiano chi siano i carabinieri e che non bisogna dare per scontato che un concetto sia noto agli altri solo perché noto a noi. Un duro colpo all’etnocentrismo linguistico che è talvolta causa di profonde incomprensioni tra individui di paesi diversi.
Una terza osservazione è stata proposta dalla linguista Licia Corbolante, in un post risalente all’epoca dell’omicidio. Corbolante faceva notare che la notizia dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega era stata riportata in maniera errata da alcuni media di lingua inglese.
In particolare, con riferimento al grado del carabiniere italiano, questo era stato tradotto, tramite un palese calco, con Vice-brigadier. Il problema è che, mentre il brigadiere italiano è un sottufficiale, «negli ordinamenti militari di alcuni paesi di lingua inglese la parola brigadier indica un grado elevato nella gerarchia militare» tanto che «nell’esercito del Regno Unito si chiama brigadier l’ufficiale di grado superiore a colonel e inferiore a major general. Nell’esercito, nella marina e nell’aviazione degli Stati Uniti lo stesso grado prende invece il nome di brigadier general».
L’errore non è di poco conto al punto che la stessa Corbolante osserva: «Forse qualche lettore anglofono con competenze militari si sarà domandato perché mai in Italia un alto ufficiale stesse pattugliando le strade di Roma per recuperare uno zainetto rubato (a un lettore italiano farebbe probabilmente lo stesso effetto leggere di un “vicegenerale” coinvolto in quella che doveva essere un’operazione di routine)».
Le tre osservazioni da me proposte sono univoche quanto alle conseguenze pratiche e concrete degli errori di traduzione e delle incomprensioni linguistiche. Quelli che possono sembrare banali fraintendimenti, insignificanti travisamenti, piccole sviste possono dar luogo a drammi reali che possono decidere della vita e della morte di una persona, della sua condanna o della sua innocenza, della rappresentazione della vicenda in un modo o in un altro.
Si tratta di situazioni la cui importanza tendiamo a sottovalutare o sminuire ma che, come dimostra la storia, si verificano con una certa frequenza e meritano tutta l’attenzione di chi ritiene che la corretta traduzione o interpretazione di una parola non sia un orpello di cui si può fare tranquillamente a meno.