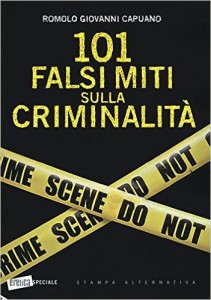 C’è una certa ironia nelle storie degli scienziati che vogliono studiare il crimine da un punto di vista biologico o genetico. Quasi inevitabilmente, tendono a individuare dei tratti, delle caratteristiche, delle zone del cervello che, secondo loro, sarebbero associati a un’alta probabilità (se non certezza) di commettere atti criminali, salvo poi rendersi conto che quei tratti, caratteristiche, zone del cervello sono presenti anche in persone del tutto rispettabili. Anzi, addirittura in… loro stessi!
C’è una certa ironia nelle storie degli scienziati che vogliono studiare il crimine da un punto di vista biologico o genetico. Quasi inevitabilmente, tendono a individuare dei tratti, delle caratteristiche, delle zone del cervello che, secondo loro, sarebbero associati a un’alta probabilità (se non certezza) di commettere atti criminali, salvo poi rendersi conto che quei tratti, caratteristiche, zone del cervello sono presenti anche in persone del tutto rispettabili. Anzi, addirittura in… loro stessi!
In un post precedente, ho già fatto notare come, dopo la morte di Cesare Lombroso, avvenuta il 19 ottobre 1909, l’Istituto di medicina legale dell’Università di Torino notò che il cervello del criminologo torinese era ricco di pieghe di passaggio, una delle tipiche ‘stimmate’ delinquenziali individuate da Lombroso. In altre parole, il criminologo, stando alla sua stessa teoria, era un delinquente nato!
Una disavventura del genere è capitata più recentemente al neuroscienziato americano James Fallon, il quale, studiando il cervello di diversi serial killer, ha notato che
molti mostravano livelli di attività inferiori alla media nelle aree del lobo frontale legate all’empatia, alla morale e all’autocontrollo. Nel tentativo di quantificare le differenze tra loro e il resto della popolazione, Fallon dispose sulla scrivania le scintigrafie cerebrali degli assassini e quelle che aveva fatto ai loro familiari. Quella che più di tutte gridava “psicopatico!”… era la sua. Pensò di far sparire quel risultato inquietante, ma poi decise di fare il bravo scienziato e indagare oltre, esaminando il proprio DNA. Il risultato fu ancora più sconcertante: “Avevo tutti gli alleli collegati con un rischio elevato di aggressività, violenza e scarsa empatia”.
Seriamente preoccupato, Fallon fece alcune ricerche approfondite nella sua genealogia. In vari rami della famiglia trovò sette presunti assassini […].
In cerca di risposte sulla propria mancanza di istinto criminale, Fallon decise che doveva la sua non-violenza all’amore di sua madre e la ringraziò dal profondo del cuore. Nel 2013 scrisse The Psychopath Inside, libro in cui afferma: “Il fattore biologico non è una sentenza insindacabile: ci indica solo le probabilità che abbiamo di mettere in atto certe tendenze. I geni si limitano a fornire certe inclinazioni, a far sì che una persona possa diventare uno psicopatico”» (McDermid, V., 2016, Anatomia del crimine. Storie e segreti delle scienze forensi, Codice Edizioni, Torino, p. 258).
Di fronte a vicende del genere, ammesso che le cose stiano esattamente così, mi viene da chiedere: e se le teorie biologiche sul comportamento criminale fossero del tutto prive di senso? Del resto, un tratto che non discrimina affatto tra persone criminali e persone rispettabili non ha alcun valore in termini scientifici. Soprattutto gli studi di questi neurobiologi entusiasti non sembrano prendere in considerazione il fatto che i comportamenti devianti non sono MAI un fatto esclusivamente biologico, ma sono l’esito di incroci di definizioni sociali, etichette normative, variabili psicologiche, sociologiche, politiche e di altro genere. A costo di attirarmi critiche di ogni genere, arrivo a sostenere che la biologia non c’entra per niente con il crimine, se non in maniera talmente vaga da essere irrilevante. Dire che si è geneticamente predisposti al crimine è come dire che si è geneticamente predisposti a mangiare e respirare.
È probabile, però, che la tentazione di imputare il comportamento dei delinquenti a un gene o a un tratto biologico susciti ancora molto entusiasmo negli scienziati e che sentiremo e leggeremo ancora a lungo di teorie come quelle di Lombroso e Fallon. Salvo poi scoprire che quei geni e quei tratti li hanno tutti. Compresi gli stessi scienziati che ne parlano.
Per altre bizzarrie della criminologia, rimando al mio recente 101 falsi miti sulla criminalità.









































