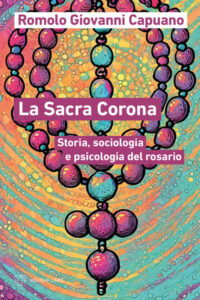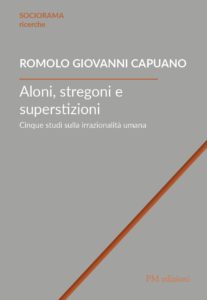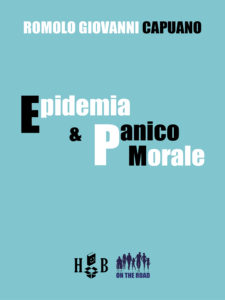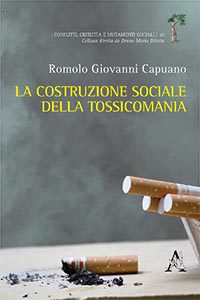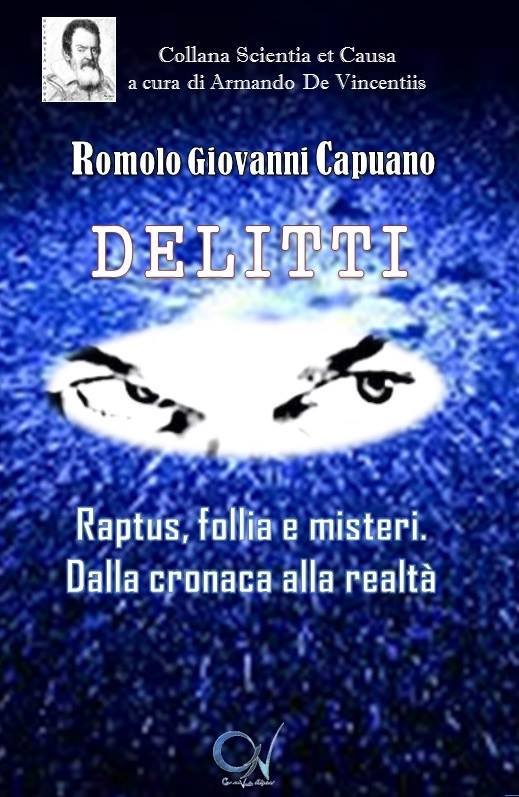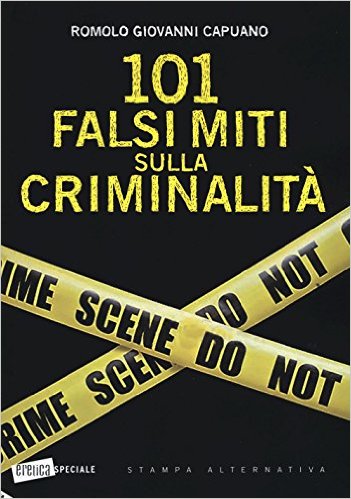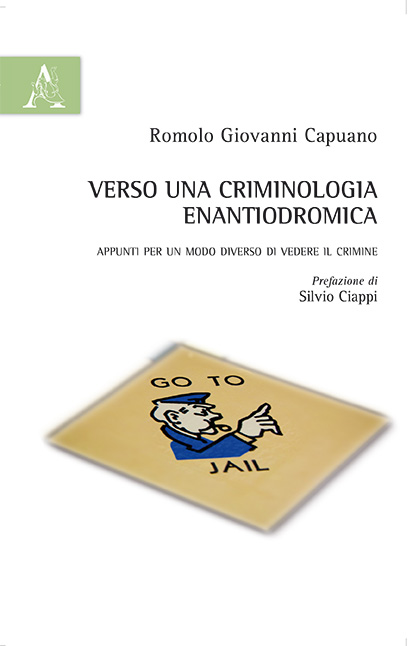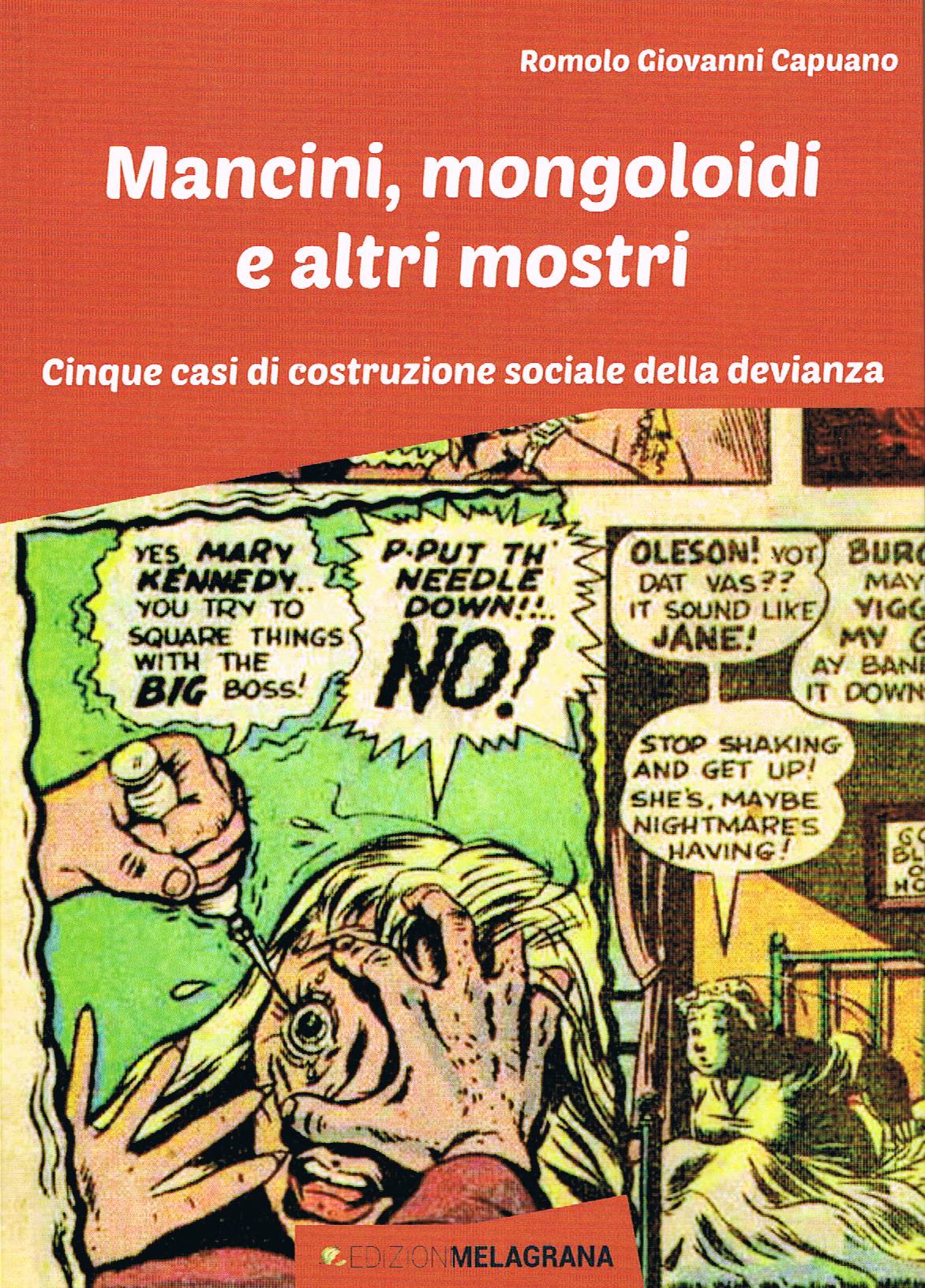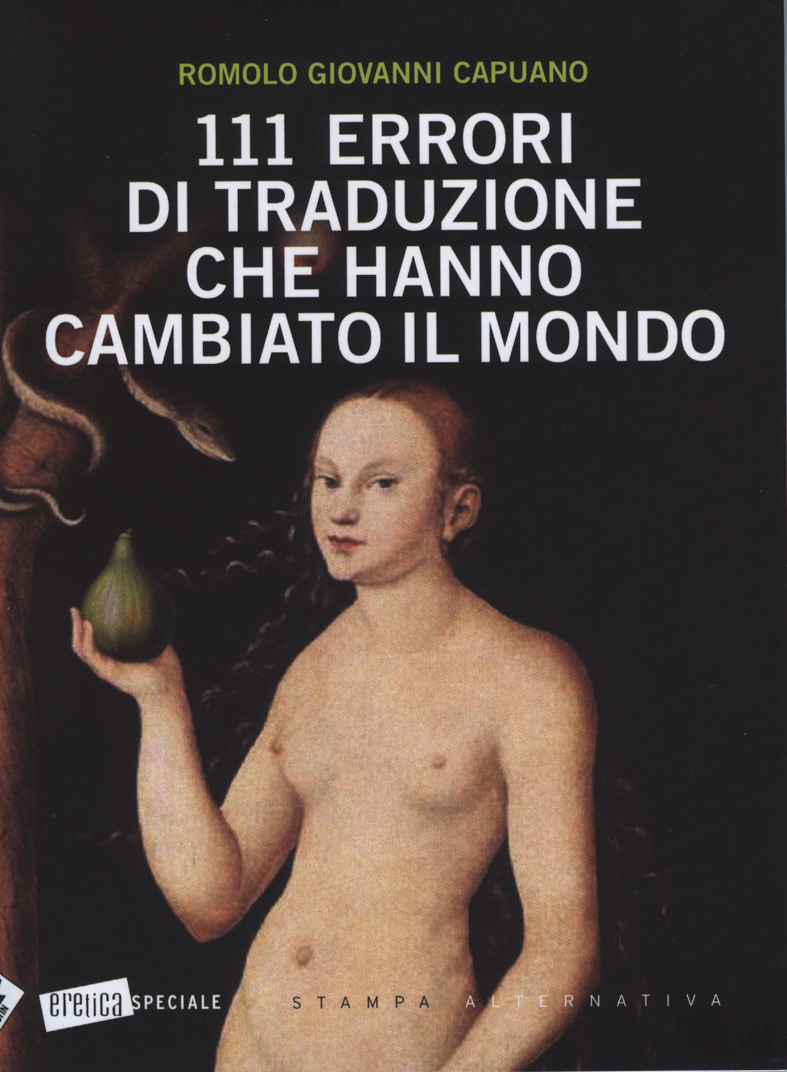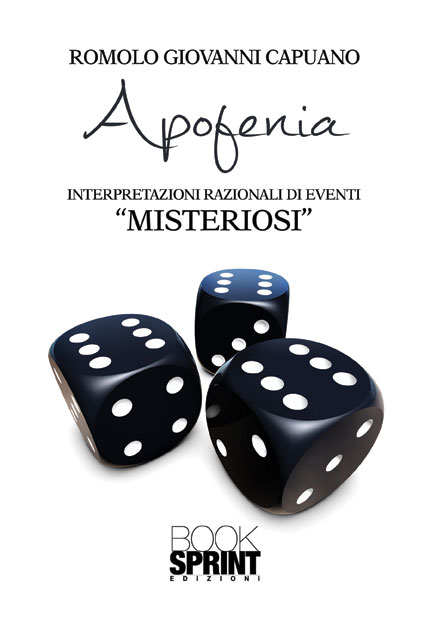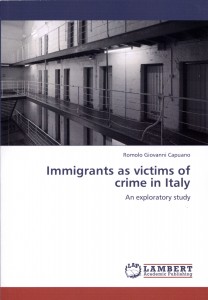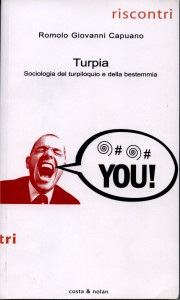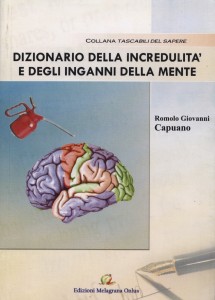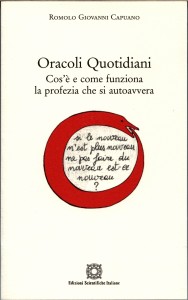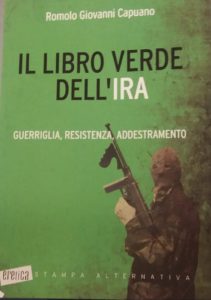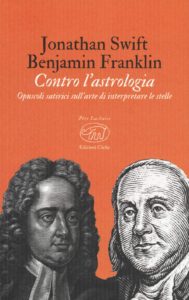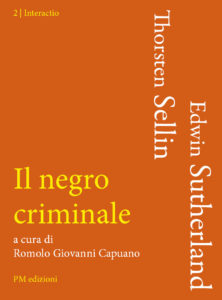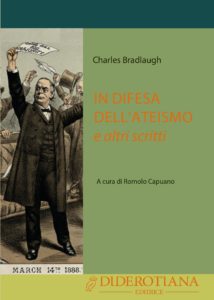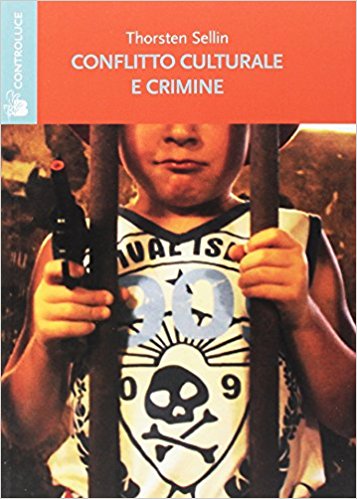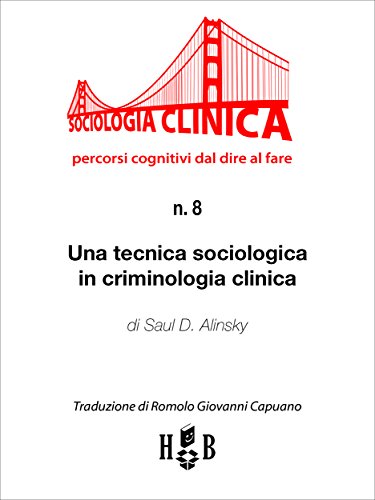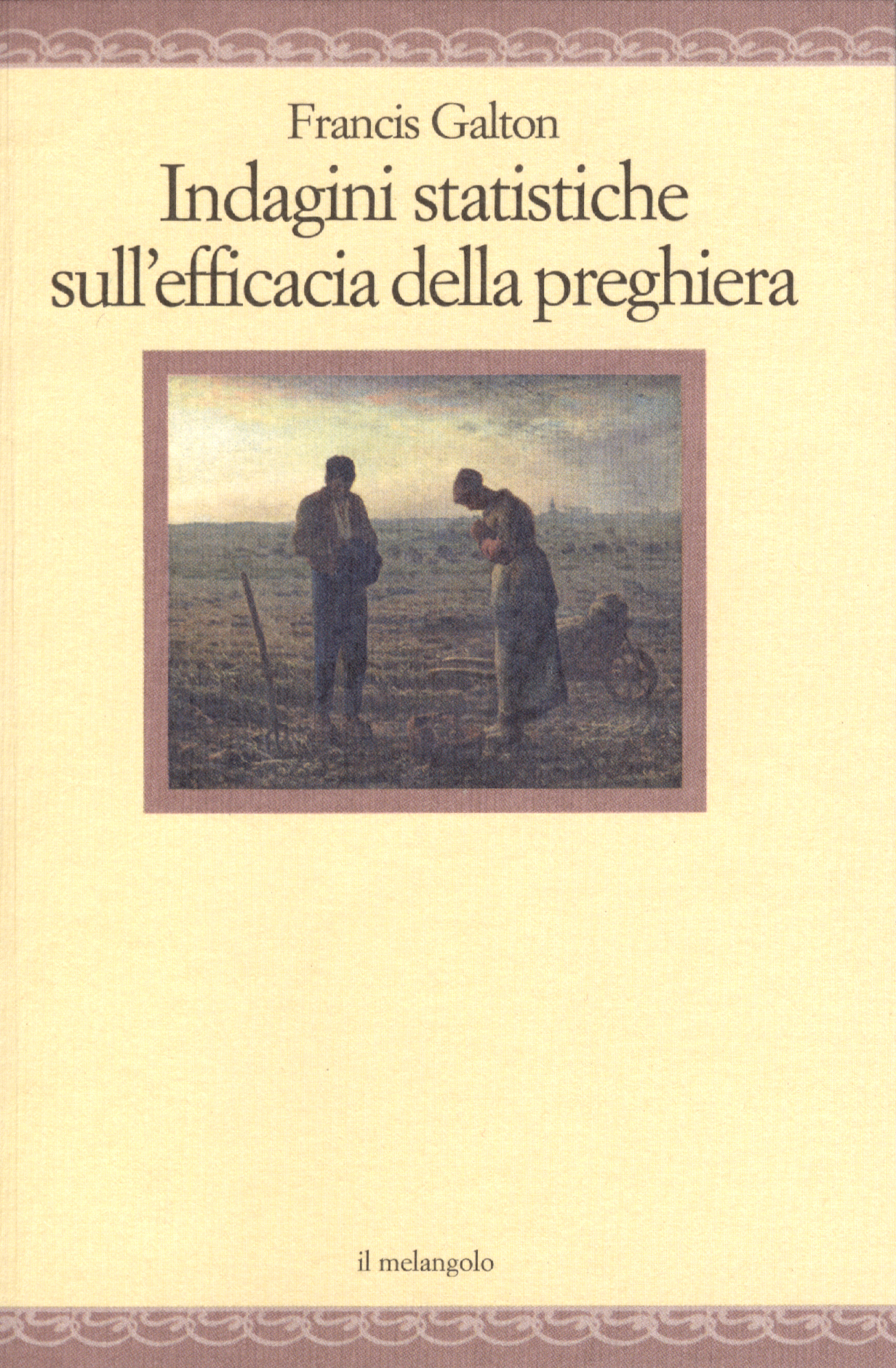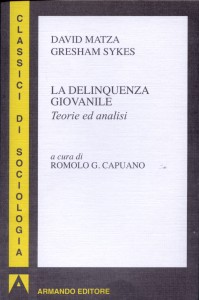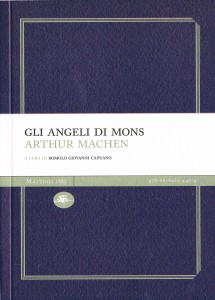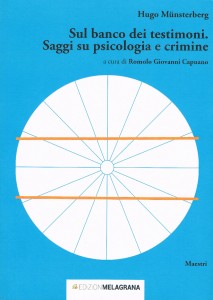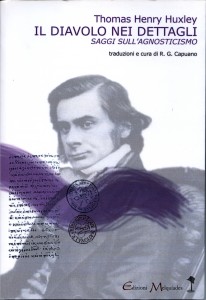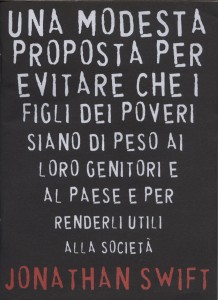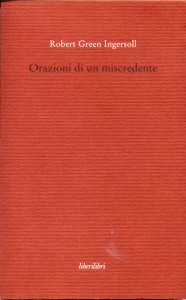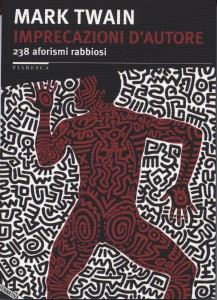Le emozioni che proviamo sono davvero “autentiche” e “spontanee”? Quando proviamo un’emozione, lo facciamo in piena libertà e autonomia? Possiamo dire che le emozioni scaturiscono solo e unicamente dai recessi più intimi del nostro essere?
Secondo la sociologia delle emozioni, la risposta è un sonoro “no”. Ogni società, infatti, impone ai suoi membri “regole del sentire” (feeling rules) e “regole di espressione” (display rules). Le prime ci dicono che cosa provare in ogni data situazione sociale. Le seconde ci dicono come e se esprimere le emozioni oppure modificarle con altre più adeguate alle caratteristiche del contesto in cui agiamo. Le emozioni, dunque, non scaturiscono da un semplice processo fisiologico. La società plasma ogni nostro sentire e, perfino, ogni nostro modo di manifestare il nostro sentire.
Una delle conseguenze di tali assunti sociologici è che non dobbiamo mai compiere l’errore di associare il concetto di verità a una manifestazione emotiva. Non possiamo parlare di emozioni vere o autentiche perché il nostro sentire è sempre subordinato a regole del sentire e regole di espressione. Perfino quando crediamo di essere trasportati da un sentimento estremamente intenso, come l’amore “più sincero”, in realtà paghiamo tributo a norme che la società ci impone fin dalla nascita.
Ci sono poi situazioni in cui gli individui sono chiamati, per ragioni professionali o di altro genere, a compiere un vero e proprio “lavoro emozionale” (emotional labour) ossia uno sforzo sulla messa in forma delle proprie emozioni. Si pensi a un’infermiera dell’ospedale chiamata a negare al parente di un ricoverato l’accesso a un reparto in orario non consentito, esibendo un sorriso di comprensione. Oppure a un’assistente di volo tenuta, per contratto, a manifestare sempre una calda e positiva cordialità ai passeggeri dell’aereo su cui presta servizio. Nei due casi citati, l’infermiera e l’assistente di volo non possono non essere cortesi nei confronti dei loro rispettivi “clienti” poiché rischierebbero denunce e richiami.
Stesso discorso riguarda i politici di professione, che hanno “l’obbligo” di mettere in scena le forme di manifestazione emotiva più adeguate al contesto in cui si trovano per ottenere voti e consenso. Più ciò avviene in maniera intensa e coinvolgente, più comunicheranno ai loro interlocutori una sensazione di autenticità. Per non parlare di attori di cinema e teatro e protagonisti di talk show. L’errore più grande è quello di pensare che questi soggetti esprimano autenticamente le proprie emozioni durante le loro attività o che esibiscano le stesse forme di manifestazione emotiva una volta usciti dal ruolo.
La tentazione di attribuire agli altri stati emotivi che essi sono chiamati a mostrare in ragione delle loro attività è fortissima e genera equivoci infiniti. Ad esempio, ci si meraviglia che l’attore dal sorriso caldo e smagliante sullo schermo sia denunciato dalla moglie per maltrattamenti. O che il politico così coinvolgente in campagna elettorale sia arrestato per corruzione.
La verità è che nessuna manifestazione emotiva è, di per sé, autentica nel senso di puramente individuale. La società ci condiziona perfino quando ridiamo, piangiamo, ci sentiamo contenti o tristi, proviamo rabbia o gioia, sofferenza o felicità. E l’intensità dell’emozione esibita non dovrebbe mai essere assunta come indicatrice di stati d’animo genuini, per quanto in buona fede essi siano manifestati.
È un duro colpo per chi crede nella bontà dei sentimenti. Ma anche questi – ci insegna la sociologia – sono mediati dall’influenza della società.
Riferimento:
Cerulo, M., 2018, Sociologia delle emozioni, Il Mulino, Bologna, cap. 5 e pp. 180-185.