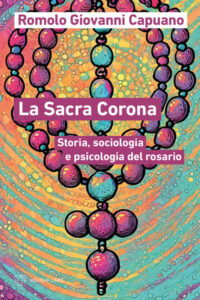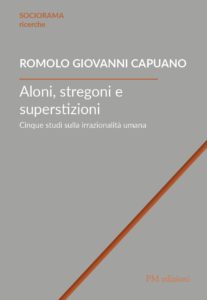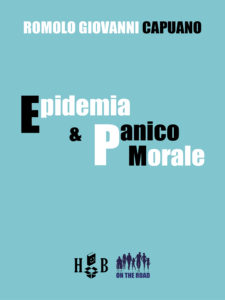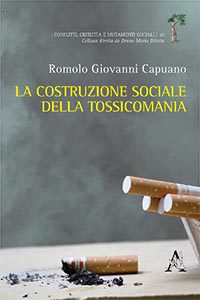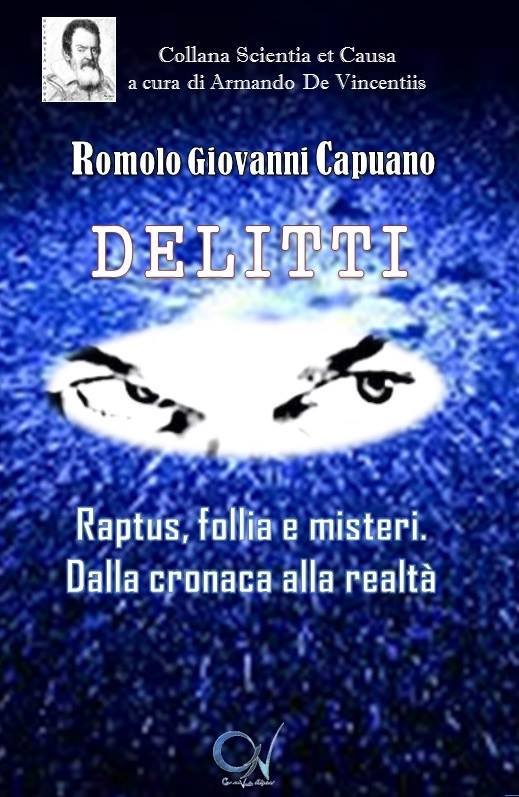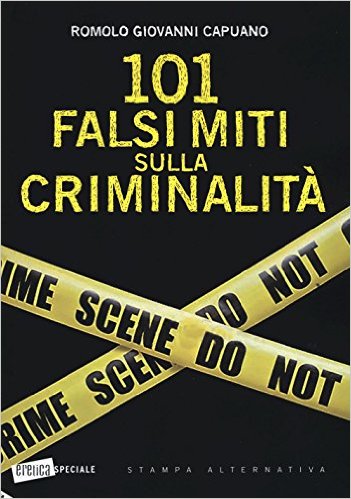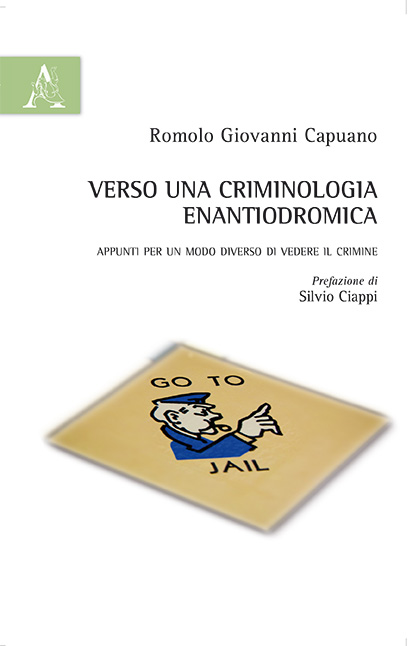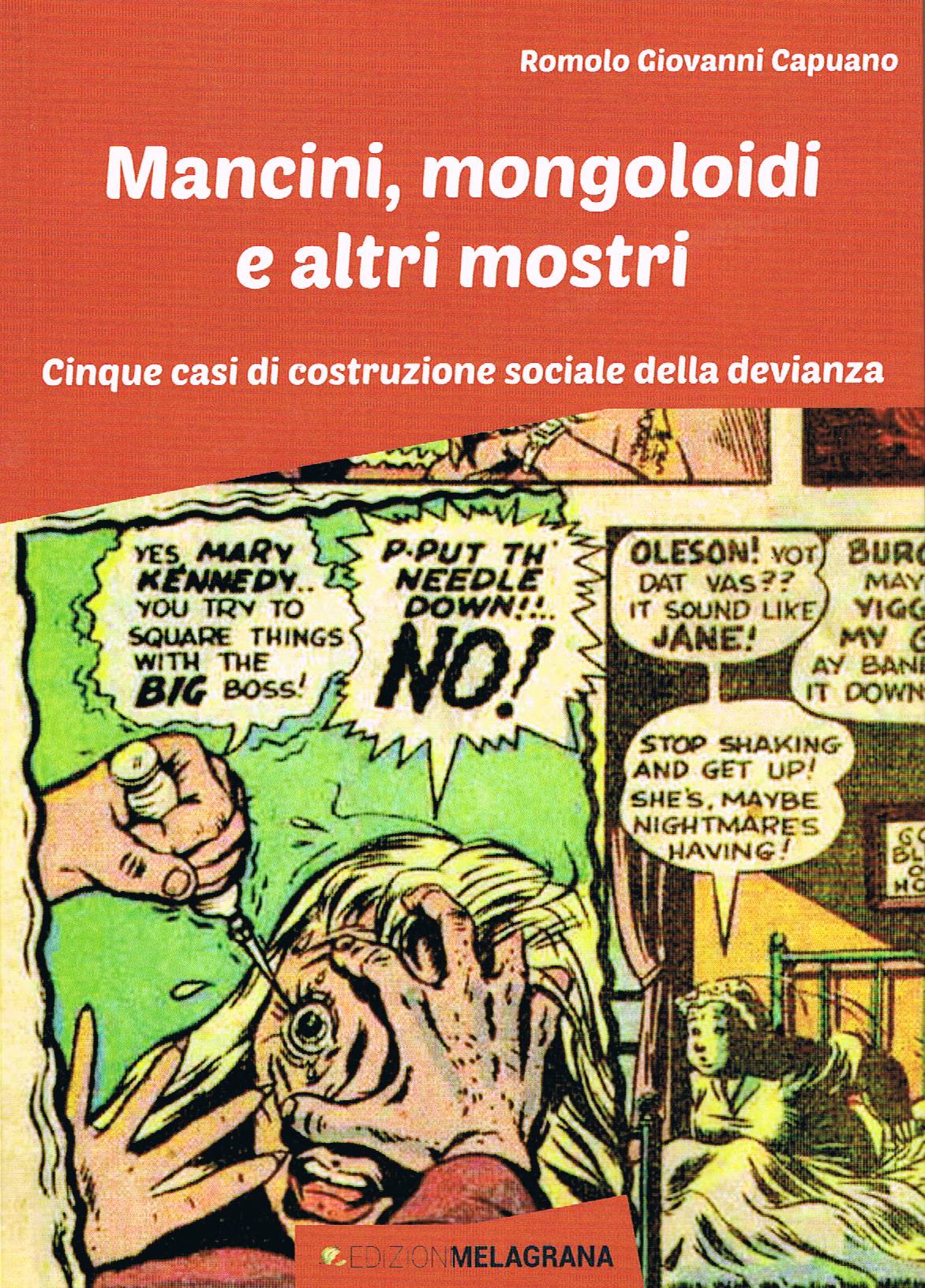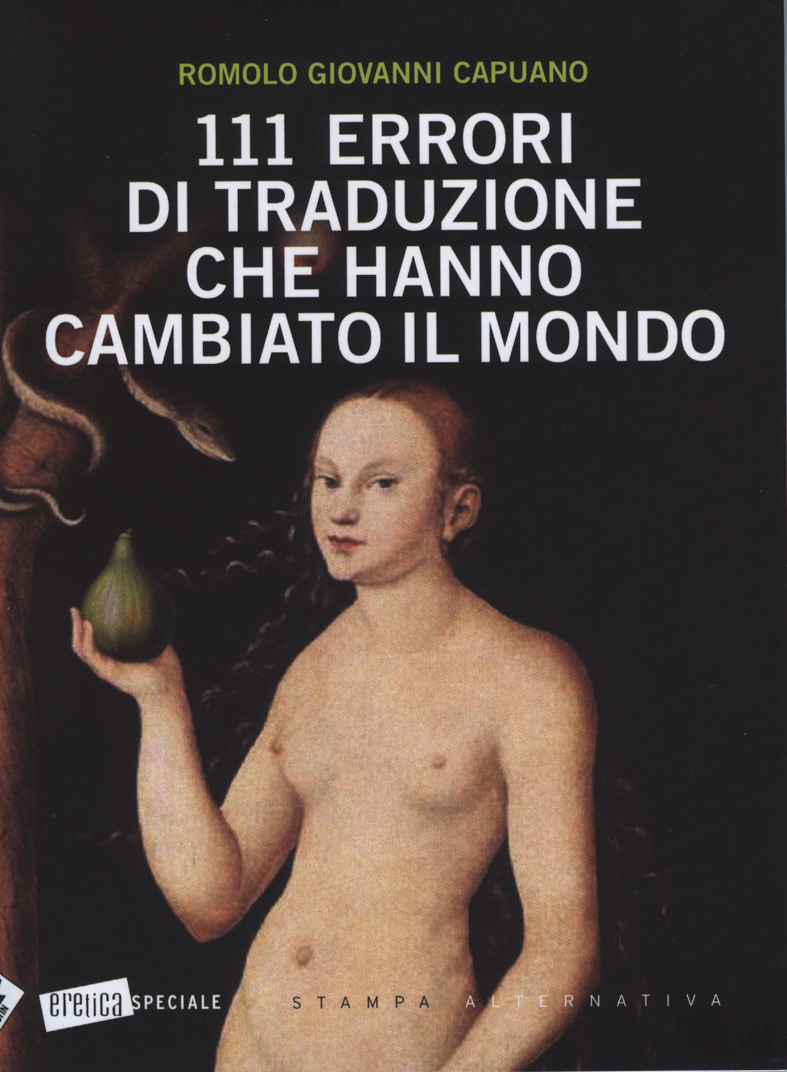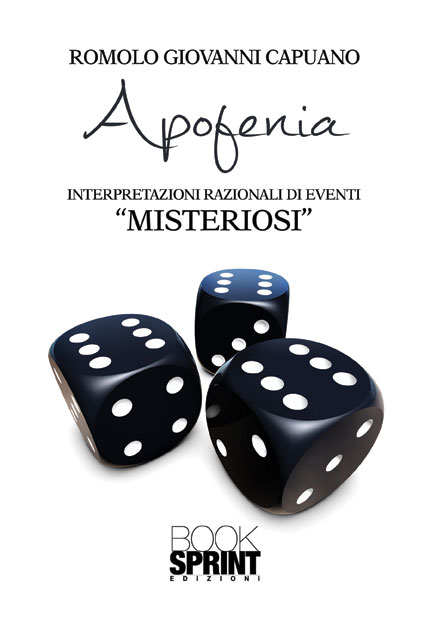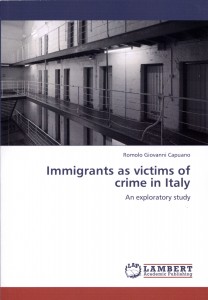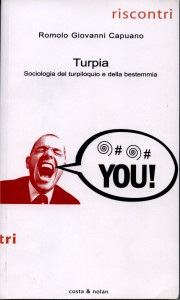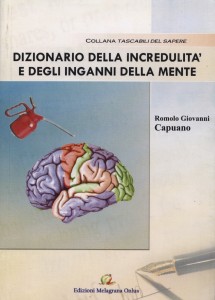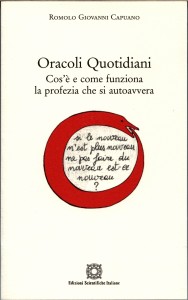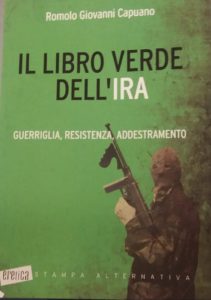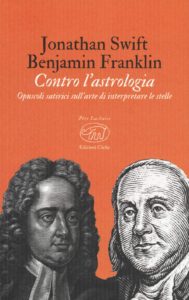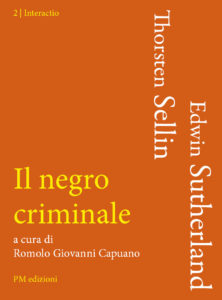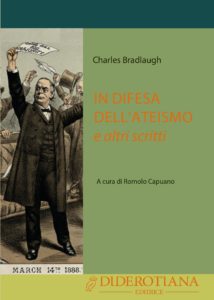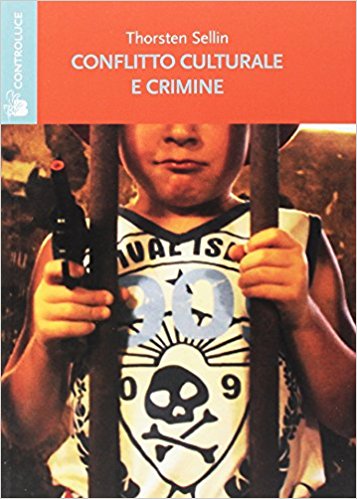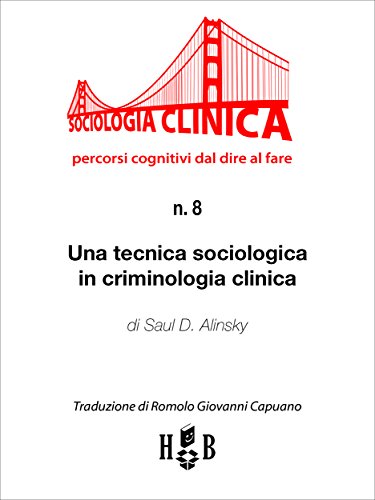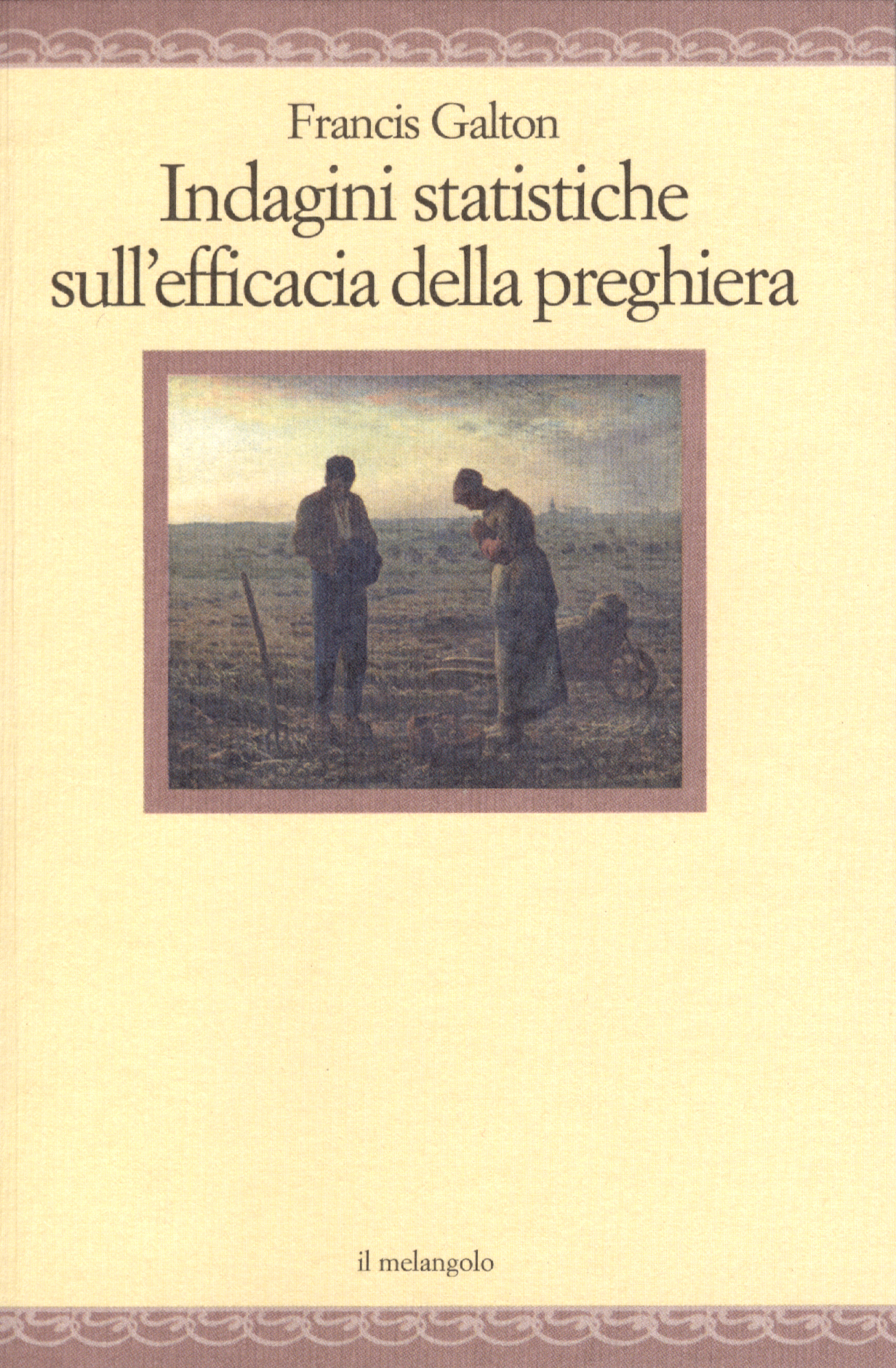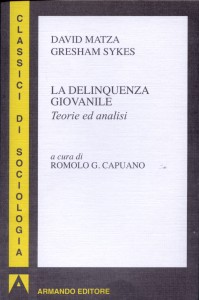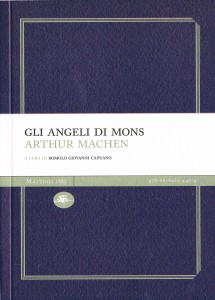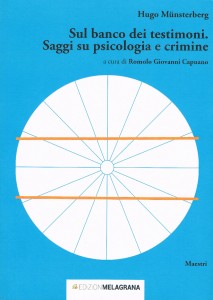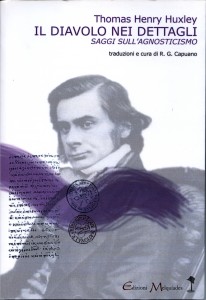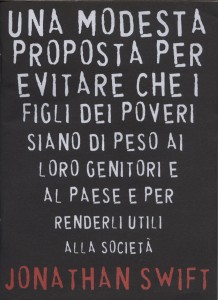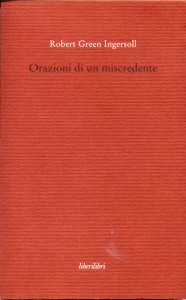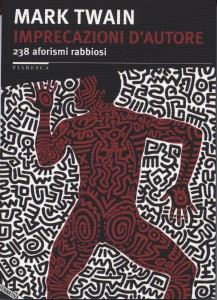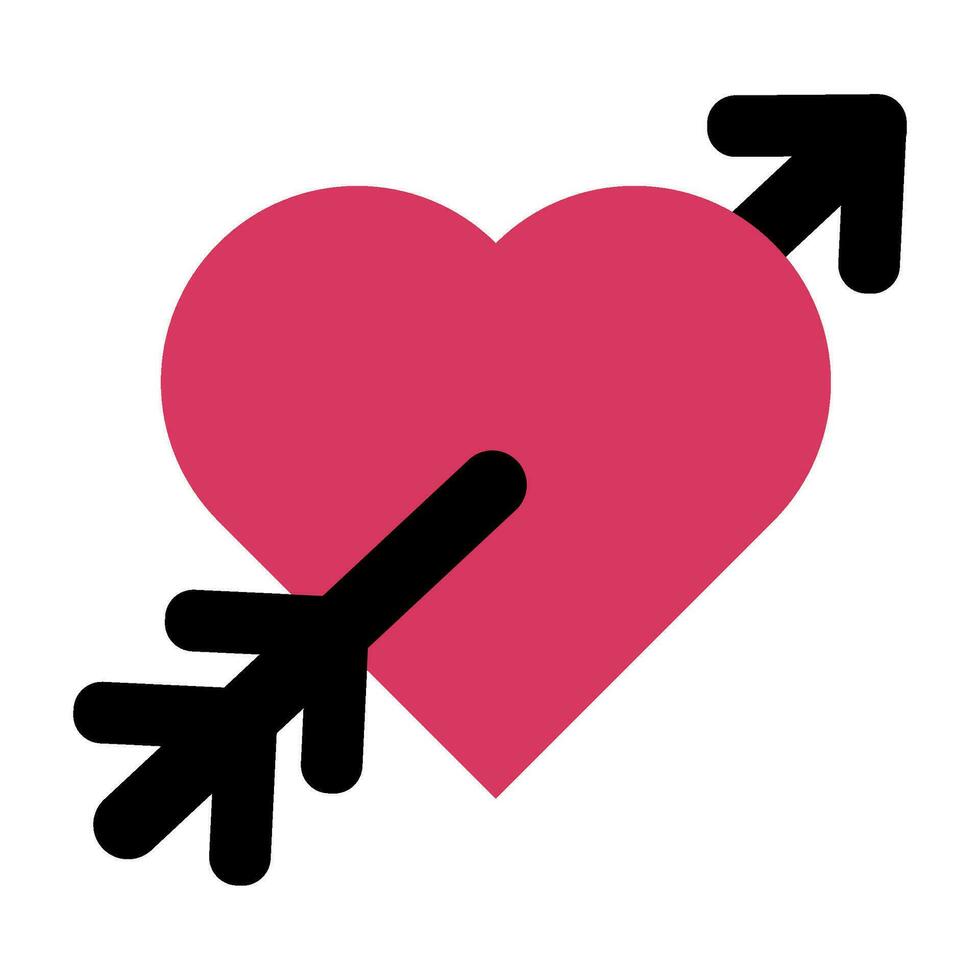
«Chi amò mai che non amasse al primo sguardo?» si domanda la pastorella Febea in dialogo con il pastore Silvio in Come vi piace (1623) di William Shakespeare. Tesi implicitamente sottoscritta dai protagonisti del celebre Romeo e Giulietta (1594-1596), in cui Romeo dei Montecchi si innamora “a prima vista” di Giulietta della famiglia rivale dei Capuleti durante una festa.
Nella letteratura mondiale, il tema del colpo di fulmine che attanaglia saldamente due persone destinate ad amarsi per sempre è piuttosto ricorrente. Anzi, ordinariamente l’eroe si innamora della sua bella “al primo sguardo”, come accade nell’Orlando furioso (1516) di Ludovico Ariosto in cui Orlando viene rapito immediatamente dall’apparizione della bellissima principessa Angelica.
Un paio di secoli prima, nell’Elegia di madonna Fiammetta (1345) di Giovanni Boccaccio, la protagonista racconta di essersi innamorata “al primo sguardo” del mercante Panfilo: «E acciò che io non vada ogni suo atto narrando […] in sí fatta maniera andò, che io, oltre ad ogni potere raccontare, da subito e inopinato amore mi trovai presa, e ancora sono».
“Inopinato amore” fu anche quello che colse Dante nei confronti di Beatrice. Lo descrive Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante (1362):
Era intra la turba de’ giovinetti una figliuola del sopradetto Folco, il cui nome era Bice come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse d’otto anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e ne’ suoi atti gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea; e, oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, ma prima possente ad innamorare, agli occhi del nostro Dante: il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella imagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì.
Il tema non è, peraltro, circoscritto ai secoli passati. I primi versi di “Amore a prima vista” della poetessa polacca Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, ne sono testimonianza:
Sono entrambi convinti
che un sentimento improvviso li unì.
È bella una tale certezza
ma l’incertezza è più bella.
Nello stesso secolo, i Beatles di With a Little Help from My Friends esprimono una uguale convinzione:
Would you believe in a love at first sight?
Yes, I’m certain that it happens all the time.
Sarebbe impresa disperata elencare tutte le opere letterarie, artistiche, cinematografiche ecc. che hanno celebrato l’amore a prima vista, certificandone in questo modo l’esistenza. Libri, canzoni, film, serie televisive, rubriche del cuore lo tematizzano, a vario titolo, rafforzando la percezione che rappresenti la forma ideale di innamoramento. La conseguenza è che l’amore a prima vista è un fenomeno dato per scontato, scarsamente problematizzato, ma molto pervasivo. Esso scorrazza liberamente nel sentire comune, affolla le conversazioni quotidiane, addensa le battute di attori e attrici, occupa i versi di innumerevoli motivi canori, ispira desideri e frustrazioni di giovani amanti.
È probabile che ognuno di noi, se interrogato, si dichiarerebbe certo della sua esistenza. Del resto, come potrebbero mentire secoli e secoli di testimonianze di ogni tipo al riguardo?
Eppure, già a lume di buon senso, la nozione di “amore a prima vista” appare problematica. In essa, infatti, si cela un vero e proprio ossimoro. Pensiamoci bene. L’amore presuppone un sentimento profondo e duraturo nei confronti di una persona. «L’amore nasce dal profondo e guarda verso il futuro», scrive il sociologo Francesco Alberoni (2000, p. 49). Inoltre, per amare davvero qualcuno si ha bisogno di conoscerlo bene, come testimoniano locuzioni come “amore materno”, “amore filiale”, “amore fraterno”. L’amore richiede intimità, passione, legame, impegno, durata. Nel caso di un rapporto di coppia, sue condizioni sono: un sentimento messo alla prova dal tempo, una conoscenza frutto di frequentazioni non occasionali, la percezione di sentirsi un “noi” e non due individui separati, il desiderio di voler stare insieme a lungo, di “invecchiare insieme”, anzi di vivere con l’altro/a “finché morte non ci separi”, come recita la nota formula nuziale.
Tutto questo non si consegue “a prima vista”.
Ingredienti del colpo di fulmine sono, invece: un’attrazione fisica istantanea, l’infatuazione, l’entusiasmo improvviso provocato dal semplice aspetto fisico della persona.
L’attrazione fisica si colloca, per antonomasia, sul piano del qui-ed-ora, dell’effimero, della superficialità. “Beauty is only skin-deep” dicono gli inglesi. Ovvero: la bellezza fisica ha una “profondità” che non va oltre quella della pelle. L’infatuazione, invece, si basa sull’idealizzazione dell’altro/a in un orizzonte temporale compresso e tende a durare solo se il rapporto non viene vissuto. Tanto che, una volta che l’altro/a viene conosciuto/a, si trasforma in altro o cede il posto a una frustrazione – l’effetto realtà – in grado di attenuare o annullare la percezione iniziale.
L’infatuazione è l’esito di un’attenzione selettiva centrata su uno o più aspetti dell’altra persona, i quali vengono concepiti come rappresentanti della personalità nel suo complesso. Così, la bellezza del viso viene assunta come l’immagine di una bellezza interiore. Un interesse condiviso come la prova di una profonda affinità. Inoltre, sulla persona sono sovente proiettati desideri, bisogni, aspetti di sé, che finiscono con l’offuscare la sua reale personalità. Al contrario, come abbiamo visto, «amare un essere umano significa conoscere e amare la sua persona», per usare le parole di Nathaniel Brandon, autore di La psicologia dell’amore romantico (1992, p. 57). Ribadiamolo. Non può esserci amore vero senza conoscenza. E la conoscenza implica un decorso temporale, una reciprocità continua, un confronto assiduo.
Ma allora, se tra “amore” e “colpo di fulmine” c’è un rapporto di opposizione, come si spiega la popolarità della nozione di “amore a prima vista”? La risposta, secondo le scienze umane, sta nel fatto che l’esperienza dell’innamoramento induce una serie di distorsioni cognitive, che alterano positivamente la percezione dell’altra persona e rendono speciale il rapporto. Ad essere alterata non è solo la percezione, ma anche il ricordo (confabulated memory, in inglese), che assume tinte decisamente rosee, perfino a dispetto della realtà.
Già Sigmund Freud (1856-1939), nella prima metà del XX secolo, notava come l’innamoramento comporti un’alterazione evidente della realtà:
Nel quadro di questo innamoramento ci ha colpito fin dall’inizio il fenomeno della sopravvalutazione sessuale, il fatto, cioè, che l’oggetto amato sfugga entro certi limiti alla critica, che tutte le sue qualità vengano apprezzate più di quelle delle persone non amate o più che nel periodo in cui l’oggetto stesso non era amato. In virtù di una rimozione più o meno efficace, oppure di una messa fuori gioco delle tendenze sessuali, sorge l’illusione che l’oggetto sia amato anche sensualmente a causa dei suoi pregi spirituali, mentre al contrario è solo il fascino sensuale che ha potuto conferirgli quei pregi. La tendenza che qui falsa il giudizio è quella all’idealizzazione (Freud, 1921, p. 300).
Più o meno nello stesso periodo, l’antropologo americano Ralph Linton (1893-1953) evidenziava la natura culturale di tale “anomalia”:
Tutte le società riconoscono che tra le persone di sesso opposto si sviluppano affetti emotivi, occasionali, violenti, ma la nostra attuale cultura americana è praticamente la sola che abbia tentato di… farne la base del matrimonio… La loro rarità nella maggior parte delle società suggerisce che si tratti di anomalie psicologiche a cui la nostra cultura ha assegnato un valore straordinario (Linton, 1936, cit. in Brandon, 1992, pp. 53-54).
Venendo a tempi più recenti, vari studi dimostrano che gli individui tendono a valutare i propri partner in una luce più positiva rispetto agli altri e ad avere un pregiudizio positivo nei confronti delle proprie relazioni. Ad esempio, gli innamorati vedono i loro partner in una luce più positiva della media per quanto riguarda variabili come intelligenza, attrazione fisica, calore e senso dell’umorismo. Inoltre, chi è sposato tende a sovrastimare la stabilità del proprio matrimonio e a sottovalutare le probabilità di divorzio (Swami, Stieger, Haubner, Voracek, Furnham, 2009, pp.1-2).
Nel complesso, si è scoperto che gli individui coinvolti in una relazione intima esibiscono le seguenti tipiche distorsioni cognitive (in inglese biases): (a) esagerano sistematicamente gli aspetti positivi delle loro relazioni, ritenendo queste superiori a quelle di altre coppie (bias di miglioramento); (b) si mostrano eccessivamente ottimisti riguardo all’evoluzione del proprio rapporto (bias ottimistico); (c) esagerano il livello di controllo che possiedono nei confronti della propria relazione (bias di controllo) (Gagné, Lydon, 2004, pp. 322-324).
Altro bias emerso dalla ricerca psicologica e sociologica è il bias dell’amore cieco (love-is-blind bias), che è possibile definire come la tendenza a percepire il partner con cui si è coinvolti in una relazione romantica come più attraente di quanto non sia in realtà e più attraente di sé stessi. La tendenza a valutare il proprio partner più positivamente di quanto si valuti sé stessi prende anche il nome di partner-serving bias (Fletcher, Kerr, 2010).
L’idealizzazione della persona amata è, talvolta, sostenuta ricorrendo ad attribuzioni causali distorte per cui, mentre le condotte positive del partner sono attribuite a caratteristiche della persona, quelle negative sono considerate come aventi una causa occasionale (Hall, Taylor, 1976). Gli aspetti gradevoli dell’altro/a sono, dunque, ascritti a tratti stabili e duraturi della sua personalità (la “vera essenza”); quelli spiacevoli a cause contingenti, provvisorie, situazionali (“Non era davvero lui/lei”).
Altre due importanti distorsioni cognitive sono: a) il bias di conferma, in base al quale, l’innamorato/a tende a osservare, cercare e valorizzare solo le informazioni che sembrano confermare la sua visione idealizzata della persona amata, trascurando quelle che sembrano contraddirla; 2) l’effetto alone, per cui i tratti positivi della persona amata “contagiano” la percezione degli altri tratti di personalità, favorendo il sorgere di aspettative irrealistiche da cui possono facilmente derivare delusioni cocenti (Capuano, 2021).
Tutte queste distorsioni concorrono a creare quelle che in psicologia sono definite “illusioni positive”, illusioni che servono a preservare e sostenere la propria autostima e la propria salute mentale a dispetto di possibili minacce provenienti da informazioni negative. Una considerevole letteratura suggerisce da tempo che giudicarsi in maniera eccessivamente positiva, percepire in maniera esagerata il proprio livello di controllo sulla realtà o le proprie capacità, possedere un ottimismo irrealistico sono caratteristiche normali del pensiero umano che hanno spesso conseguenze positive come la capacità di essere felici o soddisfatti, e di generare lavoro creativo. Ciò avviene perché le illusioni positive agiscono come una sorta di filtro nei confronti delle informazioni provenienti dal mondo esterno, distorcendole in senso positivo per il sé (Taylor, Brown, 1988). In virtù di tali illusioni, in campo sentimentale, le persone tendono a proiettare sul proprio partner quelle che considerano le caratteristiche ideali che dovrebbe avere la persona amata, a sopravvalutare il livello di soddisfazione che ci si aspetta dal rapporto e a sottovalutare la probabilità di conflitti o disaccordi. Ciò, a sua volta, è funzionale a un maggior senso di sicurezza relazionale e a un maggior livello percepito di soddisfazione.
Se questo è vero in generale, è possibile che anche la nozione di “amore a prima vista” debba la sua fortuna a distorsioni cognitive e illusioni positive? Secondo la ricerca psicosociologica, sì.
In particolare, coloro che credono in questa particolare forma di amore sono soggetti a quelli che gli inglesi chiamano outcome bias (bias del risultato) e hindsight bias (bias del senno di poi). In base al primo, le persone tendono a rileggere il passato alla luce delle conoscenze acquisite successivamente, che modificano la visione di quanto accaduto nel passato. Più precisamente, le persone tendono a valutare le azioni in base ai risultati. Se le loro convinzioni iniziali si rivelano vere, dichiarano di esserne sempre state sicure, indipendentemente da quanto lo fossero all’inizio. Pertanto, se una persona prova una forte attrazione iniziale per un partner con cui ha in seguito una relazione sentimentale, è più probabile che il primo incontro venga successivamente etichettato come amore a prima vista. Ciò non accadrà, invece, se dall’iniziale attrazione fisica non deriverà alcun coinvolgimento romantico. Il passato è dunque visto alla luce del presente e l’attrazione del primo incontro viene rivestita di una nuova luce che originariamente non possedeva (Zsok, Haucke, De Wit, Barelds, 2017, p. 870).
In questo fenomeno, l’attrazione fisica esercita un ruolo importante. Le persone di bell’aspetto hanno maggiori probabilità di essere viste in maniera esageratamente positiva. A esse, infatti, vengono assegnati tratti caratteriali più desiderabili, in base all’effetto alone. Se all’iniziale attrazione segue un’esperienza di innamoramento profondo, reciproco e duraturo è facile, come detto, che l’iniziale attrazione fisica venga reinterpretata come amore a prima vista. E qui subentra la seconda fallacia: il bias del senno di poi, in base al quale, dopo l’accadimento di un evento, il suo verificarsi sembra essere più probabile di prima fino ad assumere i contorni dell’inevitabilità (“Non poteva che andare così!”). La relazione di amore induce a ricordare l’attrazione fisica iniziale come un “colpo di fulmine” dalle inevitabili conseguenze sentimentali. La storia d’amore viene letta come se il suo esito fosse l’unico possibile, come se il suo copione non avrebbe potuto svolgersi altrimenti. In realtà, il momento fatale è riconosciuto solo a posteriori, col senno di poi. E, come ricorda il filosofo Yuval Noah Harari, «ciò che, visto col senno di poi, appare inevitabile è invece tutt’altro che ovvio nel momento in cui si verifica» (Harari, 2017, p. 297).
L’amore a prima vista è, dunque, etichettabile come un’illusione positiva, sostenuta da precise distorsioni cognitive, che svolge diverse funzioni all’interno della coppia: essa consente, infatti, di migliorare il rapporto conferendogli un’aura speciale, quasi magica; di leggere la propria “favola d’amore” in maniera coerentemente romantica fin dall’inizio, proiettando sul passato passioni e sentimenti attuali; di conformarsi a modelli culturali ideali accreditati dalla società; di comporre eventuali difficoltà o disaccordi nel nome di una storia unica e inimitabile.
Tutto ciò potrebbe apparire deprimente. Classificare l’amore a prima vista tra le illusioni, sebbene positive, sembrerebbe un colpo mortale (e basso) a una delle credenze ancora oggi più diffuse: quella nell’amore romantico. In realtà, le illusioni svolgono un ruolo estremamente importante nella nostra vita tanto che è possibile affermare, senza timore di essere smentiti, che senza di esse la vita sarebbe ben poca cosa. Soprattutto quando sono positive.
Riferimenti
Alberoni, F., 2000, Ti amo, BUR, Milano.
Brandon, N., 1992, La psicologia dell’amore romantico, Sugarco, Milano.
Capuano, R. G., 2021, Aloni, stregoni e superstizioni. Cinque studi sulla irrazionalità umana, PM Edizioni, Varazze (SV)
Fletcher, G. J. O., Kerr, P. S. G., 2010, “Through the eyes of love: Reality and illusion in intimate relationships”, Psychological Bulletin, vol. 136, pp. 627–658.
Freud, S., 1921, Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Idem, 1989, Opere. L’Io e l’Es e altri scritti 1917-1923, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino.
Gagné, F. M., Lydon, J. E., 2004, “Bias and accuracy in close relationships: An integrative review”, Personality and Social Psychology Review, vol. 8, pp. 322–338.
Hall, J., Taylor, S.E., 1976, “When love is blind: Maintaining idealized images of one’s spouse”, Human Relations, vol. 29, pp. 751–761.
Harari, Y. N., 2017, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano.
Linton, R., 1936, The Study of Man, Appleton-Century Co., New York.
Swami, V., Stieger, S., Haubner, T., Voracek, M., Furnham, A., 2009, “Evaluating the physical attractiveness of oneself and one’s romantic partner: Individual and relationship correlates of the love-is-blind bias”, Journal of Individual Differences, vol. 30, pp. 35–43.
Taylor, S.E., Brown, J.D., 1988, “Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health”, Psychological Bulletin, vol. 103, pp. 193–210
Zsok, F., Haucke, M., De Wit, C., Barelds, D., 2017. “What kind of love is love at first sight? An empirical investigation”, Personal Relationships, vol. 24, n. 4., pp. 869-885.