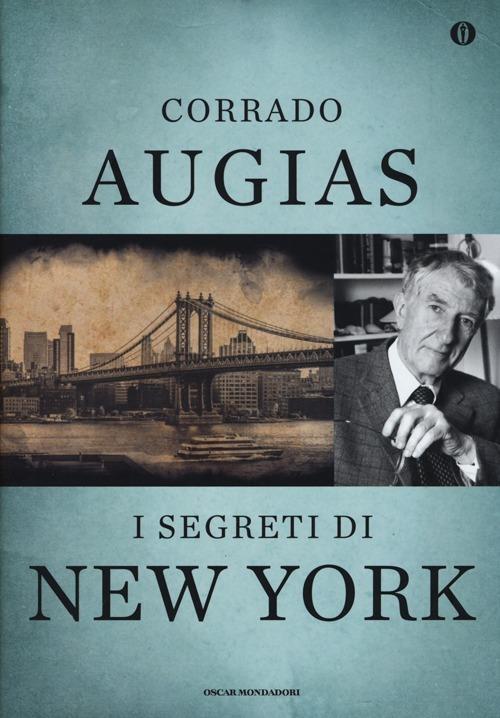Ellis Island è una piccola isola della baia di New York che, dal 1892 al 1954, ha “accolto” milioni di immigrati provenienti dall’Europa. Qui, i nuovi arrivati venivano identificati, visitati da medici e psichiatri, registrati e accompagnati al molo per imbarcarsi sul traghetto per Manhattan. Se giudicati deformi, ciechi, sordi, portatori di malattie contagiose o affetti da malattie mentali, venivano espulsi dal suolo americano. Una iattura per tanti, se si pensa che il viaggio dall’Europa agli Stati Uniti durava più di un mese e spesso l’aspirante migrante aveva speso tutto ciò che aveva per il viaggio. Attualmente, Ellis Island è sede di un importante museo che ricorda quei giorni.
Le procedure di ammissione agli Stati Uniti erano disciplinate da regole burocratiche, spesso sbrigative e brutali, oltre che disumane. Tale brutalità era evidente durante le fasi di registrazione e delle visite mediche in cui i migranti erano esaminati come carne da macello. Il grande numero di essi non contribuì certamente a mitigare le procedure di ammissione, che si svolgevano spesso in un clima di incomprensione e indifferenza nei confronti delle sorti di quegli uomini e donne, che per gli americani non erano altro che poveri straccioni analfabeti in cerca di un’occupazione.
Durante la fase di registrazione, in particolare, che prevedeva l’annotazione di nome, luogo di nascita, stato civile, professione e precedenti penali, era facile che l’incontro con tante lingue diverse e la frettolosità delle operazioni inducesse il personale addetto a vari tipi di errori. Alcuni di questi finivano con il cancellare per sempre l’identità del nuovo venuto, trasformando il nome o il luogo di provenienza con effetti tanto tragici quanto ridicoli.
Al riguardo, Corrado Augias, nel libro I segreti di New York, racconta un aneddoto esemplare, non si sa se inventato, tratto da un’operetta dello scrittore francese George Perec, che vale la pena di citare per intero:
A un vecchio ebreo russo era stato suggerito di dichiarare un nome americano, in modo che gli agenti dell’immigrazione non faticassero a trascriverlo. Il vecchio chiese consiglio alla prima persona incontrata che gli suggerì “Rockefeller”. Continuò a ripetersi quel nome per tutto l’interminabile tempo in cui rimase in fila, con il risultato che quando arrivò davanti ai commissari dell’immigrazione se l’era dimenticato. Alla domanda di come si chiamasse balbettò desolato in yiddish “Schon vergessen”, l’ho dimenticato. Impassibile il commissario scrisse sul registro “John Ferguson”.
In questo modo, attraverso un tratto di penna mistificatore, il nuovo venuto veniva ribattezzato, la sua storia cancellata, la sua identità contraffatta, la sua umanità affidata allo sbadiglio di un agente dell’immigrazione.
Equivoci del genere, di cui oggi ridiamo, hanno avuto un impatto devastante sulle esistenze di milioni di persone, costrette a reinventarsi in un ambiente culturale, sociale, linguistico alieno e, frequentemente, ostile. Chissà quanti John Ferguson sono entrati negli Stati Uniti. Chissà quanti di essi hanno avuto figli che continuano ad avere un nome inventato per un errore di interpretazione!
Fonte:
Augias, C., 2001, I segreti di New York, Oscar Mondadori, Milano, p. 191.