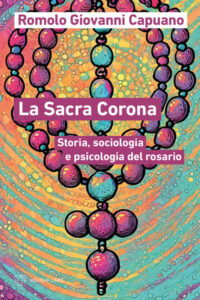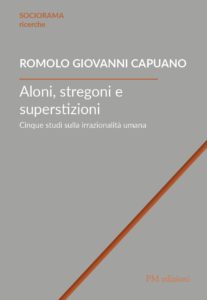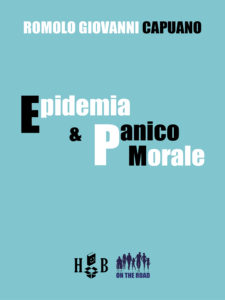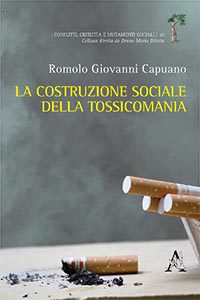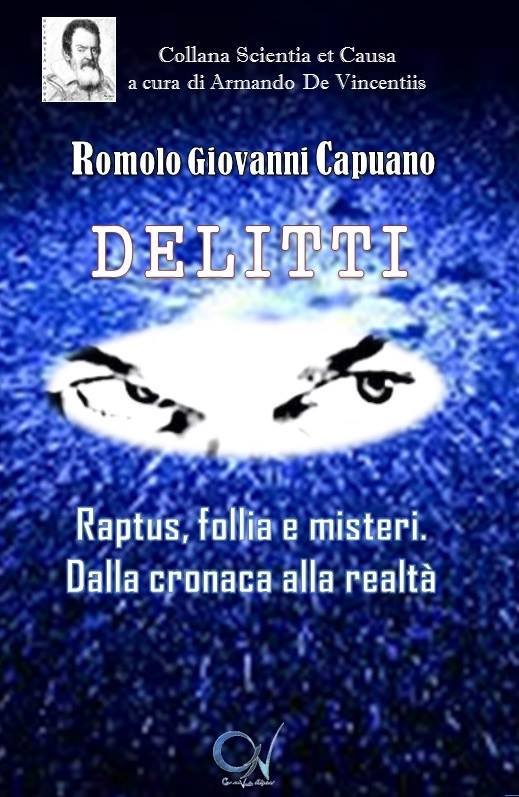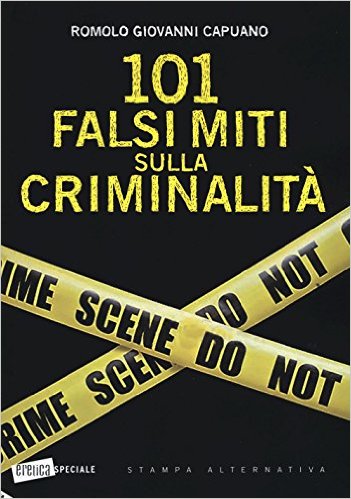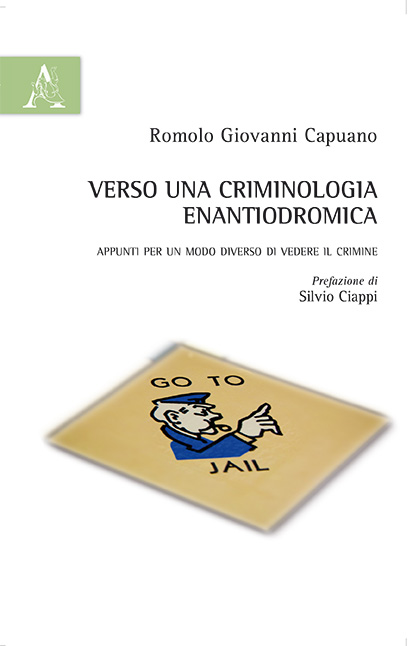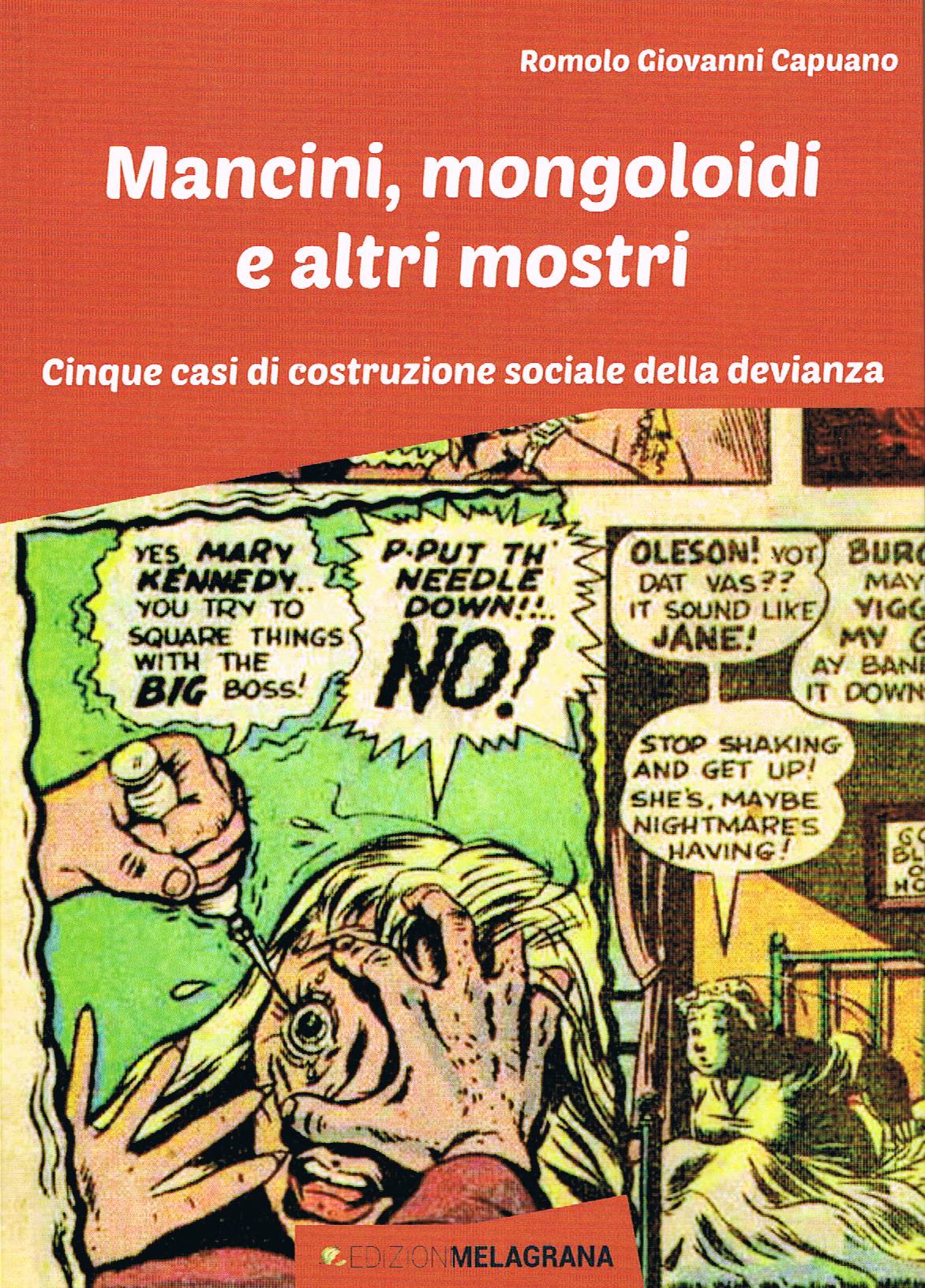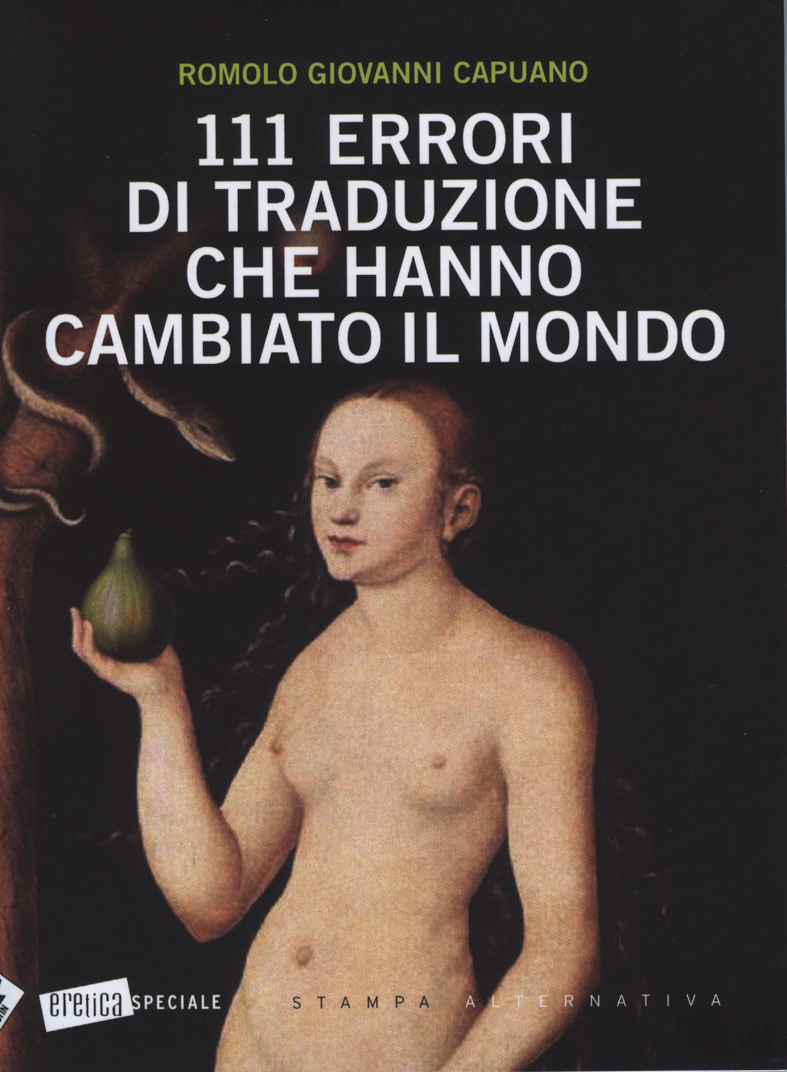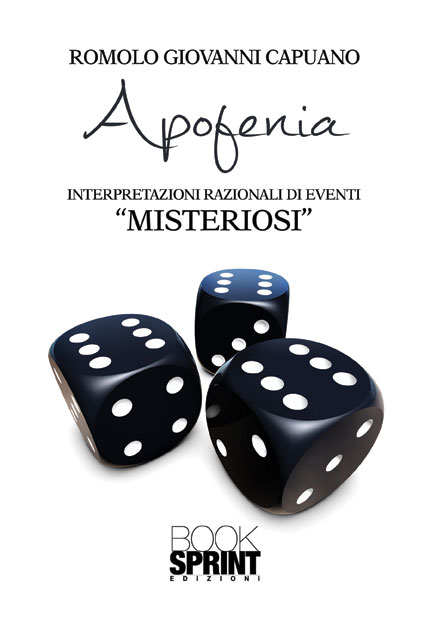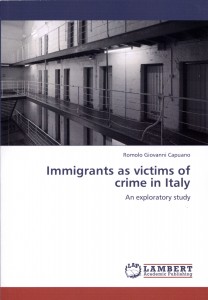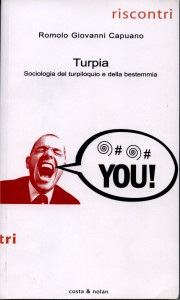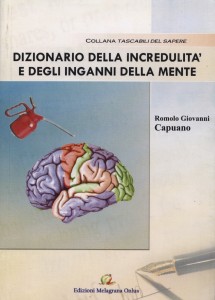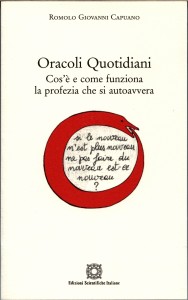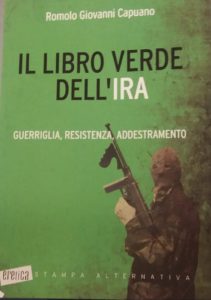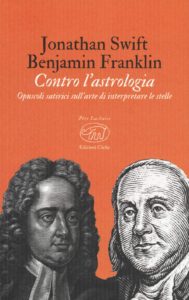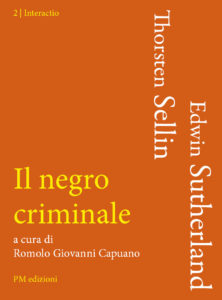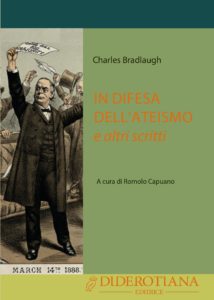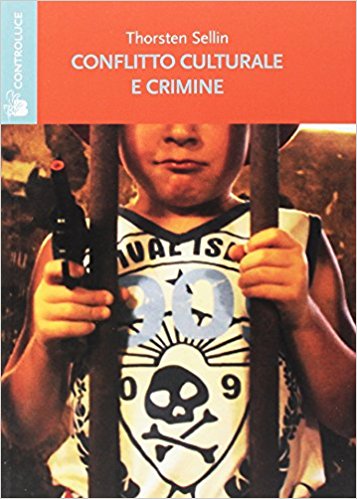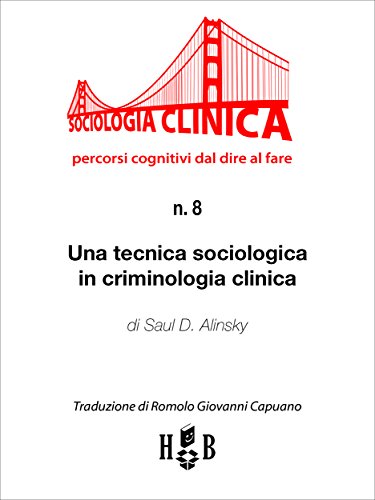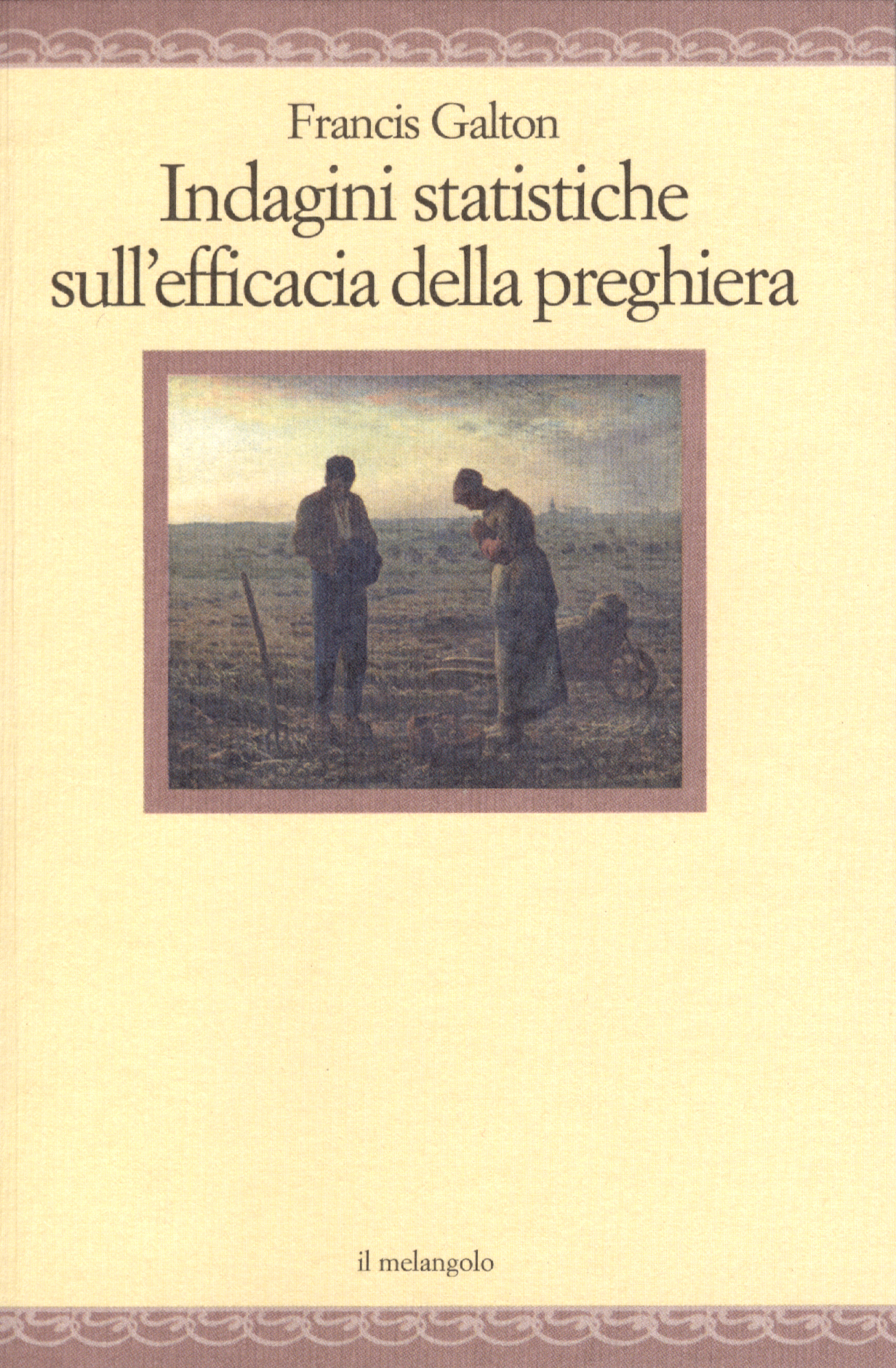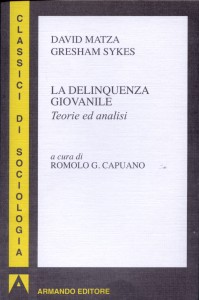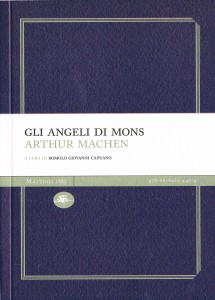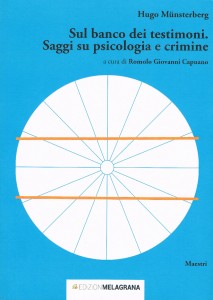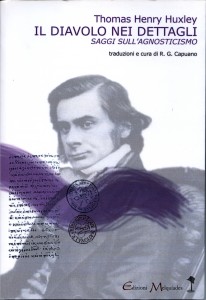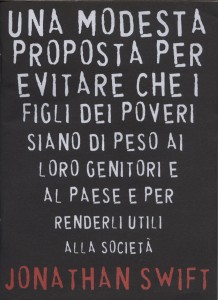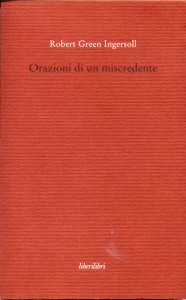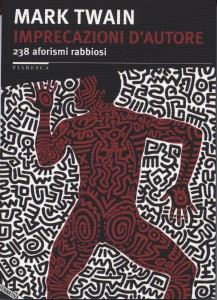Tra i dispositivi retorici attualmente più in voga per screditare l’avversario in un confronto verbale, vi è sicuramente il ricorso all’accusa che l’altro, l’oppositore, ha “tanto tempo libero”.
Alcuni opinionisti e giornalisti – uno di questi è sicuramente David Parenzo – ne fanno un uso talmente frequente da diventare quasi abuso smodato, se non un refrain talmente ripetitivo da convertirsi nell’insignificanza. Tuttavia, a giudicare dalle reazioni spesso risentite degli avversari, sembra funzionare.
Per comprendere perché, dobbiamo dedicarci a una breve analisi di ciò che sottintende il dispositivo. Nella nostra società a capitalismo avanzato, ossessionata dal lavoro e dall’attivismo a ogni costo, “avere tanto tempo libero” equivale a oziare, non fare niente, starsene con le mani in mano. È, in altre parole, una moderna versione dell’accidia di teologica memoria, ossia di quella “negligenza nell’esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell’anima” che, per i cattolici, corrisponde a uno dei sette peccati capitali, mentre per i contemporanei, imbevuti di principi produttivistici che esaltano il profitto come fine ultimo della vita,… pure (con la differenza che gli altri sei – la superbia, l’avarizia, l’ira, l’invidia, la lussuria, la gola – non lo sono, anzi sono funzionali ai valori del capitalismo).
Nella nostra società, è importante “essere occupati”, “occupare il tempo”, possibilmente in attività remunerate con stipendi e bonifici che si chiamano “lavoro”, oppure in attività che, comunque, fanno “crescere l’economia”, come il turismo o lo shopping. Se si fa altro, se si trascorre la maggior parte del tempo in attività non remunerate che si chiamano “pensare”, “scrivere”, “dipingere”, “meditare” (a meno che, come nell’ultimo caso, tali attività non servano a recuperare le forze in vista della ripresa ossessiva del lavoro), si viene percepiti come nullafacenti, perdigiorno, sfaccendati e, forse, si suscita anche qualche sospetto (“ma perché questo non lavora?”).
Tutto cambia, naturalmente, se tali attività vengono remunerate: il denaro, nella nostra società, è la più riconosciuta attestazione del valore della nostra condotta, il certificato della nostra salute mentale e civile, la prova provata che di noi ci si può fidare.
Eppure, è proprio quando si ha tanto tempo libero che si può pensare liberamente e concepire riflessioni non necessariamente in linea con i diktat della nostra società. È proprio quando si ha tanto tempo libero… che si è liberi, e che si può osare dire e fare cose che, se non avessimo tempo libero, non potremmo dire e fare.
Tutto questo è visto come una minaccia dal benpensante, dall’integrato, dal fariseo che rispetta solo chi agisce in sintonia con ciò che desidera il “sistema”. Lavorare, occupare tutto il proprio tempo in attività imposte da altri, non avere un minuto per sé, sono forme di disciplinamento e di sedazione dell’individuo, che servono a tenerlo al suo posto: another brick in the wall, come cantavano i Pink Floyd.
L’accusa di “avere tanto tempo libero” è, allora, un avvertimento a ritornare al proprio posto, a non tralignare, a non deviare dal solco tracciato per noi dalla società, perché si rischia di dire o fare cose scomode. Ma forse, in una società dominata dal verbo del consumo e del profitto come la nostra, dire o fare cose scomode è la certificazione più valida del fatto che siamo ancora vivi.