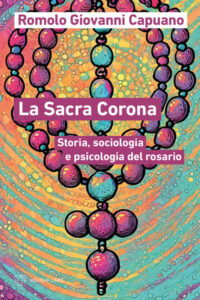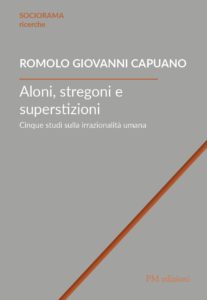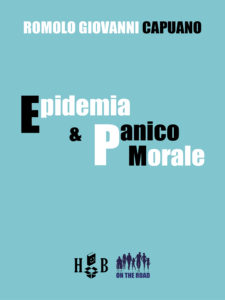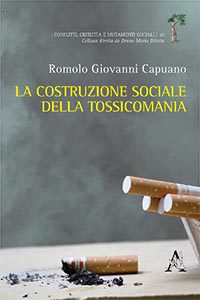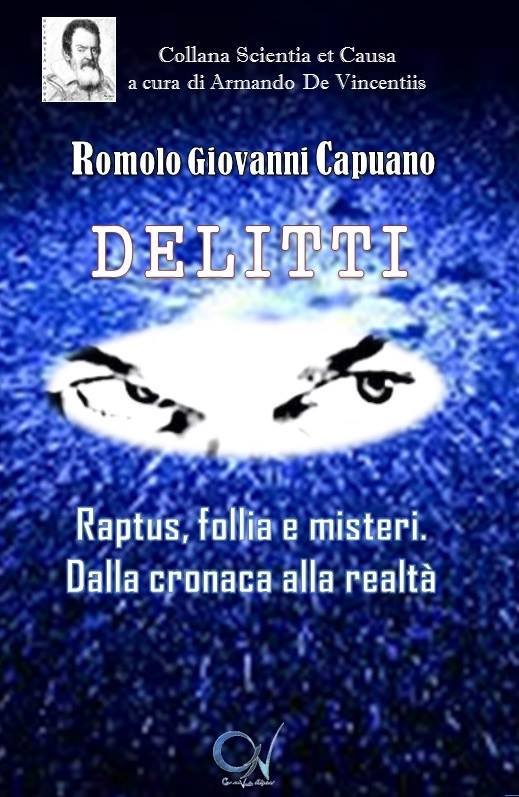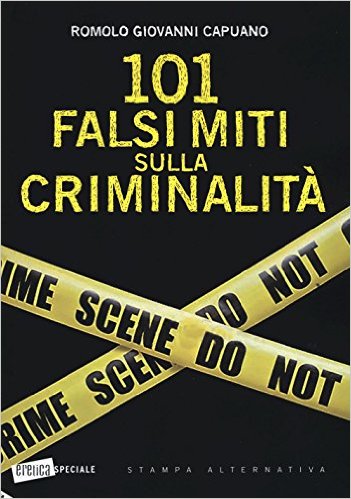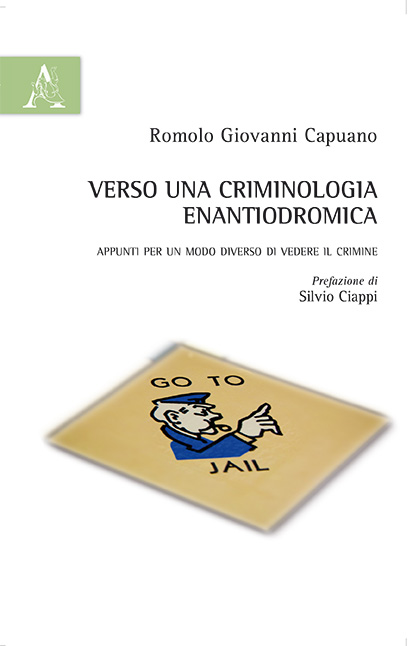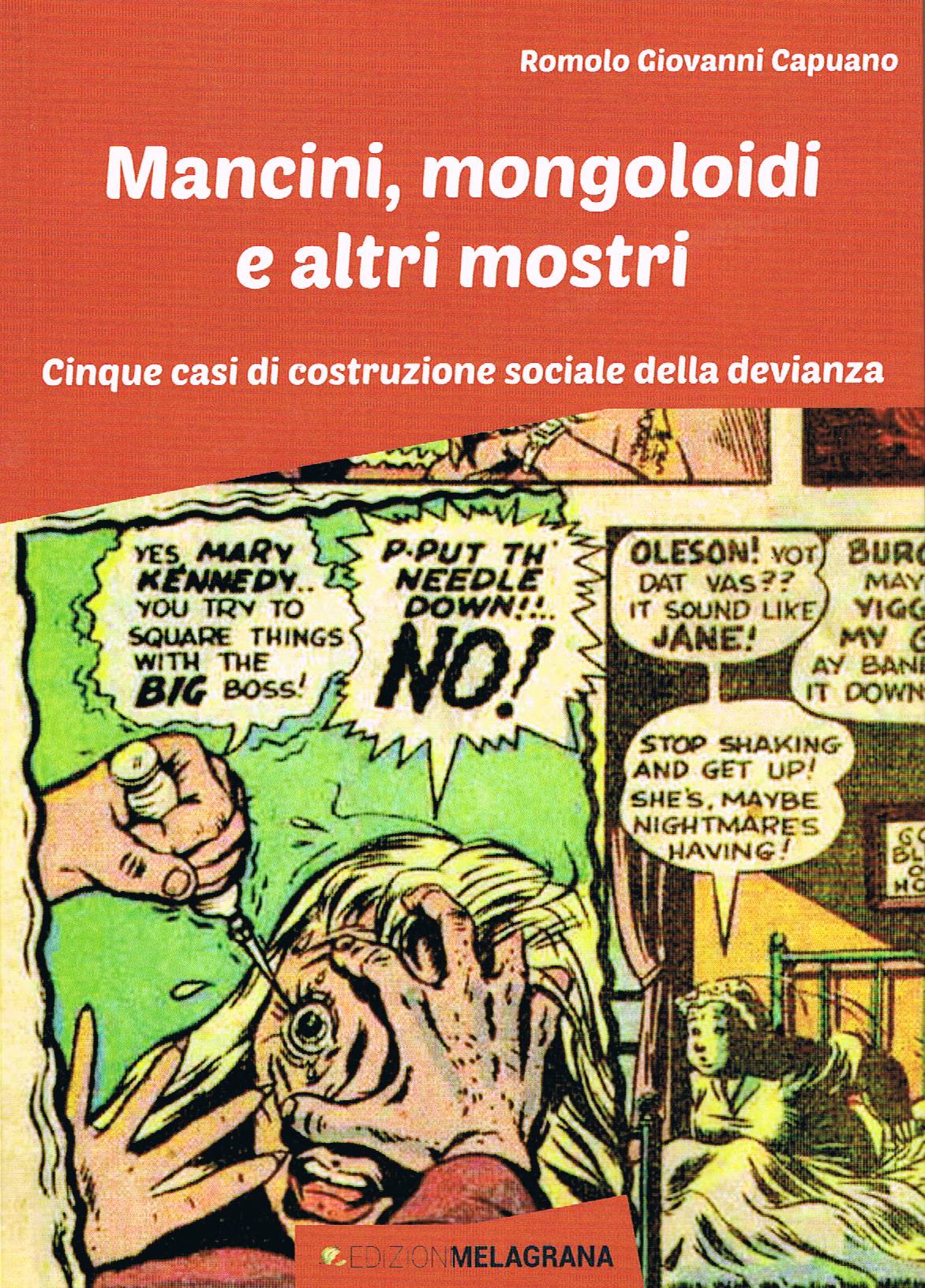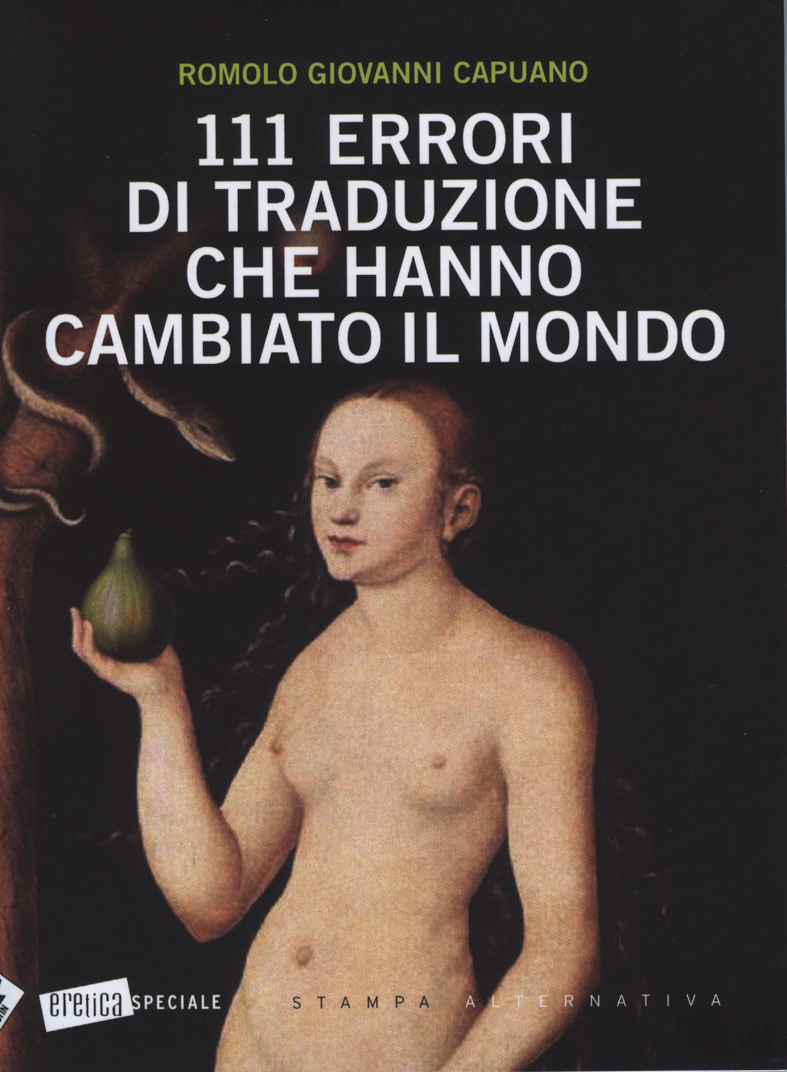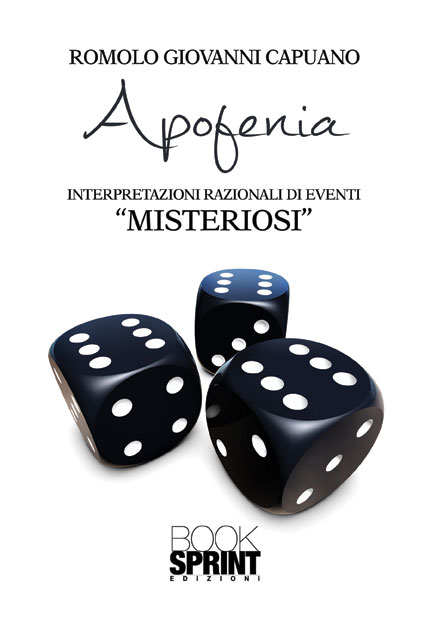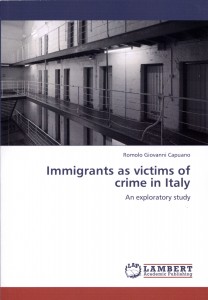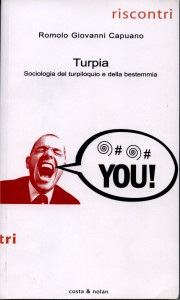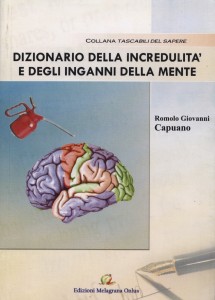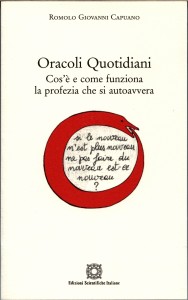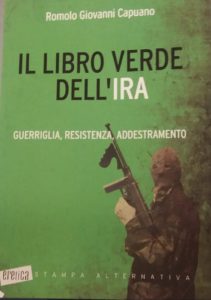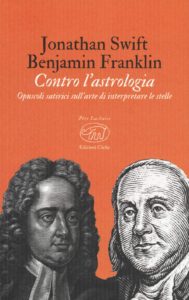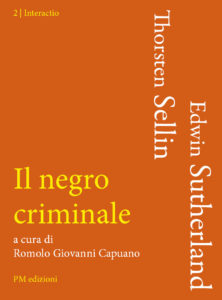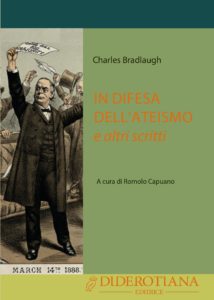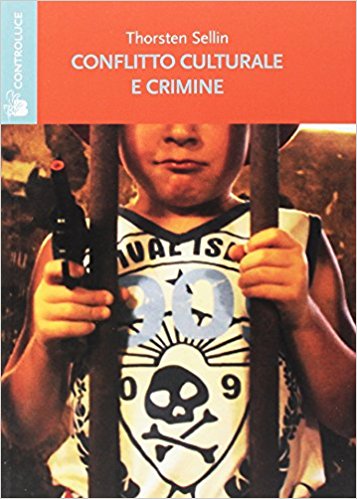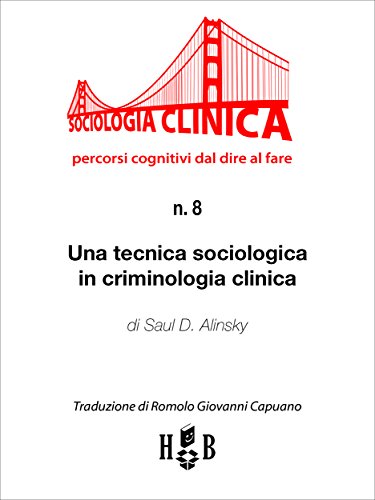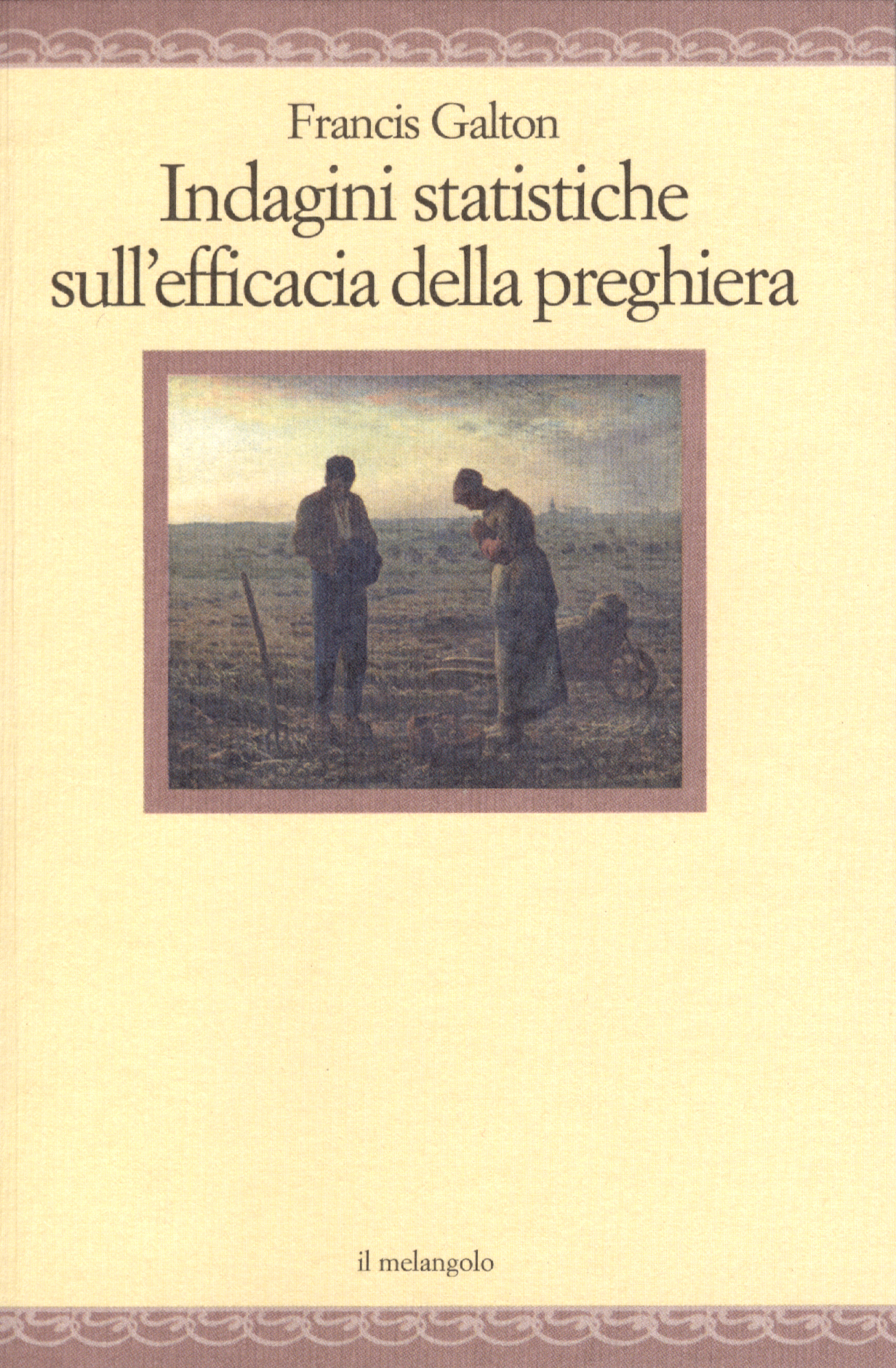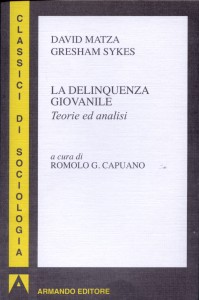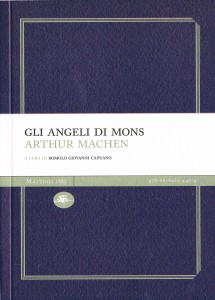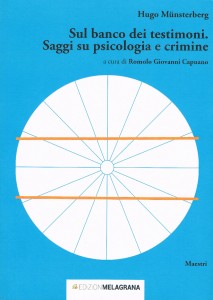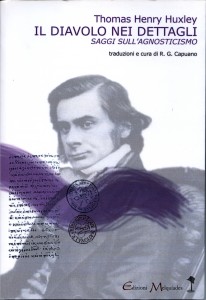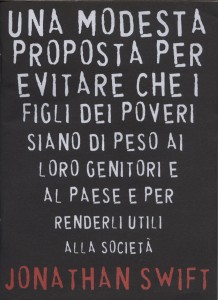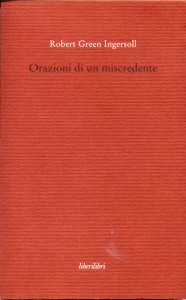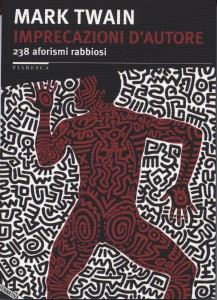Il termine greco kakoùrgos significa “malfattore”, “criminale”. Esso compare tre volte nel Vangelo di Luca, dove sono definiti kakoùrgoi coloro che furono condannati a morire sulla croce insieme a Gesù. Nell’immaginario biblico di senso comune, Gesù è diverso da loro: un innocente che muore per salvare l’umanità intera a cui capita di condividere la funesta sorte insieme a due volgari “banditi”, collocati accanto a lui per puro caso. E, in effetti, le traduzioni abituali di Luca 23, 32, versetto che introduce al lettore i due personaggi, sembrano confermare tale estraneità:
Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati (Bibbia CEI).
Ora, altri due, malfattori, erano condotti per essere messi a morte insieme a lui (Bibbia Nuova Riveduta).
Or venivano condotti con lui anche due malfattori per essere messi a morte (Bibbia Nuova Diodati).
Ora altri due, malfattori, erano condotti con lui per essere messi a morte (Bibbia Riveduta 2020).
I due malfattori, dunque, sarebbero stati altra cosa rispetto a Gesù: comparse casuali sul palcoscenico del più grande dramma religioso della storia.
Il problema è che, se traduciamo Luca 23, 32 letteralmente dal greco, la frase diventa:
Venivano condotti dunque anche altri due malfattori insieme con lui per essere crocefissi.
In altre parole, i due personaggi crocifissi insieme a Gesù non erano gli unici malfattori. C’era un altro malfattore con loro e questi non poteva essere che Gesù stesso. Misteriosamente, però, nelle traduzioni consuete l’aggettivo “altri” sparisce o viene riformulato in modo da escludere dal novero dei malfattori Gesù.
Perché? La risposta è semplice. Perché, in questo modo, come osserva lo studioso Giambernardo Piroddi, si ottiene «il ricercato effetto di creare una netta separazione tra il primo condannato a morte e gli altri due». Tale effetto occulta il fatto che anche Gesù era un kakoùrgos, ossia un “malfattore”, un “criminale”, anzi un “rivoluzionario”, pienamente immerso in «quel grande movimento di speranza e di esaltazione nazionale chiamato messianismo» che scuoteva la società ebraica del suo tempo, come suggerisce ancora Piroddi.
Del resto, solo così è possibile intendere la sua condanna a morte sulla croce – destino non riservato a pacifici predicatori religiosi – e tanti altri episodi della sua vita narrati dai Vangeli che «raccontano in maniera molto chiara e fuori d’ogni metafora vicende di matrice eversiva occorse in precisi luoghi in una data epoca storica, che hanno avuto per protagonista un pretendente al trono d’Israele […] inviso al dominatore romano, ma non del tutto alla classe politico-sacerdotale da cui proveniva e cui era legato per lignaggio».
Le traduzioni più abituali dei Vangeli appaiono, dunque, almeno in parte, come un’opera di purificazione, tesa a offrire al lettore una immagine edulcorata, se non annacquata, di un rivoluzionario della sua epoca, trasformato in pacifico e saggio, per quanto paradossale, promotore di un messaggio puramente spirituale e del tutto avulso dalla realtà conflittuale a lui contemporanea.
L’utilizzo di parabole e di codici comunicativi bisognosi di interpretazione hanno lo scopo di occultare questa fondamentale “verità”. Solo così è sopravvissuta per secoli la figura di Gesù che, se svelata interamente, avrebbe corso il rischio di essere rimossa dalla memoria o spinta in ultimo piano, come è accaduto a tanti ribelli e rivoluzionari del tempo di cui sappiamo solo grazie a fonti storiche note quasi esclusivamente agli addetti ai lavori.
Fonte:
Piroddi, G., 2023, Gesù non amava i nemici. Quello che i vangeli greci raccontano e le traduzioni censurano, Edizioni Clandestine, Milano, pp. 223-227, 262.