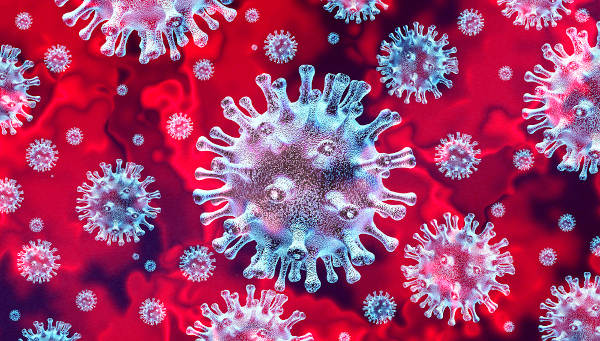
È paradossale come, nella nostra società senescente, destinata nell’immediato futuro a essere gerontocratica e gerontofila per necessità, demograficamente votata al trionfo della terza e quarta età, che presto chiameremo “prime età”, l’ageismo sia ancora sostanzialmente misconosciuto, pur facendo continuamente irruzione tra gli incavi della contemporaneità. Prendiamo la faccenda del coronavirus, ad esempio. È noto che i bollettini quotidiani che aggiornano pornograficamente il numero delle persone morte per Covid-19, spesso in barba a quello che, fino a pochi giorni fa, era il feticcio della privacy e dei “dati sensibili”, quasi che, di fronte all’emergenza, ogni sensibilità debba venir meno, si affrettano ad aggiungere che i deceduti sono tutti anziani e affetti da altre patologie. Questa impazienza – è stato notato – finisce con il sortire una funzione (che nessuno mai ammetterà direttamente) di rassicurazione apotropaica. In altre parole, il messaggio che arriva è di questo tenore:
Non preoccupatevi! La parte sana, funzionante e produttiva della società non verrà ghermita dai fetidi artigli del virus. Voi che siete giovani (o almeno non vecchi), lavorate e vi divertite potete dormire sogni tranquilli. Solo “quegli altri”, i vecchi, saranno sacrificati al moloch del virus. Solo loro pagheranno il prezzo di questo morbo imprevisto.
Questo messaggio tracima dai listini medici propagandati dai media e si insinua nei discorsi quotidiani della gente, quasi che i vecchi fossero davvero “altri” e la vecchiaia non fosse una fase della vita di ognuno di noi. Si realizza, dunque, quello straordinario processo per cui diventiamo estranei a noi stessi e proiettiamo all’esterno ciò che diventeremo, reificandolo, traducendolo in un corpo estraneo.
È questa l’essenza dell’ageismo, termine inventato dal medico, gerontologo e psichiatra americano Robert Neil Butler (1927–2010), nel 1969, per descrivere il «pregiudizio di un gruppo di età nei confronti di altri gruppi di età», ma che, nella letteratura del settore, viene adoperato soprattutto per indicare i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti di chi è vecchio in quanto vecchio.
Sono molti gli esempi, spesso non riconosciuti, di ageismo. È noto a chiunque abbia avuto una persona cara di età avanzata in ospedale, come gli anziani ricevano meno attenzioni e cure in caso di incidenti o malattie perché “tanto sono vecchi”. Non altrettanto noto è che, per lo stesso motivo, meno fondi sono stanziati per la ricerca geriatrica. Riflettiamo poi sull’attribuzione di incompetenza lavorativa che “costringe” chi è vecchio ad andare in pensione e non occuparsi di niente che sia produttivo per la società, anche se poi ai vecchi sono assegnati importanti quanto misconosciuti compiti di welfare sociale (ad esempio, l’accudimento dei nipoti). Si pensi ancora all’attribuzione di significati morali negativi al vecchio o vecchia che intenda continuare la propria vita sessuale, soprattutto se si sente attratto/attratta da uomini/donne molto più giovani (lo stereotipo del “vecchio porco”). Si potrebbe continuare.
A distanza di quasi 50 anni dalla introduzione del termine, di ageismo si continua a parlare poco, come se le nostre società non tendessero a invecchiare sempre più; come se i vecchi non stessero diventando la fascia demografica più importante del pianeta. E quando parliamo di vecchi, come nel caso del coronavirus, lo facciamo per usarli come capri espiatori e amuleti scacciapensieri delle nostre fobie nei confronti di virus sconosciuti.
È importante renderci conto che ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di ageismo nella nostra società. Imparare a riconoscerlo in quanto tale sarebbe già un grande passo avanti.
Ricordo che qui è possibile trovare la mia traduzione, munita di una corposa introduzione, del testo di Butler – Age-ism: Another Form of Bigotry – che ha introdotto nelle scienze sociali il termine ageismo.
Leggiamolo per acquisire consapevolezza di ciò che la società fa ai vecchi e a ognuno di noi.









































