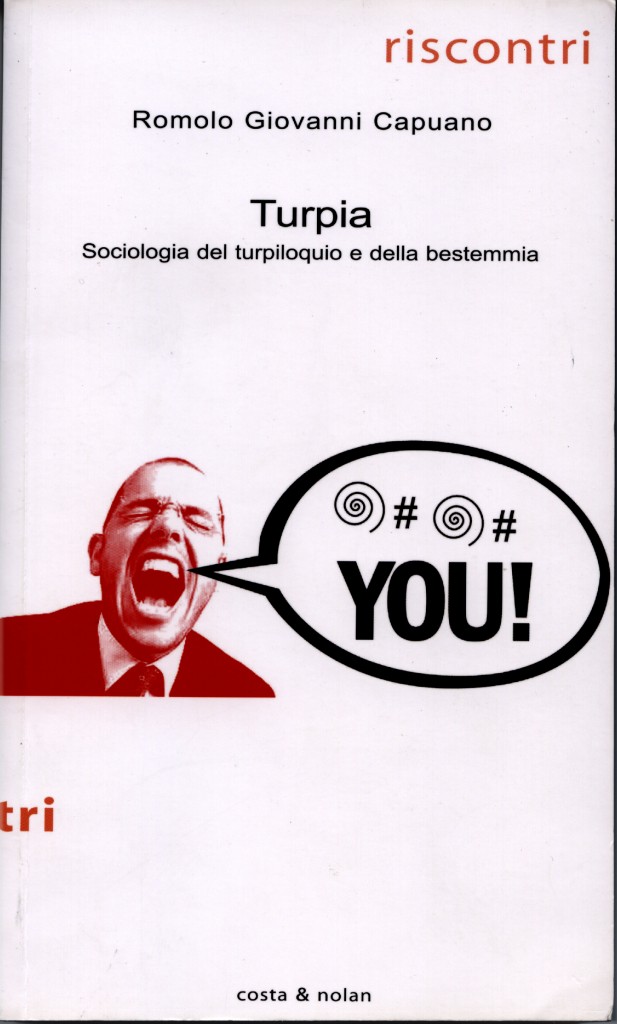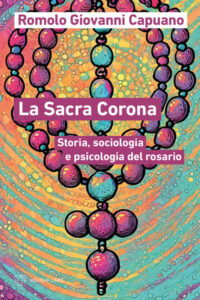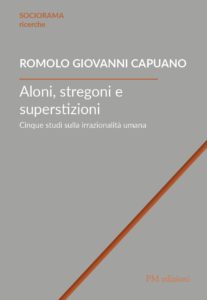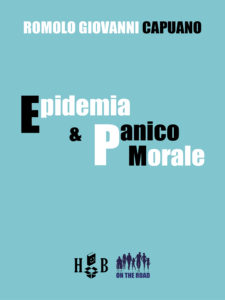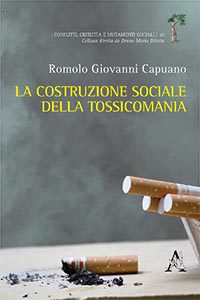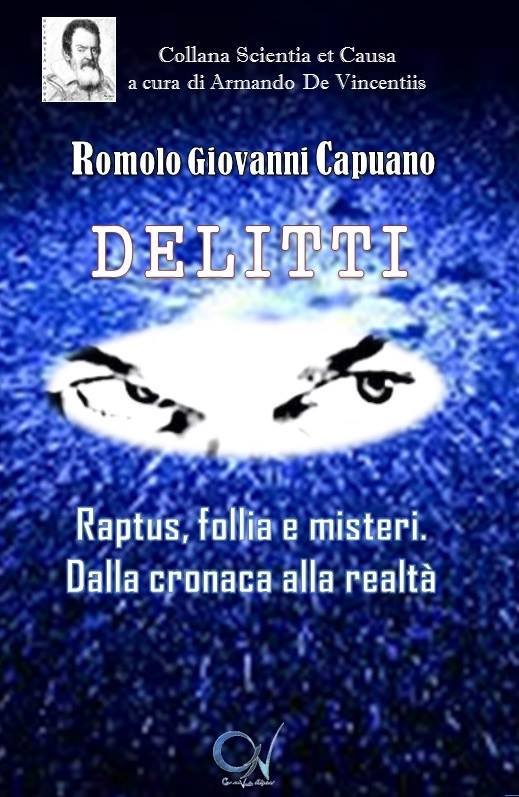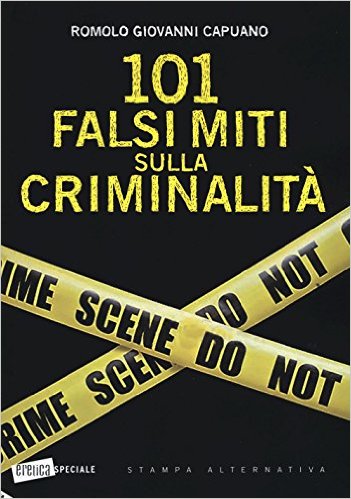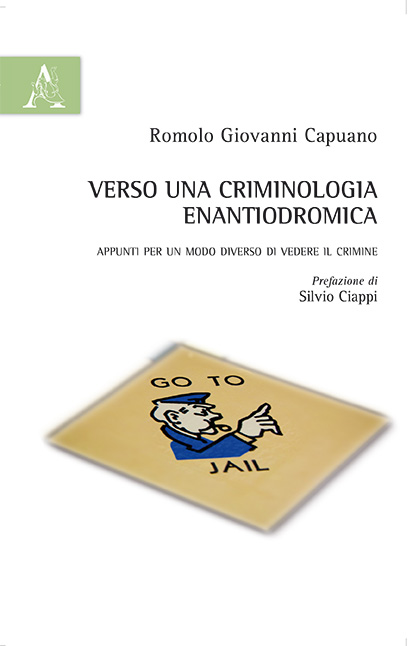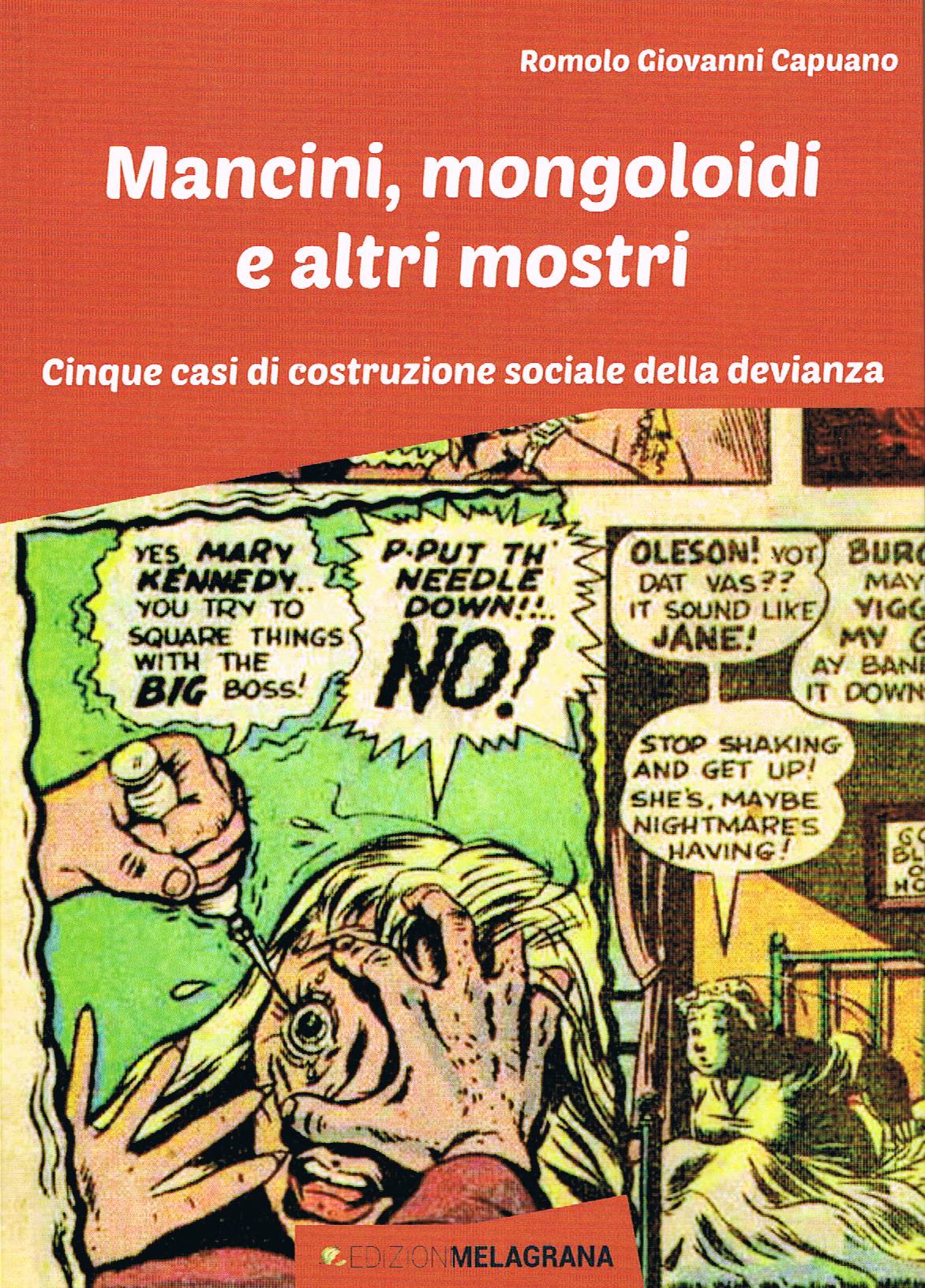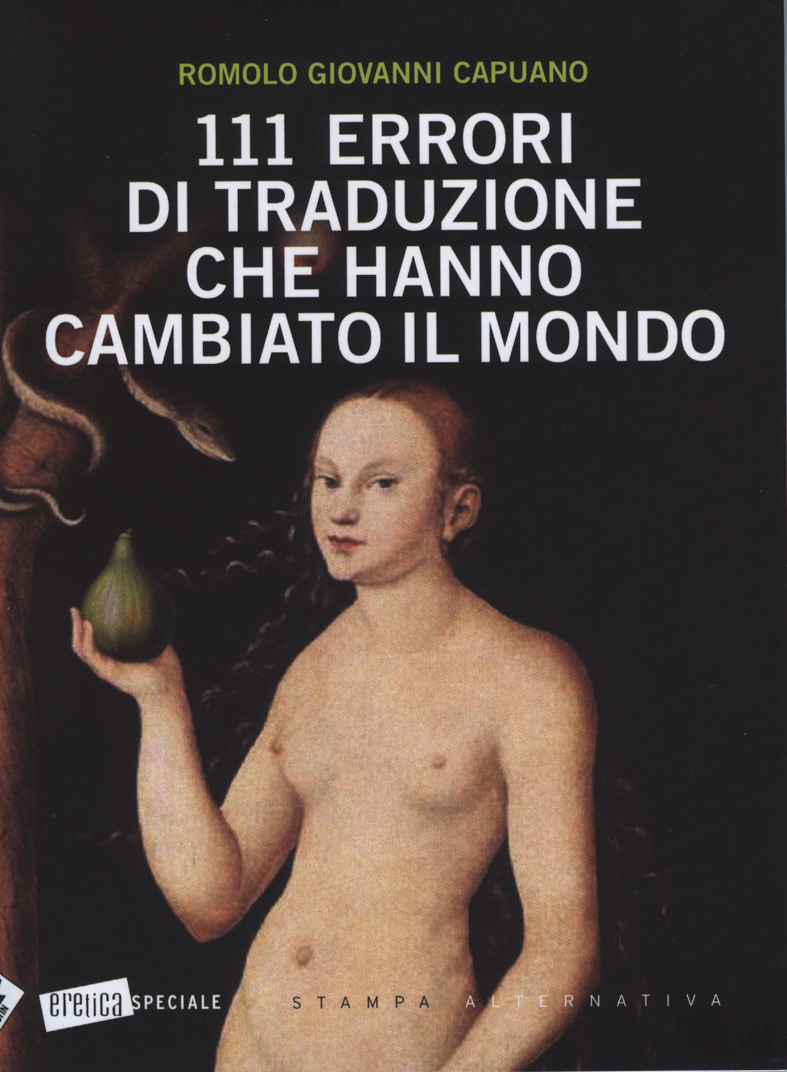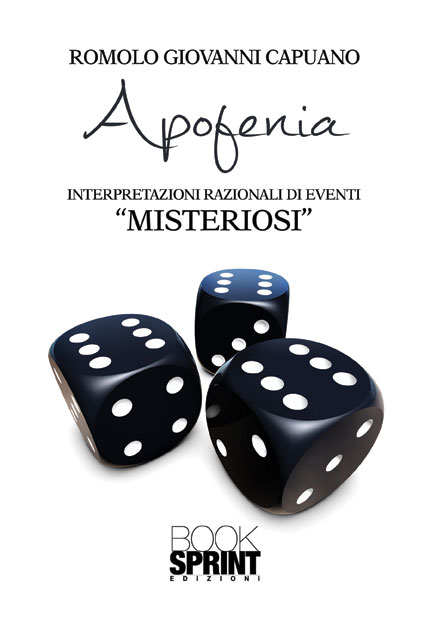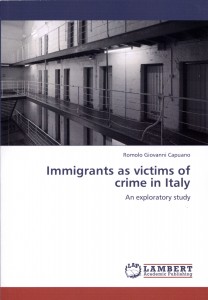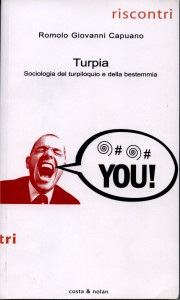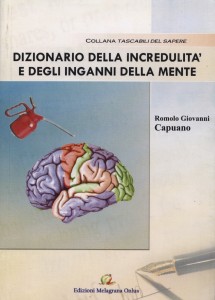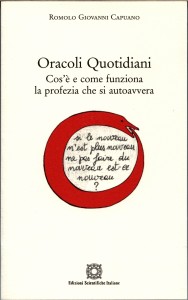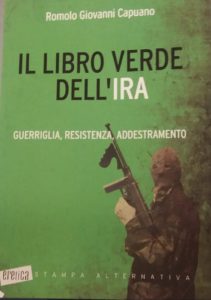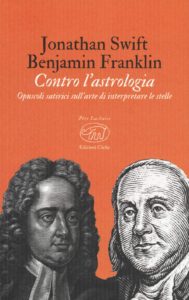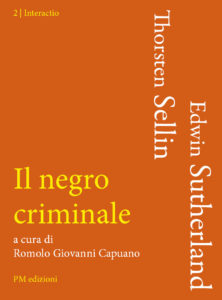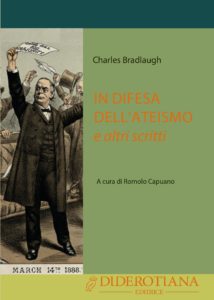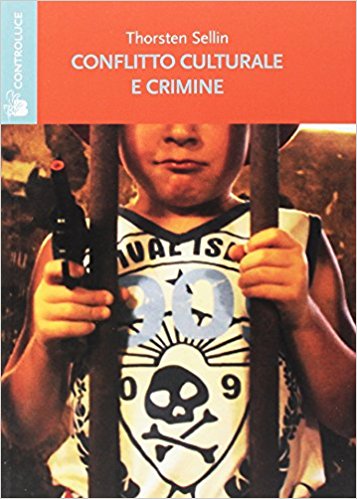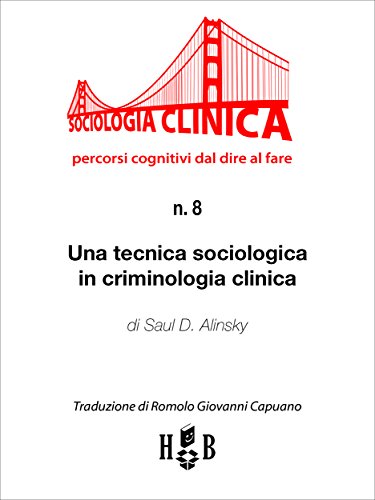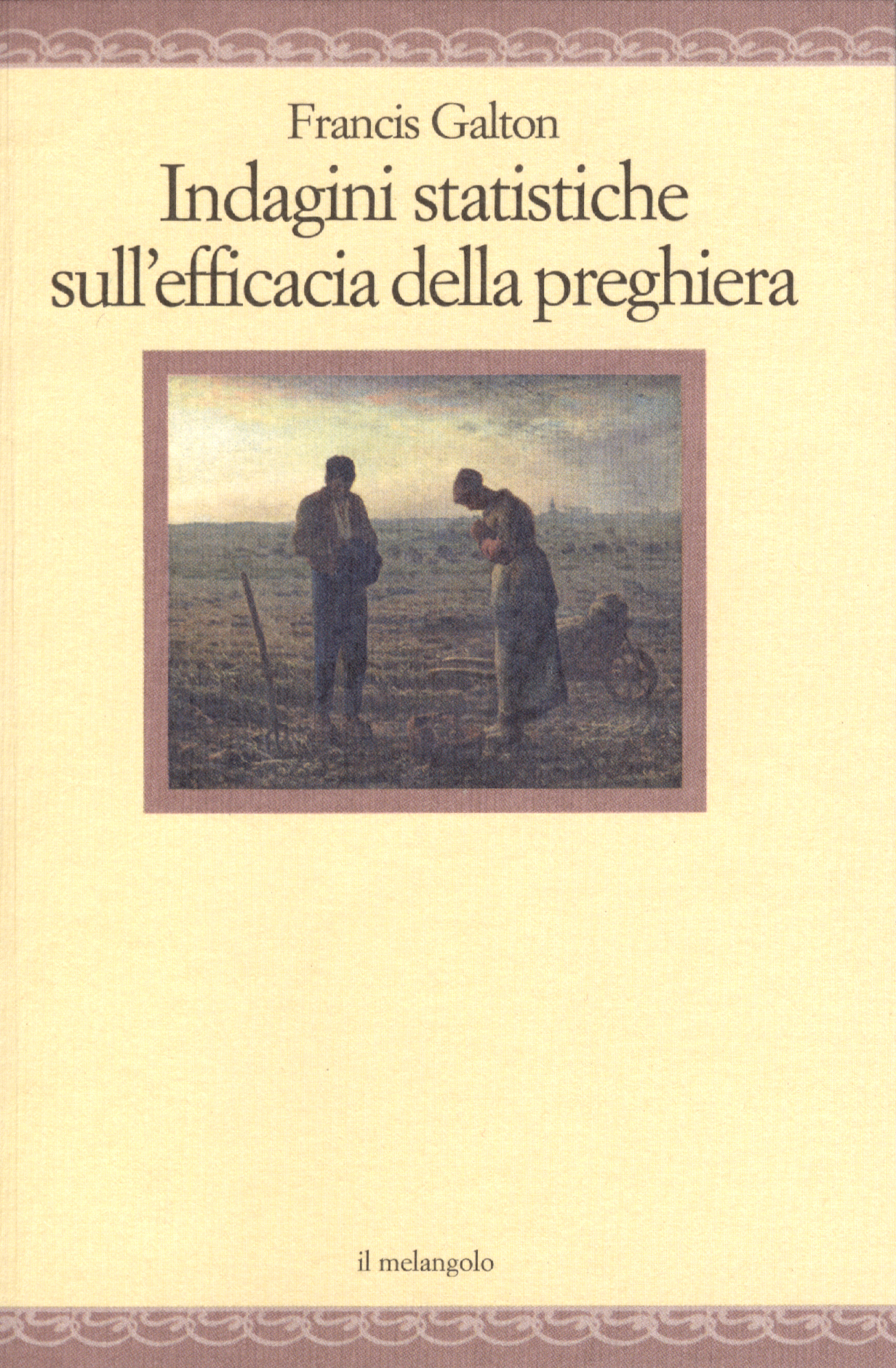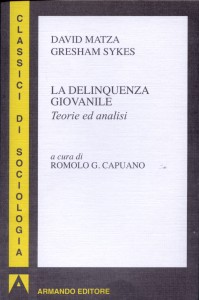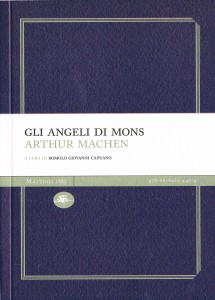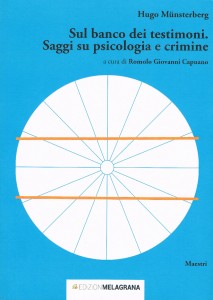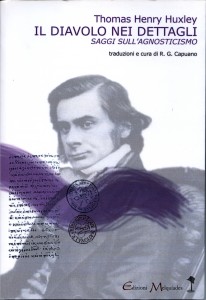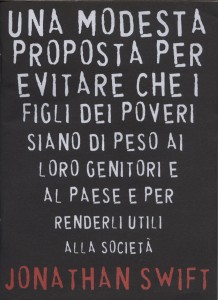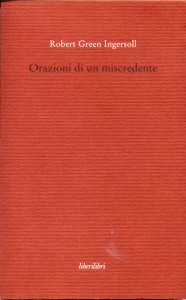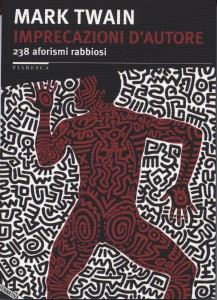Che cos’era il turpiloquio al tempo dei Promessi sposi? Che idea aveva delle parolacce e delle bestemmie Manzoni? Un’idea possiamo farcela leggendo il seguente brano di Fermo e Lucia, in cui lo scrittore milanese presenta la personalità di Padre Cristoforo:
Era a quei tempi comunissima a tutte le classi di persone l’usanza d’infiorare il discorso di quelle parole delle quali quando si vogliono stampare non si pone che l’iniziale con alcuni puntini, di quelle parole che esprimono o ciò che vi ha di più sozzo o ciò che vi ha di più riverito, di quelle parole le quali quando scappano ad un signorino nella puerizia, fanno fare viso dell’arme alla mamma, e la fanno sclamare: «ohibò! dov’hai tu inteso questo: nella via o dai servitori certamente» (e l’avrà inteso dal signor padre) di quelle parole che non sono sconosciute nelle sale fastose, e che formano la terza parte dei colloqui del popolo, al quale dicono alcuni sapienti che converrebbe abbandonarle; ma questi sapienti non dicono bene, perché comunque gli uomini sieno classificati, non vi ha alcuna classe d’uomini alla quale convenga ciò che è turpe. Quest’uso era adunque comunissimo in allora, e chi ne vuol la prova dia una occhiata alle leggi che bestemmiavano pene atroci per impedir la bestemmia, guardi alla cura che i vescovi prendevano per togliere questa vergogna dal clero stesso. Il signor Ludovico aveva fatto un tale uso di queste frasi che la lingua del Padre Cristoforo durava fatica a rimandarle tutte le volte che si presentavano, cioè ad ogni primo impeto di passione di qualunque genere; ma il Padre Cristoforo faceva stare la sua lingua. Solamente in certi casi rari, nei quali la passione era tanto viva che quasi quasi Cristoforo tornava per un momento Ludovico, veniva ad un componimento. Si proferivano le parole, ma trasformate: ad alcune consonanti radicali n’erano sostituite altre che toglievano il senso ordinario alla parola, e lasciavano soltanto travedere una lontana intenzione, quasi un bisogno di proferirla. Così mutato, trasformato, temperato era l’animo, in modo però che riteneva alquanto dell’antica sua natura.
Il brano esprime una serie di considerazioni sociologiche sul turpiloquio.
Innanzitutto, il Manzoni conferma che, allora come oggi, parolacce e bestemmie erano comuni “a tutte le classi” sociali, quindi tanto al popolino quanto all’alta borghesia, e che l’idea che gli adolescenti borghesi apprendessero le “male parole” dal volgo – invece che dal “signor padre” – era del tutto errata. Non esistevano labbra pure per nascita. Il vezzo di imprecare non era appannaggio di nessuno in particolare. Tutti reclamavano questo privilegio.
In secondo luogo, proprio come fanno i sociologi oggi, Manzoni ricava l’idea della diffusione interclassista del turpiloquio dalla severità delle leggi che punivano questo comportamento e dall’attenzione che i vescovi dedicavano al fenomeno per ridurlo tra le file del clero. Tanta severità non sarebbe comprensibile se parolacce e bestemmie fossero state comportamenti marginali.
In terzo luogo, il turpiloquio è ricondotto alla urgente pressione di stati passionali che, talvolta, si imponevano anche a religiosi come Padre Cristoforo, il quale era costretto a “trasformare” le parole più atroci tramite meccanismi di alterazione eufemizzante che attenuavano l’impatto verbale, lasciando comunque intravedere il senso dell’espressione. Questi meccanismi sono, come è noto ai linguisti, alla base della creazione di tante parole e locuzioni “alternative” oggi molto comuni. Si pensi, per fare un solo esempio, a “mannaggia” che eufemizza la maledizione, rendendola più accettabile.
La pagina di Fermo e Lucia appena riportata fu completamente trasformata nei Promessi Sposi, perdendo molto della sua verve sociologica:
Il suo linguaggio era abitualmente umile e posato; ma, quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta, l’uomo s’animava, a un tratto, dell’impeto antico, che, secondato e modificato da un’enfasi solenne, venutagli dall’uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno, come l’aspetto, annunziava una lunga guerra, tra un’indole focosa, risentita, e una volontà opposta, abitualmente vittoriosa, sempre all’erta, e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratello ed amico, che lo conosceva bene, l’aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale, che alcuni, anche ben educati, pronunziano, quando la passione trabocca, smozzicate, con qualche lettera mutata; parole che, in quel travisamento, fanno però ricordare della loro energia primitiva.
Rimane, comunque, l’idea che il turpiloquio sia legato a una “energia primitiva” che preme per traboccare e che l’educazione chiede di tenere a freno per non apparire come membri non competenti della società.
Manzoni non sospettava neppure che, nella contemporaneità, il turpiloquio sarebbe stato percepito positivamente come indicatore di autenticità e credibilità, come è evidente in politica e nella televisione-realtà. Certo, sono trascorsi oltre 150 anni dalla morte dello scrittore, ma quante cose sono cambiate da allora!
Per chi volesse approfondire la sociologia del turpiloquio rimando al mio Turpia. Sociologia del turpiloquio e della bestemmia.